DAVID YALLOP in NOME DI DIO La Morte Di Papa Luciani
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Advocate - June 30, 1960 Catholic Church
Seton Hall University eRepository @ Seton Hall The aC tholic Advocate Archives and Special Collections 6-30-1960 The Advocate - June 30, 1960 Catholic Church Follow this and additional works at: https://scholarship.shu.edu/catholic-advocate Part of the Catholic Studies Commons, and the Missions and World Christianity Commons Recommended Citation Catholic Church, "The Advocate - June 30, 1960" (1960). The Catholic Advocate. 142. https://scholarship.shu.edu/catholic-advocate/142 Cuban Exile The Advocate Work Official Publication of the Groups Archdiocese of Newark. N. and J., Diocese of Paterson. N. J. VoL No. 9, 27 THURSDAY, JUNE 1960 30, PRICE: TEN CENTS For Change Charges Catholic Families NCWC News Service Three groups of exiled Cuban leaders have issued Don 't statements accusing the Castro of Act Catholic government setting up a Always communist in Cuba regime and attacking religion. SAN In ANTONIO, Tex. Catholic Miami, a Cuban Christian Democratic families too often development projects. Movement in reflect the behavior standards Exile was of their non-Catholic organized. Earlier in June the an- neigh- HIS STATISTICS movement on bors, rather than reflecting the teachings of the early mar- nounced that it had suspended its Church, were borne in riages out a survey activities in Cuba because Economic Msgr. Irving A. Deßlanc charged here. taken St. “only improvement was by Mary’s University the Communist here Party may carry promised, “but the government Msgr. Deßlanc, director of the NCWC among 14,552 Catholic teen- Family Life out fully and its unimpeded prop- with arbitrary enforcements and made the accusation in agers. of the ex- Bureau, Two-thirds boys aganda and The state- activity.” violence ruined the an article for the Na- pected to be engaged demagogical prepared indicates that are by age 20 or ment said the will we losing 40% group work bases of tional Catholic 21, while the production, causing a fi- Life Con- of the children dominant for for Family from a mixed age a free, democratic and Chris- nancial vention here. -

The Murder of Pope John Paul I
p The Murder of Pope John Paul I BY VANCE FERRELL Pilgrims Books PB–907 The Murder of Pope John Paul I by Vance Ferrell Published by Pilgrims Books Beersheba Springs, TN 37305 USA Printed in the United States of America Cover and Text Copyright © 1999 by Pilgrims Books In Florence, when Cardinal Benelli came out of his room at 9 a.m., he was surrounded by reporters. Tears flooding from his eyes, he said, “The Church has lost the right man for the right moment. We are very distressed. We are left frightened.” When Pope Paul VI died, little emotion had been expressed. But when John Paul I died, the entire city was up in arms. Men and women wept openly everywhere. When his body was shown, people passing it were heard to shout, “Who has done this to you? Who has murdered you?” Within two days, the public and the press were loudly demanding an autopsy. But the Vatican was determined that no autopsy be performed, for that might have revealed some- thing new about the cause of death. FOR ADDITIONAL COPIES: One copy - $3.00, plus $1.50 p&h / Two copies - $5.50 each, plus $2.00 p&h Ten Copies - $5.25 each, plus $3.00 p&h In Tennessee, add 8.25% of cost of books / Foreign, add 20% of cost of books 3 Contents 1 - Birth and Youth 5 2 - Priest and Bishop 8 3 - Luciani Discovers Vatican Bank 13 4 - The Conclave 21 5 - A New Pope 26 6 - The Vatican Financiers 29 7 - Investments by the Holy Day 32 8 - The Thirty-three Days Begin 41 9 - The Last Day 51 10 - How Did it Happen? 56 11 - The Aftermath 61 Appendix: Chronology of the Popes 64 4 The Murder of -

David Yallop En Nombre De Dios
David Yallop En Nombre de Dios Primera edición: SeptíemBrelie 1984 Segunda edición: Abril de 1985 Tercera edición: Julio de 1985 Cuarta edición: Febrero de 1986 Quinta edición: Junio de 1986 Sexta edición: Septiembre de 1986. Titulo original: IN GOD'S ÑAME Traducción: Sebastián Bel Spino Poetic Products Ltd. (Londres), 1984 Editorial La Oveja Negra Ltda., 1985 Carrera 14 No. 79-17 Bogotá - Colombia Diseño: Hernando Vergara ISBN 84-8280-660-2 Impreso y encuadernado por: Editorial Printer Colombiana Ltda. Impreso en Colombia Printed in Colombia Sobre el autor El primer libro de David Yallop, titulado Para alentar a los otros, obligo al Gobierno británico a reabrir el caso de asesinato Craig/Bent-ley, que se había considerado resuelto y cerrado veinte años antes. El libro provocó un tumultuoso debate en la Cámara de los Lores, durante el cual lord Arran manifestó: Una de dos: o David Yallop es e! peor bribón que se ha escapado de la horca en toda la historia británica o en relación con este caso de asesinato sólo ha dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. El libro, sumado a un documental escenificado para televisión con libreto del autor, terminó por convencer a mucha gente, desde el anterior lord canciller de Gran Bretaña, lord Gardiner, pasando por lord Arran y lord Goodman, hasta escritores como Arthur Koestler. Todos coincidieron en opinar que había ocurrido una gravísima injusticia. El segundo libro de Yallop, El día en que cesaron las risas, fue ampliamente aclamado a ambos lados del Atlántico y está considerado como la biografía definitiva y la rehabilitación póstuma del famoso actor de cine mudo Roscoe (Fatty) Arbuckle. -

Rafael Rodriguez Guillen
2 Monsenor Rafael Rodriguez Guillen INDEX PG INTRODUCTION TO THE VATICAN'S POWER POLITICAL STATE ...............................................................4 VATICANISTS AND CURATES EXPOSE THE VATICAN........................................................................7 THE STATE OF NATIONAL CATHOLICISM AND ITS ORGANIZATIONS .........................................................10 NATIONAL CATHOLICISM CARET NOT FOR SOULS.. 13 MARCINKUS AND VAGNOZZI: THE VATICAN'S POWERFUL BANKERS. ......................................................16 THE COMMITTEE APSA: CONSULTANTS TO THE VATICAN'S FINANCES ..............................................19 THE CANONICAL RIGHT AND THE ADMINISTRATION OF GOODS ............................................................................22 THE STATISTICAL OFFICES OR CONGREGATIONS, THEIR FINANCES................................................................ 25 THE RICHES OF VATICAN STATE OR NATIONAL CATHOLICISM................................................28 THE MULTINATIONAL ENTERPRISE OF THE VATICAN'S CATHOLIC STATE......................................... 31 THE VATICAN BANK SCANDAL REAPPEARS IN VENEZUELA....................................................................34 ORIGINS OF THE CHURCH'S ECONOMIC POWER IN MEXICO ...........................................................................40 POWER CLERICAL BUSINESS IN TIJUANA ................... 43 POWER ECONOMIC MIGHT IN MEXICO......................... 46 ECONOMICAL POWER WITH THE CATHOLIC CATECHISM.................................................... -
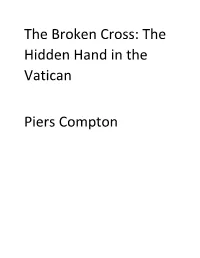
The Broken Cross: the Hidden Hand in the Vatican Piers Compton
The Broken Cross: The Hidden Hand in the Vatican Piers Compton Part One What remains when Rome perishes? When Rome falls – the world. Virgil Byron. Its claims were monstrous. They passed beyond human reckoning. For it claimed to be the one divine and authoritative voice on earth; and it taught, gave judgment, and asserted, always in the same valid tone, confident that its message would outlive the transitory phenomena of doubt, change, and contradiction. It stood secure, an edifice of truth behind the ramparts of truth which defied the many and various attacks launched by its enemies. For it claimed a strength that was not of itself, a life-force and vigour imparted by a power that could not be found elsewhere; and because it could not be likened to any earthly thing it provoked fear, bewilderment, mockery, even hate. But through the centuries it never wavered; never abandoned one item of its stupendous inheritance; never allowed the smallest rent to appear in its much derided mantle of intolerance. It inspired devotion and admiration even in those who scorned its mental discipline. It rose above conjecture, likelihood, probability; for the Word by which it had been founded was also its guarantee of permanence. It provided the one answer to the immemorial question – what is truth? One of our essayists told1, as many of our schoolboys used to know, of its place in history; how it saw the beginning, as it was likely to see the end, of our worldly systems; and how, in time to come, a broken arch of London Bridge might furnish a foothold from which a traveller ‘could sketch the ruins of St. -

St. Peter's Pietà
EDIZIONI MUSEI VATICANI St. Peter’s Pietà History and Restoration 40 Years Later Edited by Guy Devreux On the cover: Vatican Basilica, Saint Peter’s Treasury Museum, plaster cast of Michelangelo’s Pietà (photo M. Falcioni) Editorial Directors Antonio Paolucci, Arnold Nesselrath, Paolo Nicolini Edited by Guy Devreux Texts P. Badaloni, G. Devreux, R. Di Pinto, V. Federici, A. Felice, N. Gabrielli, F. Morresi, U. Santamaria, P. Zander Editorial Coordinator Federico Di Cesare Editorial Board Cristina D’Andrea (general supervisor) and Stefania Botti with the collaboration of Sabrina Moscato and Simona Tarantino Layout and Design Giulia Angelini Print Vatican Printing Press ISBN 978-88-8271-339-3 © Vatican Museums Edition 2014 Vatican City www.museivaticani.va Rights of translation, electronic storage, reproduction and total or partial adaptation, with any means (including microfi lms and photocopies), are reserved, as applied to all countries. Michelangelo’s Pieta: A collaborative restoration Nazzareno Gabrielli Of all the restoration team members1, who are shown in the pic- ture below and with whom I worked on the restoration of Mi- chelangelo’s Pietà, which had been savagely damaged by a de- Picture 1 ranged man of Australian origin, I am the only survivor. (picture The restoration team after 1). project completion. 1 Prof. Deoclecio Redig de Campos, General Director of the Vatican Museums; Engineer Francesco Vacchini, Manager of the Fabbrica di San Pietro; Dr. Vittorio Federici, Manager of the Offi ce for Scientifi c Research of the Vatican Museums; Dr. Nazareno Gabrielli, Deputy Inspector of the Offi ce for Scientifi c Research; Ulderico Grispigni, Head Restorer of the Marble Restoration Lab; Francesco Dati, Head Restorer of the Ceramics and Bronze Restoration Lab; Giuseppe Morresi, Head restorer of the Plastic Materials and Artistic Reproductions Lab. -

Redalyc.L´Archivio Del Concilio Vaticano II: Storia E Sviluppo
Anuario de Historia de la Iglesia ISSN: 1133-0104 [email protected] Universidad de Navarra España Doria, Piero L´Archivio del Concilio Vaticano II: Storia e Sviluppo Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 21, 2012, pp. 135-155 Universidad de Navarra Pamplona, España Disponibile in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35523355007 Come citare l'articolo Numero completo Sistema d'Informazione Scientifica Altro articolo Rete di Riviste Scientifiche dell'America Latina, i Caraibi, la Spagna e il Portogallo Home di rivista in redalyc.org Progetto accademico senza scopo di lucro, sviluppato sotto l'open acces initiative L’Archivio del Concilio Vaticano II: Storia e Sviluppo* The Archives of Vatican II: history and development Piero DORIA Oficial del Archivo Secreto Vaticano. Archivista del archivo del Concilio Vaticano II. Miembro de la redacción de «CVII», revista del Centro de Estudios sobre el Concilio Vaticano II del Laterano. Redactor jefe de la revista «Notes et documents» del Instituto Internacional Jacques Maritain de Roma [email protected] Abstract: The article studies the actions which, after Resumen: El artículo estudia los hechos que, después the Conciliar Assembly, brought about the reunifica- de la Asamblea Conciliar, han llevado a la reunificación tion in one place only of the archives of each of the en una única sede de los archivos de cada una de las Commissions and Secretariats (1966-1967), as well as Comisiones y Secretariados (1966-1967), a la institu- the institution of the Archives of Vatican ii, and their ción de una Oficina del Archivo del Concilio Vaticano II reordering and final transference to the Vatican Secret (1967), y a su reordenamiento y transferencia final en el Archives (2000), where the long task of inventory work, Archivo Secreto Vaticano (2000), donde se ha realizado still in progress, has been performed on the enormous un largo trabajo de inventariado, aún en marcha, de la volume of documentation. -

Il Pontificio Seminario Lombardo Nel Centenario Della Fondazione
Il Pontificio Seminario Lombardo nel centenario della fondazione Roma 1965 Il Santo Padre S.S. Paolo VI benedice la nuova sede del Pontificio Seminario Lombardo in piazza S. Maria Maggiore, 5 il giorno 11 novembre 1965 Il Pontificio. Seminario Lombardo nel centenario della fondazione Roma 1965 PRIMO REVOL VTO SAECVLO A PONTIFICIO CONDITO SEMINARIO SS. AMBROSII ET CAROLl LONGOBARDORVM PAVLVS PP. VI QUONDAM ALVMNVS SOLLEMNI RlTV NOVAS DEDICAT AEDES DENVO PROPE LlBERIANAM BASILlCAM EXSTRVCTAS IN SOLO QVOD PIVS Xl PONT. MAX. ITEM HVIVS SACRI EPHEBEI SODALlS PRO SUA MVNIFICENTIA DONARAT CVNCTIS LONGOBARDORVM REGIONIS EPISCOPIS PVRPVRATIS PATRIBVS PRAESVLlBVS AVCTORITATIBVS ADSTANTlBVS DVM CONCILlVM OECVMENICVM VATICANVM II AGITVR HOC TENVE OPVSCVLVM AMANTI STVDIO CONCINNATVM TAM FA VSTAE CELEBRITATIS CAVSA ANIMO GRATO PORRIGITVR DIE Xl MENSIS NOV. ANNO MCMLXV C. fGGH )2t ,,~,,1i.., """,' 9.4,;w, ~ L,.nJ~ ~ Q'o~~ d .. ~ ./« r~ -if..ed-e u~-tdaAt<-~'(' ~~~ (~-t.c<- ,;.f c...~EA.,..-~ ~ "~~~",,,e.~ t'-o-->-t.- -t ~~ ~ d" "'-""i'-1A ;'f.to' ~ d~ "'''7'~ fw~---,~4. <:, ~4'-~, .oLe& ,~~ ~ UL-~e .-.:l.dlc.. -lo-"/.Q t~ ..,d' c:>~~ c.a ........ -te 4~ ,.d....;{~ c..-odCo~ Ln~ ~~ f~ ~ t-0-7~ -tr~ --.t ~ -lo-l.-c ~4t..o, .d-<: '-"<-<.-<:>-1-e. -4~, ~ :.:1-<-<..- ok.' e4<f.4 ~-t.~ .d,; ~ .f'~..,~,~ d~ C/{,..'-4~, ~ <~ iidek 9-aJUd 99.0- La ricorrenza del centenario di fondazione del Seminario Lombar do è stata accomlJagnata, pcr singolare disegno della Divina Prov videnza, dalla ricostruzione della sede ne/luogo dove la generosa bontà di Pio XI l'aveva posta e l'affettuosa S'aggezza di Paolo VI ha voluto che rimanesse. -

The Annals of Unsolved Crime by Edward Jay Epstein Isbn: 9781612190488
THE ANNALS OF UNSOLVED CRIME BY EDWARD JAY EPSTEIN ISBN: 9781612190488 Available at mhpbooks.com and wherever books are sold. THE ANNALS OF UNSOLVED CRIME BY EDWARD JAY EPSTEIN MELVILLE HOUSE BROOKLYN • LONDON CONTENTS PREFACE 5 PART ONE “LONERS”: BUT WERE THEY ALONE? 1. The Assassination of President Lincoln 21 2. The Reichstag Fire 29 3. The Lindbergh Kidnapping 35 4. The Assassination of Olof Palme 43 5. The Anthrax Attack on America 47 6. The Pope’s Assassin 59 PART TWO SUICIDE, ACCIDENT, OR DISGUISED MURDER? 7. The Mayerling Incident 65 8. Who Killed God’s Banker? 69 9. The Death of Dag Hammarskjöld 97 10. The Strange Death of Marilyn Monroe 103 11. The Crash of Enrico Mattei 109 12. The Disappearance of Lin Biao 113 13. The Elimination of General Zia 117 14. The Submerged Spy 131 PART THREE COLD CASE FILE 15. Jack the Ripper 139 16. The Harry Oakes Murder 145 17. The Black Dahlia 151 18. The Pursuit of Dr. Sam Sheppard 155 19. The Killing of JonBenet Ramsey 161 20. The Zodiac 165 21. The Vanishing of Jimmy Hoffa 169 2 EDWARD JAY EPSTEIN PART FOUR CRIMES OF STATE 22. Death in Ukraine: The Case of the Headless Journalist 177 23. The Dubai Hit 189 24. The Beirut Assassination 195 25. Who Assassinated Anna Politkovskaya? 201 26. Blowing Up Bhutto 205 27. The Case of the Radioactive Corpse 209 28. The Godfather Contract 231 29. The Vanishings 237 PART FIVE SOLVED OR UNSOLVED? 30. The Oklahoma City Bombing 245 31. The O. J. -
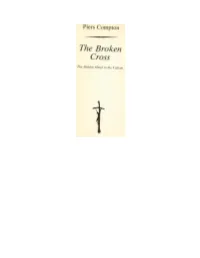
Broken Cross, The: the Hidden Hand in the Vatican
Part One What remains when Rome perishes ? When Rome falls, the world. Virgil. Byron. Its claims were monstrous. They passed beyond human reckoning. For it claimed to be the one divine and authoritative voice on earth; and it taught, gave judgment, and asserted, always in the same valid tone, confident that its message would outlive the transitory phenomena of doubt, change, and contradiction. It stood secure, an edifice of truth behind the ramparts of truth which defied the many and various attacks launched by its enemies. For it claimed a strength that was not of itself, a life-force and vigour imparted by a power that could not be found elsewhere; and because it could not be likened to any earthly thing it provoked fear, bewilderment, mockery, even hate. But through the centuries it never wavered; never abandoned one item of its stupendous inheritance; never allowed the smallest rent to appear in its much derided mantle of intolerance. It inspired devotion and admiration even in those who scorned its mental discipline. It rose above conjecture, likelihood, probability; for the Word by which it had been founded was also its guarantee of permanence. It provided the one answer to the immemorial question--what is truth? One of our essayists told,[1] as many of our schoolboys used to know, of its place in history; how it saw the beginning, as it was likely to see the end, of our worldly systems; and how, in time to come, a broken arch of London Bridge might furnish a foothold from which a traveller ‘could sketch the ruins of St. -

For T^X Ctedit Bill
lllfi^ BY RELIGIOUS NEWS SERVICE The threej with Cardinal Villot, constitute what is called a "Particular Congregation." Vatican City In accord with [prescriptions issued by i . Pope Paul VI in 1975, three cardinals have been chosen The choosing of the three by lot took place in what is by "lot to assist^ Cardinal Jean! Villot, the chamberlain of known as the "General Congregation," that is, one of the th|e Holy Roman Church, j with routine matters of entire college — or as many as are in Rome at the time. I i church administration until the third day after the start ofi the conclave to elect ajnew! pope. The conclave The General Congregation, whose main function is to opens Aug; 25. prepare for the electoral conclave, has nominated- two separate commissions] each consisting of three cardinals, The cardinal assistants arfe Narciso Jubany Arnau, to make a security check on persons allowed to enter the archbishop of ,,and|jtwo officials of the Roman conclave and to take charge of the opening and locking Curia - Cardinals Silviq p^di and Antonio Samor^ up of the conclave. In addition to cardinal electors, a nurriber of persons wijl be allowed into thb conclave, including priests to hear confessions, (two physicians, with one ojr two medical assistants, two "technicians," and "ah appropriate number of ptlher persons to take care of the needs of the conclave," ' ' Cardinal Silvio • [Three Italian cardinals are on the commission to make Oddi the security check - Paoli Bertoli, Francesco Carpino and Egldio Vagnozzi. i On the commissioh in charge of "preparation and enclosing of the conclave" are American Cardinal John J. -

Searching for the Illuminati Deep Within the Bowels Of
Searching For the Illuminati Deep Within the Bowels of the Vatican All roads lead to Piazza San Pietro when it comes to power, leadership and initiation into the devious and diabolical Illuminati. In the 1980's, the Vatican Bank Scandal brought to light the connections between the Freemasons/Illuminati, the Vatican and the mafia. Secret initiations are said to take place in the catacombs of the Vatican and was Pope John Paul I killed after 39 days in office for wanting to expose the truth about Vatican finances and the Illuminati? 16 Jan 2006 By Greg Szymanski Part I While Mass is being said in the Sistine Chapel and tourists are being shown the works of Michelangelo, deep within the bowels of the Vatican sits a large, circular room with 13 separate chambers, each leading to a distinct catacomb. When a mummified body is placed in front of each doorway, a young child is then brutally sacrificed with a long, golden knife during what is said to be a secret induction ceremony for new members of the Illuminati, better known as the New World Order. As a young freelance reporter in Rome during the early 1980s, I heard many rumors of these secret ceremonies from local shop owners, several drunken priests and a couple of local clairvoyants or fortune-telling card readers, one who apparently advised and guided the film career of the famous Italian film director, Federico Fellini. Although a product of a Catholic education and graduate of Notre Dame High School before going on to college, I still couldn't help but wonder if the stories about the brutal child sacrifices were actually true.