O.S.M.T.J. – J.P.L.I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
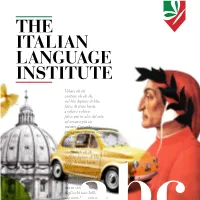
Accommodation
THE ITALIAN LANGUAGE INSTITUTE Volare oh oh cantare oh oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo volavo felice più in alto del sole ed ancora più sù, mentre il mondo pian piano spariva laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare oh oh cantare oh oh oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perchè, quando tramonta la luna li porta con se, ma io continuo a sognare negl’occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. THE SCHOOL THE TOWN The institute is situated in the centre of Viterbo and has been Viterbo (population: 60,000) is in central Italy, around 65 offering courses for ENGLISH and ITALIAN since 1995 and miles (105 km) north of Rome. The medieval walled hill town is accredited by the Italian Ministry of Education and Cam- is situated in Lazio. The region is also known as Tuscia, and bridge English Language Assessment. The experience, the lies within the loosely-defined area ofE truria, which spreads methods and the supervision of our teaching ensure the high across Lazio, Umbria and Tuscany, incorporating the heart- standard of our courses. lands of the ancient Etruscan civilization. We also pride ourselves on the warm, welcoming atmosphere The main attraction in Viterbo is its medieval architecture: in the school as well as the helpfulness of the staff. Teaching in the remains of its grand Papal Palace (Palazzo dei Papi) and small groups enables closer contact with teachers and fellow the humbler medieval lanes. -

On the Distribution of Lathyrus L. Species (Fabaceae) in Lazio (Central Italy)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Linzer biologische Beiträge Jahr/Year: 1997 Band/Volume: 0029_1 Autor(en)/Author(s): Mortellaro Rosella, Colasante Maretta Artikel/Article: On the distribution of Lathyrus L. species (Fabaceae) in Lazio (Central Italy). 247-297 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at Linzer biol. Beitr. 29/1 247-297 31.7.1997 On the distribution of Lathyrus L. species (Fabaceae) in Lazio (Central Italy) R. MORTELLARO & M. COLASANTE Abstract: Information about the distribution of species helps us to settle the se- paration of infrageneric taxa and are also useful to interpret the evolution of the ob- served genus. Here we refer to the distribution of Lathyrus species in Lazio (Central Italy) with information obtained from herbaria, field and Bibliographic data. In our investigation we found that some taxa need a complete systematic revision to solve their taxonomic problems concerning mainly a lot of intermediate forms which pro- bably are natural hybrids between some closely related taxa. It is obvious that the corresponding distribution feels the effect of this. In our opinion, according to recent investigations, we consider the following nineteen species to be spread in Lazio: L. amphicarpos L., L. annuus L., L. aphaca L., L. cicera L., L. clymenum L., L. hirsutus L., L. latifolius L., L. linifolius (REICHARD) BÄSSLER, L. niger (L.) BERNH., L. nisso- lia L., L. ochrus (L.) DC, L. pannonicus (JACQ.) GARCKE, L. pratensis L., L. sativus L., L. setifolius L., L. sphaericus RETZ, L. sylvestris L., L. venetus (MILLER) WOHLF., L. -

OGGETTO: Approvazione Dell'elenco Preliminare Dei Siti Geologici Di
DGR n. 859 del 13/11/2009 OGGETTO: Approvazione dell’elenco dei siti geologici di importanza regionale. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell’Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge Regionale n.6 del 18 febbraio 2002, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002; VISTA la Direttiva n.79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; VISTA la Direttiva 92/43 CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; VISTO il D.P.R. n.357/1997: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Direttiva “Habitat"); VISTA la legge 6 dicembre 1991, n.394 recante “Legge quadro sulle aree protette”, e successive modifiche ed integrazioni, che detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; VISTA la legge n.183 del 18 maggio 1989 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’art.136 del Decreto Legislativo del 22 gennaio -

ETRUSCAN TUSCANY – 7 Nights/ 8 Days
ETRUSCAN TUSCANY 8 days to discover the most ancient sites of Tuscany D01: ROME - VITERBO Arrival at Roma airport. Meeting with our bus driver and guide. The trip starts immediately to Cerveteri necropolis of Banditaccia, the oldest evidence of the Etruscan-Italic world of the origins. The architecture of the great tumulus, the ancient conception of the cycle of life, death and rebirth, and sacred arts and sciences. At twilight, nice accommodation in agriturismo near Viterbo. D02: LAKE BOLSENA – SORANO In the morning, trip around the Bolsena Lake to the Parco dei Mostri di Bomarzo, a unique monumental park. Here, carved in the living rock, stand the depictions of the fabulous myths of the ancient world, rediscovered during the Renaissance: the Giants, the Earth Goddess, drakes, sphinxes, sirens and other marvels. After the park, a stop to visit Civita di Bagnoregio, one of the most handsome Italian hamlets, then, trough the panoramic perimeter of the lake of Bolsena, we will arrive to our agriturismo in the Etruscan area Sorano-Pitigliano-Sovana. Dinner at the stunning old borgo of Sorano. D03: SORANO - SOVANA - PITIGLIANO - TUFO AREA Visit to the Etruscan zone of Sovana. Excursion to the volcanic rupestrian environment, where there are still the remains of the major Etruscan monuments like the Tomba della Sirena, the Ildebranda, the Cavone, the Tomba delle Ninfe Alate and many others. After lunch, visit to the medieval borgo of Sovana to the Duomo and the Church of Santa Maria, where the face of Jesus is said to have appeared, then proceeding to the Spring of the river Sileno and down to the Via Cava di San Giuseppe, walking up to the walled city of Pitigliano. -

Historic Preservation and Sustainable Design in the Etruscan Hill Towns of Central Italy May 6 – May 16, 2020 36 AIA-Approved HSW Learning Units
Historic Preservation and Sustainable Design in the Etruscan Hill Towns of Central Italy May 6 – May 16, 2020 36 AIA-Approved HSW Learning Units Civita di Bagnoregio, Italy Travel to the Etruscan Hill Town region of Italy to discover these intensely beautiful towns, landscapes and culture. This 10-day travel program focuses on modern and historic design, sustainability, preservation, art and architecture, food and wine in ancient hill towns and world-renowned UNESCO World Heritage Sites. Email us at [email protected] for more information Siena Cortona Perugia Pienza Assisi Todi Orvieto Civita di Bagnoregio Tuscania Caprarola Tarquinia Map modified from Mapquest source The Etruscan hill town civilization of central Italy was crucial to the development of Western culture, art, agriculture, and architecture. Enduring yet fragile, geological instability, conflicts and time have taken their toll requiring continual creativity, rebuilding, and stabilization. Travel to the Etruscan Hill Town region of Italy to discover these intensely beautiful towns, landscapes and culture. These hill towns present a living laboratory of sustainable design efforts across history. Join us in Italy for this small group tour and explore historical and modern design culture in an unforgettable series of experiences createdEmail to us promote at [email protected] design excellence by CrossCulture,for more information The Civita Institute and the American Institute of Architects. Your experiences include: ▪ An insider’s connections with The Civita Institute and the famed hilltown of Civita di Bagnoregio, an ancient Etruscan sss site that predates the founding of Rome. ▪ Travel to the Etruscan hill town of Perugia and a first hand look at a modern city with a highly preserved historic center. -

Download Download
EQA – Environmental quality / Qualité de l’Environnement / Qualità ambientale, 24 (2017) 39-45 PRELIMINARY EVIDENCES OF A PALEOSOL IN THE LIVING LANDSCAPE OF CIVITA DI BAGNOREGIO (ITALY) Sara Marinari (1)*, Maria Cristina Moscatelli (1) , Flavia Fiordelmondo (1) , Rosita Marabottini (1) , Giovanni Maria Di Buduo (2) , Gilmo Vianello (3) (1) Dipartimento per l’innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (2) Museo Geologico e delle Frane, Civita di Bagnoregio, Viterbo (3) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna Corresponding author Email: [email protected] Abstract A paleosol has been identified in an area of great natural interest for its geomorphologic and naturalistic aspects between the municipalities of Bagnoregio and Castiglione in Teverina (Viterbo, Italy). This investigation represents the preliminary steps of a study aimed to know the specific environmental features and dynamics prior to the eruptions of the "nenfri" of the Paleovulsini complex. The physico-chemical characteristics and some horizons morphological details such as the presence of roots fingerprint, the polyhedric angular and columnar structure suggest incipient weathering and pedogenesis. Moreover, the presence of nodules and the high salinity of deep horizons suggest the incorporation of pyroclastic material into a hydromorphic environment at the time of the eruptions, putting forward the hypothesis of a paleo-marsh under an arid paleoclimate. Keywords: paleosol, pyroclastic material, microbiological analysis, Civita di Bagnoregio Introduction A paleosol has been identified in an area of great natural interest for its geomorphologic and naturalistic aspects between the municipalities of Bagnoregio and Castiglione in Teverina (northern Lazio, bordering Umbria). Particular attention is given to landslides and erosive events repetition that affect both the cliff on which Civita rises and the adjacent "Valle dei Calanchi" (Fig. -

Your Italy, Your Story Istituto Lorenzo De’ Medici
Ldm TUSCANIA Your Italy, Your Story Istituto Lorenzo de’ Medici OUR MISSION Istituto Lorenzo de’ Medici is committed to delivering a high-quality international learning experience through which students advance along their educational paths, develop their creativity, realize their own potential, and empower themselves to impact the world around them. Experiential learning is LdM’s main tool to foster students’ future professional development. THE ITALIAN INTERNATIONAL INSTITUTE Founded in 1973 in Florence, Istituto Lorenzo de’ The educational opportunities at each of LdM’s Medici (LdM) is among Italy’s most comprehensive three sites are deeply rooted in their surrounding and well-established international institutions in environments, allowing students to experience higher education. In addition to its main campus in first-hand the inspiring culture of both historical Florence, LdM has premises in Rome and Tuscania. and contemporary Italy. LdM integrates formal, Today, LdM hosts over 3000 students annually from university-level learning with an emphasis on all over the world. personal growth, individual engagement, and community responsibility. OVER 40 YEARS OF EXPERIENCE IN INTERNATIONAL EDUCATION Istituto Lorenzo de’ Medici is affiliated with note on the quality of LdM facilities and academic institutions world-wide and is registered and environment. The LdM campuses in Florence, Rome authorized in Italy by the Ministry of Education, and Tuscania are approved by the U.S. Department (December 2, 1989); LdM is also accredited by the of Veterans Affairs. Tuscany Region as an educational institution (code LdM is also accredited by the CSN of the Swedish n. FI0735, decree n. 2935, July 4, 2012). government, by the Icelandic Student Loan Fund Istituto Lorenzo de’ Medici is approved by the US (LIN), and it has been awarded the European quality Middle States Commission on Higher Education as certification ISO 9001:2008 by EQA (European a branch campus of Marist College, with particular Quality Assurance). -

WORLD HERITAGE and DISASTER Knowledge, Culture and Rapresentation Le Vie Dei Mercanti XV International Forum
Fabbrica della Conoscenza numero 71 Collana fondata e diretta da Carmine Gambardella Fabbrica della Conoscenza Collana fondata e diretta da Carmine Gambardella Scientific Committee: Carmine Gambardella, UNESCO Chair on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance President and CEO of Benecon, Past-Director of the Department of Architecture and Industrial Design University of Studies of Campania “Luigi Vanvitelli” Federico Casalegno, Massachusetts Institute of Technology, Boston Massimo Giovannini, Professor, Università “Mediterranea”, Reggio Calabria Bernard Haumont, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Paris-Val de Seine Alaattin Kanoglu, Head of the Department of Architecture, İstanbul Technical University David Listokin, Professor, co-director of the Center for Urban Policy Research of Rutgers University / Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, USA Paola Sartorio, Executive Director, The U.S.- Italy Fulbright Commission Elena Shlienkova, Professor, Professor of Architecture and Construction Institute of Samara State Techni - cal University Isabel Tort Ausina, Director UNESCO Chair Forum University and Heritage, Universitat Politècnica De València UPV, Spain Nicola Pisacane, Professor of Drawing – Department of Architecture and Industrial Design_University of Studies of Campania “Luigi Vanvitelli” Head of the Master School of Architecture – Interior Design and for Autonomy Cour - ses -Department of Architecture and Industrial Design - University of Studies of Cam - pania “Luigi Vanvitelli” Pasquale Argenziano, Professor of Drawing – Department of Architecture and Industrial Design_University of Studies of Campania “Luigi Vanvitelli” Alessandra Avella, Professor of Drawing – Department of Architecture and Industrial Design_University of Studies of Campania “Luigi Vanvitelli” Alessandro Ciambrone, Ph.D. in Territorial Governance (Milieux, Cultures et Sociétés du passé et du présent – ED 395) Université Paris X UNESCO Vocations Patrimoine 2007-09 Fellow / FUL - BRIGHT Thomas Foglietta 2003-04 Rosaria Parente, Ph.D. -

Etruria Alatel 2021
4 giorni - 3 notti dal 1 al 4 ottobre 2021 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 595 (effettuazione con almeno 30 partecipanti)- Supplemento singola € 105 Versamento acconto di € 150 entro il 07/08/2021 - Saldo entro 21/08/2021 LA SEQUENZA DEL TOUR POTREBBE ESSERE MODIFICATA MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI Le prenotazioni possono essere effettuate per email all’[email protected] , per sms o su whatsapp al numero 338 6846793. Gli iscritti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di tutela in materia di Covid-19. 1° Giorno Venerdì: Partenza – Bolsena- Viterbo Ritrovo dei Sigg.ri Partecipan� secondo orario stabilitoepartenza da Mestre per il Lazio.Sosteper lasalita dei passeggeri a Padova (Ikea)eRovigo e per una pausa caffè / primacolazione libera. In tarda ma�nata arrivo a Bolsena per la prima visita guidata: la città è dominata dalla massiccia Rocca Monaldeschi, uno suoi dei monumen� più rappresentativi. Pranzoin ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con visita di Civita di Bagnoregio; la monumentale Porta Santa Maria è oggi l’unico accessoalborgo: passando sotto di essa, si possono ammirare le splendide decorazioni di leoni che schiacciano alcune figure umane. Al termine proseguimento per Viterbo, sistemazione in hotel, cena e perno�amento. 2° Giorno Sabato: Tarquinia – Tuscania- Vulci Prima colazione in hotel e successivapartenza per Tarquinia con visita guidata alla famosa Necropoli:ammirerete una straordinaria serie di tombe a tumulo scavate nella roccia e dipinte, insieme che rappresenta il nucleo più pres�gioso di questa zona archeologica, sicuramente la più importante del Mediterraneo.Pranzo in ristorante e proseguimento per Tuscania: la sugges�va ci�adina conserva l’aspetto medievalecon i suoi sette promontori in tufo su cui è stata eretta a 180 metri sul livello del mare. -

La Squadra Dell'istituto Agosti Di Bagnoregio Conquista Il Trofeo Città Di Montefiascone
This page was exported from - TusciaTimes.eu (.it) Export date: Sun Sep 26 21:07:18 2021 / +0000 GMT La squadra dell'istituto Agosti di Bagnoregio conquista il Trofeo Città di Montefiascone MONTEFIASCONE (Viterbo) ? La squadra dell'IO ?F. lli Agosti? di Bagnoregio guidata dalla professoressa Milva Ferlicca, coadiuvata dai colleghi Vittoria Angeli e Salvatore Paioletti, si aggiudica la prima edizione del ?Trofeo Città di Montefiascone? e si qualifica per disputare il ?Trofeo Città di Viterbo? in programma a Viterbo alla fine di maggio 2017. Si tratta della manifestazione conclusiva, a cui sono ammesse le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi provinciali. L'evento, che si è tenuto a Montefiascone il 30 novembre scorso, rientra nella programmazione del Progetto ?Scuola-Movimento-Sport-Salute? per la realizzazione del quale si sono unite in un accordo di rete tutte le Scuole di I grado della Provincia di Viterbo e del quale è capofila l'IC ?L. Fantappiè? di Viterbo. Tale Progetto è patrocinato dal CONI Lazio, dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo, dalla ASL di Viterbo, dall'Ordine dei Medici di Viterbo, dalla UIL Scuola di Viterbo ed è sostenuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale. In particolare, il Trofeo ?Città di Montefiascone? è patrocinato e sostenuto dal Comune di Montefiascone. Oltre alla squadra vincitrice, hanno preso parte all'incontro la squadra dell'IC ?Via Ruspantini? di Grotte di C., guidata dai professori Carlo Palumbo, Adria Dionisi, Maria Paola Belli e Fabrizio Belli; la rappresentativa dell'IC ?P. Ruffini? di Valentano, guidata dai professori Sebastiano Sbocchia, Giancarlo Menichelli, Monica Balestra, Francesca Benincasa, Tamara Pasquini e la squadra dell'Istituto Omnicomprensivo di Acuapendente guidata dai professori Gabriella Dionisi, Silvia Galli, Federica Barbini e Dante Tramontana. -

Italy Travel and Driving Guide
Travel & Driving Guide Italy www.autoeurope. com 1-800-223-5555 Index Contents Page Tips and Road Signs in Italy 3 Driving Laws and Insurance for Italy 4 Road Signs, Tolls, driving 5 Requirements for Italy Car Rental FAQ’s 6-7 Italy Regions at a Glance 7 Touring Guides Rome Guide 8-9 Northwest Italy Guide 10-11 Northeast Italy Guide 12-13 Central Italy 14-16 Southern Italy 17-18 Sicily and Sardinia 19-20 Getting Into Italy 21 Accommodation 22 Climate, Language and Public Holidays 23 Health and Safety 24 Key Facts 25 Money and Mileage Chart 26 www.autoeurope.www.autoeurope.com com 1-800 -223-5555 Touring Italy By Car Italy is a dream holiday destination and an iconic country of Europe. The boot shape of Italy dips its toe into the Mediterranean Sea at the southern tip, has snow capped Alps at its northern end, and rolling hills, pristine beaches and bustling cities in between. Discover the ancient ruins, fine museums, magnificent artworks and incredible architecture around Italy, along with century old traditions, intriguing festivals and wonderful culture. Indulge in the fantastic cuisine in Italy in beautiful locations. With so much to see and do, a self drive holiday is the perfect way to see as much of Italy as you wish at your own pace. Italy has an excellent road and highway network that will allow you to enjoy all the famous sites, and give you the freedom to uncover some undiscovered treasures as well. This guide is aimed at the traveler that enjoys the independence and comfort of their own vehicle. -

Proposal Bay of Naples
Independent 'Self Guided' walking tour Via Francigena Bolsena - Viterbo - Roma Along the final part of the Via Francigena through the Tuscia, the land of the Etruscans - from Bolsena, past Viterbo, to Rome TRIP NOTES 2021 © Genius Loci Travel. All rights reserved. [email protected] | www.genius-loci.it ***GENIUS LOCI TRAVEL - The Real Spirit Of Italy*** Independent 'Self Guided' walking tour INTRODUCTION This is a moderately challenging tour which is suitable for experienced walkers with a good general physical condition. Through the extensive footpath network of the area, roughly following the traces of the Via Francigena, one of Europe’s most important ‘highways’ in medieval times, you walk from village to village, a full immersion in the world-famous Tuscan landscape, until arriving on the shore of Lake Bolsena, in the Etruscan heartland. This last part of the Via Francigena is perhaps the area where the intriguing history of the area comes most alive. Here, more than ‘only’ walking over a medieval pilgrim’s route you’ll walk through the heartland of the Etruscans, an ancient civilisation which flourished in this area before the rise of the Roman Empire. This area, now known as the ‘Tuscia’ area, is an area where the layers of history can all be explored: apart from the Etruscan heritage, of course the Romans left many traces here too, among which one of the best preserves amphitheatres in the ancient city of Sutri. In medieval times a number of fortresses where built in several places, while during the Renaissance Popes and other wealthy families from Rome built their villa’s here, often surrounded by superbly landscaped parks.