Lectura Dantis 2002-2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vettori, Italian
Rutgers, The State University of New Jersey Department of Italian 16:560:605 Dante Seminar Fall 2013 Alessandro Vettori Office Hours by appointment Department of Italian Tel 732-932-7536 84 College Avenue - Rm 101 Fax 732-932-1686 email: [email protected] The purpose of this course is the investigation of Dante’s opus in relation to other poets, philosophers, and theologians that had deep influences on his writing. Although only two of his major works will be read in their entirety, the Divine Comedy and the Vita nova, constant references will be made to other writings. Besides a stylistic and formal analysis, numerous thematic strains will be researched and followed throughout Dante’s production. Particular attention will be paid to such concepts as allegory, poetic auto-interpretation, autobiography, and the ever-changing concept of love. Learning goals: Students will be trained to do a close analysis of literary texts, to put poetic and prose texts in conversation with philosophical ideas, to discern the boundaries of literature, philosophy, and theology. They will be assessed by means of oral presentations (one long, one short), one short paper, one long (publishable) paper, and class participation. Syllabus Texts: Vita Nova (any annotated edition); Divina Commedia (any annotated edition); secondary materials will be made available on sakai. 09/09 Introduction. Exile, Poetry, Prayer. 09/16 Vita Nuova. Ronald Martinez, “Mourning Beatrice: The Rhetoric of Threnody in the Vita nuova,” Modern Language Notes 113 (1998): 1-29. 09/23 Vita Nuova. Teodolinda Barolini, “‘Cominciandomi dal principio infino a la fine’ (V.N. XXIII 15): Forging Anti-Narrative in the Vita Nuova,” La gloriosa donna de la mente. -

L'immagine Di Ugolino Della Gherardesca Fra Arti Figurative E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI Corso di Laurea Triennale in Lettere Moderne L’immagine di Ugolino della Gherardesca fra arti figurative e cinema Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Giuliana NUVOLI Elaborato finale di: Stefano Ratti Anno Accademico 2013-2014 INDICE Introduzione CAPITOLO I: Il Conte Ugolino §.1 Il personaggio della Commedia §.2 Confronto con le opere artistiche §.3 Il personaggio nella storia CAPITOLO II: La figura del Conte Ugolino nella pittura §.1 Dal XIV al XIX secolo §.2 Dal XIX secolo ad oggi §.3 I miniatori della Commedia §.4 Gli illustratori della Commedia CAPITOLO III: La figura del Conte Ugolino nella scultura §.1 Jean-Baptiste Carpeaux §.2 Auguste Rodin §.3 Altre sculture CAPITOLO IV: L’inferno e il Conte Ugolino nella cinematografia §.1 L’Inferno del 1911 §.2 Dante’s Inferno: an animated epic §.3 Uccellacci e Uccellini Bibliografia Sitografia 1 Introduzione La figura del Conte Ugolino – celebre personaggio, realmente esistito nel 1200, incontrato da Dante Alighieri alla fine del canto XXXII della Divina Commedia, anche se la sua storia viene narrata interamente nel canto successivo, il XXXIII – ha suscitato un interesse non solo nei contemporanei lettori dell’opera di Dante, ma è divenuto simbolo della sofferenza umana e della violenza assurgendo a un immaginario mitico ormai condiviso da un pubblico vastissimo. A partire dalla figura del personaggio dantesco che scaturisce dall’interpretazione del testo della Divina Commedia, si cercherà di individuare non solo la fisionomia ma soprattutto quelle caratteristiche psicologiche che il testo di Dante lascia trasparire. Quest’ultima figura dovrà essere comparata con il personaggio storicamente esistito per cogliere le analogie e le differenze. -

A British Reflection: the Relationship Between Dante's Comedy and The
A British Reflection: the Relationship between Dante’s Comedy and the Italian Fascist Movement and Regime during the 1920s and 1930s with references to the Risorgimento. Keon Esky A thesis submitted in fulfilment of requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Arts and Social Sciences. University of Sydney 2016 KEON ESKY Fig. 1 Raffaello Sanzio, ‘La Disputa’ (detail) 1510-11, Fresco - Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatican. KEON ESKY ii I dedicate this thesis to my late father who would have wanted me to embark on such a journey, and to my partner who with patience and love has never stopped believing that I could do it. KEON ESKY iii ACKNOWLEDGEMENTS This thesis owes a debt of gratitude to many people in many different countries, and indeed continents. They have all contributed in various measures to the completion of this endeavour. However, this study is deeply indebted first and foremost to my supervisor Dr. Francesco Borghesi. Without his assistance throughout these many years, this thesis would not have been possible. For his support, patience, motivation, and vast knowledge I shall be forever thankful. He truly was my Virgil. Besides my supervisor, I would like to thank the whole Department of Italian Studies at the University of Sydney, who have patiently worked with me and assisted me when I needed it. My sincere thanks go to Dr. Rubino and the rest of the committees that in the years have formed the panel for the Annual Reviews for their insightful comments and encouragement, but equally for their firm questioning, which helped me widening the scope of my research and accept other perspectives. -

Inferno Canto 05
!Inferno: Canto 5! pg.1 Entrance to Second Circle - Minos - Good Friday Night THE STORY. Dante and Virgil descend from the First Circle to the Second (the first of the Circle of Incontinence). On the threshold sits Minos, the judge of Hell, assigning the souls to their appropriate places of torment. His opposition is overcome by Virgil's word of power, and the Poets enter the Circle, where the souls of the Lustful are tossed for ever upon a howling wind. After Virgil has pointed out a number of famous lovers, Dante speaks to the shade of Francesca da Rimini, who tells him her story. From the first circle thus I came descending To the second, which, in narrower compass turning, Holds greater woe, with outcry loud and rending. There in the threshold, horrible and girning,!4 Grim Minos sits, holding his ghastly session, And, as he girds him, sentencing and spurning; For when the ill soul faces him, confession!7 Pours out of it till nothing's left to tell; Whereon that connoisseur of all transgression Assigns it to its proper place in hell,!10 As many grades as he would have it fall, So oft he belts him round with his own tail. Before him stands a throng continual;!13 Each comes in turn to abye the fell arraign; They speak - they hear- they're whirled down one and all. "Ho! thou that comest to the house of pain,"!16 Cried Minos when he saw me, the appliance Of his dread powers suspending, "think again How thou dost go, in whom is thy reliance;!19 Be not deceived by the wide open door!" Then said my guide: "Wherefore this loud defiance? Hinder not thou his fated way; be sure!22 Hindrance is vain; thus it is willed where will And power are one; enough; ask thou no more." And now the sounds of grief begin to fill!25 My ear; I'm come where cries of anguish smite My shrinking sense, and lamentation shrill - A place made dumb of every glimmer of light,!28 Which bellows like tempestuous ocean birling In the batter of a two-way wind's buffet and fight. -
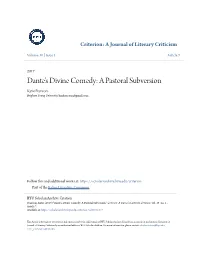
Dante's Divine Comedy
Criterion: A Journal of Literary Criticism Volume 10 | Issue 1 Article 7 2017 Dante’s Divine Comedy: A Pastoral Subversion Katie Francom Brigham Young University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/criterion Part of the Italian Literature Commons BYU ScholarsArchive Citation Francom, Katie (2017) "Dante’s Divine Comedy: A Pastoral Subversion," Criterion: A Journal of Literary Criticism: Vol. 10 : Iss. 1 , Article 7. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/criterion/vol10/iss1/7 This Article is brought to you for free and open access by the All Journals at BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Criterion: A Journal of Literary Criticism by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Dante’s Divine Comedy: A Pastoral Subversion Cover Page Footnote A huge thank you to Dr. Michael Lavers for encouraging me to write and publish this article and to Adrian Ramjoué for his editing expertise. This article is available in Criterion: A Journal of Literary Criticism: https://scholarsarchive.byu.edu/criterion/vol10/iss1/7 Dante’s Divine Comedy A Pastoral Subversion Katie Francom In Virgil’s writings, “pastoral poetry came to be used as a vehicle for allegory or veiled social and political comment” (“Pastoral Poetry”). It is thus fitting that Dante, in his attempt to write what he believed to be the greatest allegory ever created, chose Virgil to be his literary and narrative guide. Dante pulls from what Prue Shaw, a prominent Dante critic, calls the “fertilising powers” of Virgil’s allegorical and pastoral influences throughout The Divine Comedy (172). -

IT 415: Dante
La Divina Commedia di Dante ITAL 415 Fall 2016 Pennsylvania State University Prof. Michele Rossi Contacts and Information Michele Rossi, Ph.D. Email: [email protected] Office: Burrowes Bldg., Room 044 Office Hours: Tuesday and Thursday, 10:30am-11:30am; and by appointment Class Schedule: Tuesday and Thursday, 12:05pm-1:20pm, Health and Human Development Bldg. Course Description: As stated by Italo Calvino, “a classic is a book that has never finished saying what it has to say.” The Divine Comedy, Dante’s masterpiece, continues to speak to us even seven centuries after its composition. In this course, we will read Dante’s poem focusing on its famous characters – Francesca da Rimini, Pier delle Vigne, Ulisse, il conte Ugolino, Manfredi, Guido Gunizzelli, Virgilio, Beatrice… –, and we will explore different topics: love, power, and literature, 1 among others. We will also investigate the relationships between the concepts of metaphor and metamorphosis, with the goal of illuminating Dante’s unique and complex poetics. In our journey from Hell to Heaven, we will place the Divine Comedy in the cultural, historical, and literary context in which it was conceived (Italy in the Middle Ages), without forgetting its enduring influence today, even in our pop culture, as demonstrated by contemporary books (Dan Brown’s Inferno), movies (Seven), music bands (The Divine Comedy), and videogames (Dante’s Inferno). The course will be taught in Italian. Prerequisite: any 300-level Italian course. Required Book (complete version: Inferno, Purgatorio, and Paradiso): Dante Alighieri, The Divine Comedy, eds. Durling and Martinez, Oxford University Press. Course Requirements - Class Participation (25%). -

La Commedia in Palcoscenico. Appunti Su Una Ricerca Da Fare Dante E L’Arte 1, 2014 67-84
La Commedia in palcoscenico. Appunti su una ricerca da fare Dante e l’arte 1, 2014 67-84 La Commedia in palcoscenico. Appunti su una ricerca da fare Marzia Pieri Università di Siena [email protected] Riassunto Da circa due secoli la Divina Commedia è fatta oggetto, in Italia, di letture teatralizzate e di vere e proprie riduzioni drammaturgiche, che hanno raggiunto vaste masse di spet- tatori, e la cui popolarità non accenna ancora oggi ad esaurirsi. Il fenomeno delle “dan- tate” – che non conosce equivalenti in altre culture europee – accompagna l’avventura risorgimentale per la conquista dell’indipendenza, ed è legato alla tradizione italiana del grande mattatore romantico: a partire da Gustavo Modena (l’attore mazziniano che intende portare Dante al popolo come veicolo di emancipazione politica), i grandi guitti italiani romantici, naturalistici e poi novecenteschi (di avanguardia o di “tradizione”) hanno continuato a recitare il poema, costruendo, per via performativa, una peculiare ecdotica, ancora tutta da studiare. Le celebrazioni dantesche del centenario del 1865, in una Firenze appena consacrata capitale del Regno d’Italia, segnano un acme di questa fortuna festiva e teatrale. Parole chiave: Divina Commedia, Risorgimento, Recital, Gustavo Modena, Roberto Benigni, Firenze capitale, cinema muto. Abstract For the last two centuries in Italy, the Divine Comedy has been made subject of dramati- zed readings and proper dramatic reductions that have reached the bulk of the audience, and whose popularity doesn’t yet show any sign of exhaustion. The phenomenon of the ‘dantate’ – with no equivalent in other European cultures – accompanies the risorgimen- tale adventure for the sake of gaining independence. -

Dante Alighieri's Divine Comedy – Inferno
DIVINE COMEDY -INFERNO DANTE ALIGHIERI HENRY WADSWORTH LONGFELLOW ENGLISH TRANSLATION AND NOTES PAUL GUSTAVE DORE´ ILLUSTRATIONS JOSEF NYGRIN PDF PREPARATION AND TYPESETTING ENGLISH TRANSLATION AND NOTES Henry Wadsworth Longfellow ILLUSTRATIONS Paul Gustave Dor´e Released under Creative Commons Attribution-Noncommercial Licence. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ You are free: to share – to copy, distribute, display, and perform the work; to remix – to make derivative works. Under the following conditions: attribution – you must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work); noncommercial – you may not use this work for commercial purposes. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. English translation and notes by H. W. Longfellow obtained from http://dante.ilt.columbia.edu/new/comedy/. Scans of illustrations by P. G. Dor´e obtained from http://www.danshort.com/dc/, scanned by Dan Short, used with permission. MIKTEXLATEX typesetting by Josef Nygrin, in Jan & Feb 2008. http://www.paskvil.com/ Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin Contents Canto 1 1 Canto 2 9 Canto 3 16 Canto 4 23 Canto 5 30 Canto 6 38 Canto 7 44 Canto 8 51 Canto 9 58 Canto 10 65 Canto 11 71 Canto 12 77 Canto 13 85 Canto 14 93 Canto 15 99 Canto 16 104 Canto 17 110 Canto 18 116 Canto 19 124 Canto 20 131 Canto 21 136 Canto 22 143 Canto 23 150 Canto 24 158 Canto 25 164 Canto 26 171 Canto 27 177 Canto 28 183 Canto 29 192 Canto 30 200 Canto 31 207 Canto 32 215 Canto 33 222 Canto 34 231 Dante Alighieri 239 Henry Wadsworth Longfellow 245 Paul Gustave Dor´e 251 Some rights reserved c 2008 Josef Nygrin http://www.paskvil.com/ Inferno Figure 1: Midway upon the journey of our life I found myself within a forest dark.. -

American Dante Bibliography for 2001.Pdf
American Dante Bibliography for 2001 Christopher Kleinhenz This bibliography is intended to include all the Dante translations published in North America in 2001 and all Dante studies and reviews published in 2001 that are in any sense North American. The latter criterion is construed to include foreign reviews of North American publications pertaining to Dante. Books Alfie, Fabian. Comedy and Culture: Cecco Angiolieri’s Poetry and Late Medieval Society. Leeds: Northern Universities Press, 2001. vi, 216 p. (Italian Perspectives, 7) Contents: Acknowledgements (vi); Introduction. The Trouble with Cecco: The ‘State of the Question’ and Difficulties Inherent in a Study of Angiolieri (1-17); I. Comedy and Culture: Cecco Angiolieri and the Comic Traditions (19-43); II. Love and Literature: Cecco Angiolieri’s Relationship with the Amorous Lyric Traditions (45-81); III. Poverty and Poetry: Cecco Angiolieri’s Position in the Evolution of a Vernacular Trope (83-113); IV. Insult and Injury: Vituperium in the Poetry of Cecco Angiolieri (115-143); V. Cecco, Simone, Dante and Guelfo: Correspondence among Angiolieri’s Poetry (145-163); VI. Fact or Fiction: Cecco Angiolieri’s Poetic Self-Presentation (165-192); Bibliography (193-209); Index of References to Angiolieri’s Sonnets (211-212); General Index (213-216). Barolini, Teodolinda. Desire and Death, or Francesca and Guido Cavalcanti: Inferno 5 in its Lyric Context. Binghamton: Center for Medieval and Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, 2001. 50 p. (Bernardo Lecture Series, No. 9) “Explores the lyric context of Inferno 5, paying particular attention to how Italian lyric poets like Giacomo da Lentini, Guido delle Colonne, Guittone d’Arezzo, Guido Cavalcanti, and Dante himself had framed the issue of desire insufficiently controlled by reason. -
![Collana Di Studi E Testi [52]](https://docslib.b-cdn.net/cover/5203/collana-di-studi-e-testi-52-2315203.webp)
Collana Di Studi E Testi [52]
LA MODERNITÀ LETTERARIA collana di studi e testi diretta da Anna Dolfi, Alessandro Maxia, Nicola Merola Angelo R. Pupino, Giovanna Rosa [52] 000a_PAG.ED.TOMO1.indd 1 18/11/15 11.32 000a_PAG.ED.TOMO1.indd 2 18/11/15 11.32 La funzione Dante e i paradigmi della modernità Atti del XVI Convegno Internazionale della MOD Lumsa Roma, 10-13 giugno 2014 a cura di Patrizia Bertini Malgarini, Nicola Merola e Caterina Verbaro Edizioni ETS 000a_PAG.ED.TOMO1.indd 3 18/11/15 11.32 www.edizioniets.com Il presente volume è stato pubblicato con il contributo della Libera Università Maria SS. Assunta (Lumsa) di Roma © Copyright 2015 Edizioni ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa [email protected] www.edizioniets.com Distribuzione Messaggerie Libri SPA Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI) Promozione PDE PROMOZIONE SRL via Zago 2/2 - 40128 Bologna ISBN 978-884674365-7 ISSN 2239-9194 000a_PAG.ED.TOMO1.indd 4 18/11/15 11.32 CLARA BORRELLI FRANCESCA DA RIMINI NELLA TRAGEDIA della prima metà dell’OttOCENTO Tra le tante creature che Dante incontra nel suo viaggio ultraterreno, Francesca da Rimini è senza dubbio quella che ha occupato maggiormente la fantasia di drammaturghi, poeti e narratori nella prima metà dell’Otto- cento1. Il recupero della vicenda della figlia di Guido da Polenta, insieme a quello di Pia, di Piccarda, di Ugolino, di Farinata, di Manfredi e dell’A- lighieri stesso2, avviene sull’onda della riscoperta dei valori morali e civili della poesia della Commedia e dell’esemplarità del poeta fiorentino, model- lo di cittadino integerrimo e di esule fiero e disdegnoso, avviata dalla critica nella seconda metà del Settecento. -

A Twopart Curriculum Bulletin Pays Tribute to the Lite and Works of Dante Alighieri During the 700Th Annivarsary of His Birte
DOCUMENT RESUME ED 036 241 FL 001 644 AUTHOR CAVICCHIA, GIDA; CCSTADASI, VIRGINIA TITLE DANTE, SEVENTH CENTENNIAL, 1265-1965: RESOURCE MATERIALS FOR TEACHERS. CURRICULUM BULLETIN, 1965-66 SERIES, NUMBER 16. INSTITUTION NEW YORK CITY BOARD aF EDUCATION, BROOKLYNe N.Y. PUB DATE SEP 65 NOTE 111P. AVAILABLE FRCM BOARD OF-EDUCATION OF THE CITY OF NEW YORK, PUBLICATIONS SATES OFFICE, 110 LIVINGSTON STREET, BROOKLYN, NEW YORK 11201 ($1.50) EDRS PRICE EDRS PRICE MF-r$0.50 HC NOT AVAILABLE FROM EDRS. DESCRIPTORS AUTHORS, BIOGRAPHIES, CHORAL SPEAKING, CCMPOSITICN SKILLS {_LITERARY), *CURRICULUM GUIDES, FINE ARTS, INSTRUCTIONAL AIDS, INSTRUCTIONAL PROGRAM DIVISIONS, *INTERDISCIPLINARY APPROACH, *ITALIAN, LITERARY ANALYSIS, LITERARY STYLES, LITERATURE, MATHEMATICS, *POETS, READING COMPREHENSION, READING MATERIAL SELECTION, SOCIAL STUDIES, TEACHING GUIDES, VOCABULARY DEVELOPMENT IDENTIFIERS *DANTE ALIGHIERI, *DIVINE COMEDY ABSTRACT A TWOPART CURRICULUM BULLETIN PAYS TRIBUTE TO THE LITE AND WORKS OF DANTE ALIGHIERI DURING THE 700TH ANNIVARSARY OF HIS BIRTE. PART ONE INCLUDES HIS BIOGRAPHY, A DISCUSSION OF HIS MINOR WORKS, A SUMMARY OF "THE DIVINE COMEDY", DANTE'S IMPACT ON OTHER LANDS, AND DANTEAN THOUGHT. SUGGESTIONS FOR TEACHING A RESOURCE UNIT FOR ELEMENTARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL GRADES ARE PROVIDED. OTHER LANGUAGE ARTS TOPICS ARE (1) A GUIDED READING LESSON, (2)A COMPOSITION LESSON FOR VOCABULA.RY ENRICHMENT,(3) CHORAL SPEAKING, (4) POETRY APPRECIATICN, AND (5) LITERATURE. MATERIALS RELATED TO DANTE IN SOCIAL STUDIES, MATHEMATICS, ASTRONOMY, MUSIC, THE DANCE, ART, AND GUIDANCE ARE OFFERED ALONG WITH A BIBLIOGRAPHY. AN ORIGINAL PLAY, "DANTE AND BEATRICE", IS FOUND IN THE APPENDIX. (EL) U.S.DEPARIZTOTIFEAiTH.,EDLTIIIiWELFARE THIS DOCUMENT HAS BEEN REPRODUCEDOFFICE OF EDUCATION EXACTLY AS RECEIVED FROM THE !PERSON!STATEDPOSITION elmosizageolowei DOOR OR EDONOT ORGANIZATIONmum NECESSARILY ORIGINATING362,41 REPRESENT IT. -

A Study of Certain Versions of the Francesc! Da Rimini Theme
A STUDY OF CERTAIN VERSIONS OF THE FRANCESC! DA RIMINI THEME A THffiSIS SUBMITTED TO THE DEPA.RTMENT OF ENGLISH AND THE GRADUATE COUNCIL OF TEE KANSAS STATE TEACEERS COLLEGE OF EMPORIA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SO IENeE BY FRANCES HAMMAN \ IrQ l ,~" App~oved for the Majo~ Department l.Q :;;; . \.Q 11 '1"3109' j AOKN°WLE:QctMENT I wifi;P.tp acJ(;nowle.dge tihe gene;rr,ous cooperation or Dr. He.r0ld M. ifr:LE3st in the preparation of this thesis. He su.ggested the Francasca da R1mini theme as a sabject for study and his suggestions and criticisms have been extremely valuable. Frances Hamman TABm OF OONTENTS CHAPTER PAGE J;;:NTRO;oW~;I;ON 1 I I1A:N.!FE';S FMNOESOA 6 II J'EilLICO"B FRANPESOA. ,~. ;",;,RI::;.;;:MI;;;;;:';;,:;;N;.:;;;.I 11 III 19 IV BOKER t,$Jf!ANCES04. I?! ,ftIM.I:NI 24 ·V :aARDY'S .....F.....RA-.N....CE"-S;..,G....A ~ RIMnlI . 30 VI PHILLIPS'S --:.::P'A;;..o.oQ;.,;;;L_O .urn FRANCEseA - ~ R 3"7 VII 44 VIII 49 INTRODUCTION NATURE AND PURPOSE Since Dante first told the tragic love story of Fran oescs. da Rimini and Paolo Malatesta in the fifth canto of the tl Inferno" 'of The Divln~ Come9I, the theme has been inter preted in many forms of art in many nations. Painters, sculptors, musicians, poets" and dramatists in great numbers have made the story a subject for their art. Ingrss, Scheffer, watts" Cabanel are some of those who. have interpl:'eted the theme in art.