Donne E Scienza Def.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zootaxa, Two New Empoascine Leafhopper Genera and Species (Hemiptera
Zootaxa 1966: 62–68 (2008) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ ZOOTAXA Copyright © 2008 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Two new empoascine leafhopper genera and species (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) from southern China, with a key to Chinese genera of Empoascini DAO-ZHENG QIN1 & YA-LIN ZHANG2 Key Laboratory of Plant Protection Resources and Pest Management of Ministry of Education, Entomological Museum, Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi Province, 712100, China. E-mail: [email protected]; [email protected] 2corresponding author Abstract Two new genera and species of empoascine leafhoppers, Luodianasca recurvata and Treufalka lamellata are described from southern China. A key to these and other Empoascini genera from China is also provided. Key words: Auchenorrhyncha, Empoascini, Luodianasca gen. nov., Treufalka gen. nov., taxonomy, distribution Introduction The leafhopper tribe Empoascini, with more than 1000 described species worldwide, is a large group within the subfamily Typhlocybinae and can most readily be identified by the forewing lacking an appendix, hind- wing with all longitudinal veins ending at the submarginal vein, and the submarginal vein reaching but not exceeding the vein R+MP (Zhang, 1990). At present 65 genera have been recognized distributed worldwide. Many species of the group are major pests of crops, such as cotton, grape and eggplant (Oman 1949, Vidano 1962, Nielson 1968, Zhang 1990). The cotton leafhopper, Amrasca biguttula, is a destructive pest in southern China (Kuoh, 1966, Zhang 1990). The empoascine fauna of China remains inadequately studied, more than 100 species in 18 genera are known, mainly treated in the works of Matsumura (1931), Kuoh (1966), Zhang (1990) and Dworakowska (1982). -

Erika Luciano
Il curriculum vitae qui riportato contiene le informazioni relative all’attività scientifica e didattica, redatte ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. ERIKA LUCIANO INFORMAZIONI • Luogo e Data di nascita: Cuneo, 1 marzo 1979 PERSONALI • Cittadinanza: Italiana • CF: LCNRKE79C41D205B • Stato civile: coniugata, tre figli • Indirizzo di lavoro: Dipartimento di Matematica ‘G. Peano’, Università di Torino, Via Carlo Alberto 10, 10123 Torino • Indirizzo di residenza: Corso Dante 45, 12100 Cuneo • Telefono: +39 011 670 2900 (Ufficio) • Fax: +39 011 670 2878 Email [email protected] Pagina web: https://www.matematica.unito.it/do/docenti.pl/Alias?erika.luciano#tab-profilo Pagina Gruppo di Ricerca https://www.dipmatematica.unito.it/do/gruppi.pl/Show?_id=7vxg ORCID https://orcid.org/0000-0002-4037-7676 POSIZIONE • PROFESSORE UNIVERSITARIO SECONDA FASCIA CONFERMATO ATTUALE DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ‘G. PEANO’ (SSD MAT/04 – Matematiche Complementari) • ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PROFESSORE PRIMA FASCIA nel SSC 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari, SSD MAT/04 – Matematiche Complementari, conseguita il 19/04/2019 • ABILITAZIONE SCIENTIFCA NAZIONALE PROFESSORE PRIMA FASCIA nel SSC 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza, SSD MSTO/05 Storia della scienza e delle tecniche, conseguita il 6/05/2019 • ABILITAZIONE SCIENTIFCA NAZIONALE PROFESSORE SECONDA FASCIA nel SSC 11/C2 – Logica, Storia e Filosofia della Scienza, SSD MSTO/05 Storia della scienza e delle tecniche, conseguita il 29/03/2018 POSIZIONI E • 7.9.2015 chiamata unanime Professore Associato, S.S.D. -

1 Demographic Study of the Green Leafhopper, Empoasca Decipiens
Appl. Ent. Phytopath. Vol. 77, No. 2, March 2010 Demographic study of the green leafhopper, Empoasca decipiens (Hemiptera: Cicadellidae) on four sugar beet cultivars A. A. Talebi 1∗, A. Izadpanah 1, S. Moharramipour 1, Y. Fathipour 1 and B. Naseri 2 1- Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran 2- Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil (Received: July 2008; Accepted: May 2009) ABSTRACT The green leafhopper, Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) is one of pests of sugar beet, Beta vulgaris L. in Iran. In this research, life table, reproduction and population growth parameters of E. decipiens were studied on four sugar beet cultivars: Shirin, Rasool, PP8 and IC. The experiments were conducted in a growth chamber at temperature of 25±1 ºC, 50-60% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. The survival rate of individuals developed into adults from the initial cohort stage was estimated 0.78, 0.81, 0.78, and 0.76 on Shirin, Rasool, PP8 and IC, respectively. The life expectancy was 13.75, 14.89, 14.46 and 15.72 days, respectively at the first day of adult emergence. The highest gross and net fecundity rates were on IC and Shirin, respectively. Gross reproduction rate were 22.03, 20.07, 22.06 and 22.31 female per female per generation, on Shirin, Rasool, PP8 and IC, -1 respectively. Intrinsic rate of increase ( rm) were 0.099 and 0.104 (day ) on Shirin and IC, respectively. The mean generation time ( T), net reproduction rate ( R0), doubling time ( DT ) and finite rate of increase ( λ) on these cultivars were estimated by Jackknife method: 29.14- 31.75 days, 20.07-22.31 female per female per generation, 6.62-7.01 days, and 1.103-1.110 offspring per female per day, respectively. -

Distribution, Food Plants and Control of Asymmetrasca Decedens (Paoli, 1932) (Hemiptera: Cicadellidae)
DISTRIBUTION, FOOD PLANTS AND CONTROL OF ASYMMETRASCA DECEDENS (PAOLI, 1932) (HEMIPTERA: CICADELLIDAE) N. FREITAS 1 & D. AGUIN-POMBO 1, 2 With 3 figures and 1 table ABSTRACT. Asymmetrasca decedens is a polyphagous species and a pest of many cultivated plants. Although it is mainly distributed in the Mediterranean region, recently it has been reported also from Madeira Island. So far here it has been found mainly in southern coastal areas on a reduced number of plants; this suggests that the species might have been introduced recently. In Oceanic islands as Madeira free vacant niches and reduced competition are common features that can favour the establishment of invasive species. Thus, if this leafhopper were introduced recently, it would be expected to increase its food plant range and distribution subsequently. Although the flora of Madeira is different from that of the Mediterranean region, the potential risk of attacking new plants should be not underestimated. To become aware of which plants are more likely to be attacked in this new ecosystem, it is necessary to know the actual host plant range of this species. Because such data are greatly scattered, we compile here the published information on food plant associations, distribution and control. According to this information, A. decedens is widely distributed in the Palaearctic region and is associated with many cultivated plants. It has been recorded on sixty-one different plants species, of which 75% are present in Madeira. KEY WORDS: Hemiptera, leafhoppers, Asymmetrasca, Madeira, distribution, food plants, control. 1 Department of Biology, University of Madeira, Campus da Penteada, 9000-390 Funchal, Madeira, Portugal. -
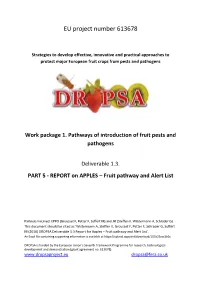
REPORT on APPLES – Fruit Pathway and Alert List
EU project number 613678 Strategies to develop effective, innovative and practical approaches to protect major European fruit crops from pests and pathogens Work package 1. Pathways of introduction of fruit pests and pathogens Deliverable 1.3. PART 5 - REPORT on APPLES – Fruit pathway and Alert List Partners involved: EPPO (Grousset F, Petter F, Suffert M) and JKI (Steffen K, Wilstermann A, Schrader G). This document should be cited as ‘Wistermann A, Steffen K, Grousset F, Petter F, Schrader G, Suffert M (2016) DROPSA Deliverable 1.3 Report for Apples – Fruit pathway and Alert List’. An Excel file containing supporting information is available at https://upload.eppo.int/download/107o25ccc1b2c DROPSA is funded by the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration (grant agreement no. 613678). www.dropsaproject.eu [email protected] DROPSA DELIVERABLE REPORT on Apples – Fruit pathway and Alert List 1. Introduction ................................................................................................................................................... 3 1.1 Background on apple .................................................................................................................................... 3 1.2 Data on production and trade of apple fruit ................................................................................................... 3 1.3 Pathway ‘apple fruit’ ..................................................................................................................................... -

Review of the New World Genera of the Leafhopper Tribe Erythroneurini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae)
Review of the New World Genera of the Leafhopper Tribe Erythroneurini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) Christopher H. Dietrich and Dmitry A. Dmitriev Illinois Natural History Survey Bulletin Volume 37, Article 5 July 2006 Illinois Natural History Survey, David L. Thomas, Chief A Division of the Illinois Department of Natural Resources Illinois Natural History Survey Distribution Office I-Building 1816 South Oak Street Champaign, IL 61820 Citation: Dietrich, C.H., and D.A. Dmitriev. 2006. Review of the New World genera of the leafhopper tribe Erythroneurini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocycbinae). Illinois Natural History Survey Bul- letin 37(5):119–190. Editor: Charles Warwick US ISSN 0073-4918 Printed by authority of the State of Illinois P0102370—.75M—07-06 Printed with soy ink on recycled and recyclable paper. Equal opportunity to participate in programs of the Illinois Department of Natural Resources (IDNR) and those funded by the U.S. Fish and Wildlife Service and other agencies is available to all individuals regardless of race, sex, national origin, disability, age, religion, or other non-merit factors. If you believe you have been discriminated against, contact the funding source’s civil rights office and/or the Equal Employment Opportunity Officer, IDNR, One Natural Resources Way, Spring- field, IL 62702-1271; 217/785-0067; TTY 217/782-9175. Review of the New World Genera of the Leafhopper Tribe Erythroneurini (Hemiptera: Cicadellidae: Typhlocybinae) Christopher H. Dietrich and Dmitry A. Dmitriev Illinois Natural History Survey Bulletin Volume 37, Article 5 July 2006 ACKNOWLEDGMENTS For lending specimens, we are grateful to Norman Penny (California Academy of Sciences), K.G.A. -

Fitohemijska Analiza I Antioksidantni Kapacitet Plodova Trešnje Inficiranih Gljivom Monilinia Laxa Aderh. I Ruhl
UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET AGRONOMIJA AGRONOMIJA Fitohemijska analiza i antioksidantni kapacitet plodova trešnje inficiranih gljivom Monilinia laxa Aderh. i Ruhl. - Doktorska disertacija - Mentor: prof. dr Đorđe Malenčić Kandidat: Boško Borković, dipl. inž. - master Novi Sad, 2018. godine Fitohemijska analiza i antioksidantni kapacitet plodova trešnje inficiranih gljivom Monilinia laxa Aderh i Ruhl, B. Borković ZAHVALNICA Neizmerno se zahvaljujem mentoru prof. dr Đorđu Malenčiću na velikoj podršci, strpljenju i razumevanju tokom izrade disertacije. Dr Biljani Kiprovski se zahvaljujem na velikom i nesebičnom zalaganju tokom celokupnog perioda doktorskih studija i izrade disertacije kako bi ona dobila poseban oblik. Prof. dr Veri Stojšin dugujem zahvalnost za angažovanje i izdvojeno vreme oko izrade fitopatološkog dela kao i na korisnim smernicama u izradi celokupne disertacije. Zahvalnost dugujem i prof. dr Dejanu Prvuloviću i doc. dr Mirjani Ljubojević na korisnim sugestijama tokom pisanja disertacije. Zahvaljujem se laborantima sa predmeta hemija i biohemija Gabrijeli Kšan, Ani Kuzmanović i Jeleni Savić na pomoći oko eksperimentalnog dela disertacije. Veliku zahvalnost dugujem kolegama sa Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine dr Renati Iličić i dr Mili Grahovac na smernicama i pomoći oko izrade fitopatološkog dela disertacije, laborantu Zoranu Bogdanoviću kao i koleginici dr Jovani Hrustić sa Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine iz Beograda na korisnim sugestijama. Hvala porodici, prijateljima i kolegama na podršci, ljubavi i razumevanju. Fitohemijska analiza i antioksidantni kapacitet plodova trešnje inficiranih gljivom Monilinia laxa Aderh i Ruhl, B. Borković UNIVERZITET U NOVOM SADU POLJOPRIVREDNI FAKULTET KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA Redni broj: RBR Identifikacioni broj: IBR Tip dokumentacije: Monografska dokumentacija TD Tip zapisa: Tekstualni štampani materijal TZ Vrsta rada (dipl., mag., dokt.): Doktorska disertacija VR Ime i prezime autora: dipl. -
A New Genus and Species in the Tribe Empoascini (Hemiptera, Cicadellidae, Typhlocybinae) from China
A peer-reviewed open-access journal ZooKeysA 386:new 85–91 genus (2014) and species in the tribe Empoascini (Hemiptera, Cicadellidae, Typhlocybinae)... 85 doi: 10.3897/zookeys.386.7020 RESEARCH articLE www.zookeys.org Launched to accelerate biodiversity research A new genus and species in the tribe Empoascini (Hemiptera, Cicadellidae, Typhlocybinae) from China Si-han Lu1,†, Dao-zheng Qin1,‡ 1 Key Laboratory of Plant Protection Resources and Pest Management of the Ministry of Education, Entomolo- gical Museum, Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China † http://zoobank.org/9E83703A-5EF6-4D4B-A4EF-DD500E40F7D6 ‡ http://zoobank.org/72814FDB-6F9B-4A56-B2F4-2DB95D631784 Corresponding author: Dao-zheng Qin ([email protected]) Academic editor: A. Sanborn | Received 12 January 2014 | Accepted 26 February 2014 | Published 7 March 2014 http://zoobank.org/397F49C0-0752-400A-BFA4-110DEB5678EE Citation: Lu S-h, Qin D-z (2014) A new genus and species in the tribe Empoascini (Hemiptera, Cicadellidae, Typhlocybinae) from China. ZooKeys 386: 85–91. doi: 10.3897/zookeys.386.7020 Abstract One new leafhopper genus, Circinans, is described with a new species Circinans striata sp. n. as the type species from southern China. Habitus photos and illustrations of male genitalia of this new species are given and differences between the new genus and closely related genera are discussed. Keywords Homoptera, Auchenorrhyncha, Cicadelloidea, new taxa, taxonomy Introduction The tribe Empoascini is a diverse group and differs from other leafhoppers in the sub- family Typhlocybinae in lacking an appendix in the forewing and in having a submar- ginal vein at the apex of the hindwing and veins RP, MP’ confluent distally (Dietrich 2005). -

A Comprehensive DNA Barcode Database for Central European Beetles with a Focus on Germany: Adding More Than 3500 Identified Species to BOLD
Molecular Ecology Resources (2015) 15, 795–818 doi: 10.1111/1755-0998.12354 A comprehensive DNA barcode database for Central European beetles with a focus on Germany: adding more than 3500 identified species to BOLD 1 ^ 1 LARS HENDRICH,* JEROME MORINIERE,* GERHARD HASZPRUNAR,*† PAUL D. N. HEBERT,‡ € AXEL HAUSMANN,*† FRANK KOHLER,§ andMICHAEL BALKE,*† *Bavarian State Collection of Zoology (SNSB – ZSM), Munchhausenstrasse€ 21, 81247 Munchen,€ Germany, †Department of Biology II and GeoBioCenter, Ludwig-Maximilians-University, Richard-Wagner-Strabe 10, 80333 Munchen,€ Germany, ‡Biodiversity Institute of Ontario (BIO), University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, Canada, §Coleopterological Science Office – Frank K€ohler, Strombergstrasse 22a, 53332 Bornheim, Germany Abstract Beetles are the most diverse group of animals and are crucial for ecosystem functioning. In many countries, they are well established for environmental impact assessment, but even in the well-studied Central European fauna, species identification can be very difficult. A comprehensive and taxonomically well-curated DNA barcode library could remedy this deficit and could also link hundreds of years of traditional knowledge with next generation sequencing technology. However, such a beetle library is missing to date. This study provides the globally largest DNA barcode reference library for Coleoptera for 15 948 individuals belonging to 3514 well-identified species (53% of the German fauna) with representatives from 97 of 103 families (94%). This study is the first comprehensive regional test of the efficiency of DNA barcoding for beetles with a focus on Germany. Sequences ≥500 bp were recovered from 63% of the specimens analysed (15 948 of 25 294) with short sequences from another 997 specimens. -

Elenco Delle Pubblicazioni Di Ermanno Malaspina
ERMANNO MALASPINA http://orcid.org/0000-0001-5604-895X Curriculum ed elenco delle pubblicazioni (aggiornamento al 20 VII 2020) CURRICULUM ATTIVITÀ DI RICERCA PUBBLICAZIONI • Edizioni, commenti e monografie Presso editori tra cui Pàtron, Utet, De Gruyter (Bibliotheca Teubneriana) • Curatele • Collaborazioni editoriali • Pubblicazioni informatiche ed on line • Articoli e rassegne In riviste nazionali (tra cui Aevum, Aevum Antiquum, Aufidus, Bollettino di Studi Latini, Rivista di Filologia e di Istruzione classica, Studi Urbinati, Antiquorum Philosophia) e internazionali (tra cui The Literary Encyclopedia, Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, Museum Helveticum, Oxford Bibliographies On Line, Revue d’Histoire des Textes, Vita Latina) ed in miscellanee presso editori nazionali (tra cui Le Monnier Università, Olschki) e internazionali (tra cui Brepols «Latinitates», Brill’s Companion, Entretiens Hardt, Garnier «Renaissance latine») • Cronache, presentazioni e recensioni In riviste nazionali (tra cui Aevum, Aufidus, Bollettino di Studi Latini, Res Publica Litterarum, Sileno) e internazionali (tra cui Bryn Mawr Classical Review, Exemplaria Classica, Gnomon, Latomus, Revue de Métaphysique et de Morale, Revue de Philologie) • Conferenze e relazioni a convegni DIDATTICA • Attività didattica universitaria • Editoria scolastica CURRICULUM 2 (escluse conferenze e relazioni a convegni) Ermanno Malaspina (Torino 1966) è Academicus ordinarius della Pontificia Academia Latinitatis, Direttore della nuova Collana di monografie Cicero. Studies -
Programma Salone
circo 10 scr iz io n i / 6 c o m u n esercizi commerciali che i espongono in vetrina la locandina Salone Off, «Io partecipo al Salone Off» offriranno sconti a chi si presenta Torino con il biglietto, abbonamento o pass del Salone, o con il coupon vista bene incluso nel programma cartaceo del Salone Off. Per la prima volta gli studenti del giornale online Bookblog Undicesima edizione per il del Salone Internazionale del Salone Off, il Salone del Libro Libro documenteranno con «diffuso», nato dall’intuizione di interviste, video, resoconti portare libri, autori e spettacoli giornalistici e contributi fuori dai padiglioni fieristici, tra audio i diversi appuntamenti, le vie e i quartieri di Torino, rendendoli disponibili a tutti nel centro e in periferia, e nei sul sito del Salone. E poi Comuni della provincia. Il debuttano i volontari: 50 Salone Off ha la missione di grande laboratorio culturale ragazzi delle scuole superiori valorizzare luoghi dal forte inclusivo e partecipato, una torinesi, coordinati da Torino significato sociale, storico, Torino (e non solo) vista bene in ReteLibri, che coadiuveranno gli ambientale e culturale: scuole, tutta la sua ricchezza di proposta organizzatori nella gestione di biblioteche, librerie, centri di e domanda di cultura. alcuni appuntamenti. quartiere, musei, teatri, ospedali, Saranno circa 200 i luoghi Il Salone Off è sostenuto case popolari, chiese, impianti che ospiteranno più di 500 dall’Assessorato alla Cultura sportivi, centri di protagonismo appuntamenti. In cartellone: e dalle dieci Circoscrizioni giovanile, botteghe, mercati, incontri con autori, reading, della Città di Torino: 1 (Centro, gallerie, strade, piazze, parchi e dibattiti, aperitivi letterari, Crocetta); 2 (Santa Rita, Mirafiori giardini. -

Full2004-4Spec
ORCHARD MANAGEMENT IN SUSTAINABLE FRUIT PRODUCTION Journal of Fruit and Ornamental Plant Research vol. 12, 2004 Special ed. INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN SWEET CHERRY (Prunus avium L.) ORCHARDS IN BULGARIA Hristina Kutinkova1 and Radoslav Andreev2 1 Fruit Growing Institute; kv. “Ostromila” 12, 4004 Plovdiv, BULGARIA e•mail: [email protected] 2 Agricultural University; 12, Mendeleev blvd., 4000 Plovdiv, BULGARIA e•mail: rado@au•plovdiv.bg (Received May 12, 2004/Accepted November 9, 2004) ABSTRACT Sweet cherry is one of the main fruit crops in Bulgaria. Effective control of insects and mites is necessary for high yield and fruit quality, yet contamination of the fruit and the environment should be avoided. A programme for integrated pest management designed for the needs of sweet cherry orchards in Bulgaria is proposed. Treatments for major cherry pests are suggested, taking into account the developmental stages and economic threshold values of particular species of insects and mites. Key words: sweet cherry, pests, integrated pest management, IPM, pest control INTRODUCTION Sweet cherry is a major fruit crop in Bulgaria. Cherries are the first fresh fruits available each year (Jivondov and Manolova, 2001). In Bulgaria, 7000 hectares are planted with cherries, and total cherry production is between 25,000 and 100,000 tons. Production of high quality cherries is impossible without effective pest and disease control. Environmental protection regulations and the disadvantages of using chemicals have prompted the development of environmentally friendly pest control methods. Consumers of sweet cherries and other stone fruits are justifiably concerned about the contamination of the fruit with pesticides. This H. Kutinkova and R.