Bologna E La Pittura*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Quadro Di Lucio Massari (1569
Il personaggio. L’ampia riflessione critica sulla Le note biografiche. Lucio Massari nasce a Bolo- pittura bolognese del periodo barocco, avvenuta gna il 22 gennaio 1569, nella parrocchia di S.Pro- in particolare tra il 1950 e il 1960, ha ampiamente colo, da Bartolomeo Massari e dalla sua prima riconsiderato l’arte pittorica di Lucio Massari e lo moglie Celidonia. La vivace intelligenza dimostrata ha definito un piccolo maestro di provincia (Carlo dal piccolo Lucio induce il padre ad affidarlo al Volpe, 1955). Questa rivalutazione rende giustizia pittore manierista Bartolomeo Passarotti (1529- della sottovalutazione che ne fecero critici e colle- 1592), pregandolo di insegnare al figlio a leggere ghi del suo tempo, influenzati sfavorevolmente e scrivere, e di avviarlo alla carriera artistica. dall'indolenza e irresolutezza che caratterizzarono Il giovane allievo si affeziona molto al suo mae- in negativo la personalità dell’artista. stro, e quando l’arte del Passarotti viene offuscata In tempi in cui nelle botteghe dei maestri barocchi dall’affermarsi a Bologna della grande pittura di si insegnava che composizione e decorazione dei Carracci, lo difen- l’arte non ammet- de strenuamente, e ingenuamente, senza accor- teva trascuratezza gersi della carica innovativa che questi ultimi stan- perchè era una ca- no portando nel pittura barocca della seconda ratteristica dei di- metà del ‘500. Superata l’acritica passionalità lettanti, ed era ne- giovanile, anche lo stesso Massari dovrà ricono- cessario dedicare scere la grandezza dei Carracci, e dopo la morte allo studio un im- del Passarotti si accosterà artisticamente a Ludo- pegno incondizio- vico Carracci e a suo cugino Annibale. -

The History of Painting in Italy, Vol. V
The History Of Painting In Italy, Vol. V By Luigi Antonio Lanzi HISTORY OF PAINTING IN UPPER ITALY. BOOK III. BOLOGNESE SCHOOL. During the progress of the present work, it has been observed that the fame of the art, in common with that of letters and of arms, has been transferred from place to place; and that wherever it fixed its seat, its influence tended to the perfection of some branch of painting, which by preceding artists had been less studied, or less understood. Towards the close of the sixteenth century, indeed, there seemed not to be left in nature, any kind of beauty, in its outward forms or aspect, that had not been admired and represented by some great master; insomuch that the artist, however ambitious, was compelled, as an imitator of nature, to become, likewise, an imitator of the best masters; while the discovery of new styles depended upon a more or less skilful combination of the old. Thus the sole career that remained open for the display of human genius was that of imitation; as it appeared impossible to design figures more masterly than those of Bonarruoti or Da Vinci, to express them with more grace than Raffaello, with more animated colours than those of Titian, with more lively motions than those of Tintoretto, or to give them a richer drapery and ornaments than Paul Veronese; to present them to the eye at every degree of distance, and in perspective, with more art, more fulness, and more enchanting power than fell to the genius of Coreggio. Accordingly the path of imitation was at that time pursued by every school, though with very little method. -

Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art
Athens Journal of Humanities & Arts - Volume 8, Issue 3, July 2021 – Pages 189-208 Li Pittori Parlano con l’Opere: Visualizing Poetry in Practice in Early Modern Italian Art By James Hutson* The relative sophistication of artists in the early modern era is contested, especially with regards to their educational backgrounds. On one hand, Dempsey-esque intellectual history is vested in touting the structured, literary curricula in art-educational institutions; while on the other, a complete rejection of the ‚artist-philosopher‛ as historical fiction seeks to undermine this hegemonic construct. This study argues that the lack of early formal education in the cases of artist like Annibale Carracci and Nicolas Poussin, who, unlike Peter Paul Rubens, did not have a firm foundation in the classics and languages that would allow them to engage directly with source material, would later be supplemented through their relationships with literary figures in the circles of Torquato Tasso, Giambattista Marino, and the Accademia dei Gelati. In addition to such relationships, informal exchanges, gatherings, and supplemental materials like Giovanni Paolo Gallucci’s Della Simmetria could be called upon when treating poetic subjects. With intimate knowledge of vernacular poetry, literati themselves participating in lectures and studio visits, and, finally, quick reference guides for subject matter, these artists were able to produce works that spoke to both poetic and artistic theory of the day, as one naturally informed the other. Introduction ‚Poets paint with words, painters speak with their works.‛1 This aphorism of Annibale Carracci (1560-1609) followed a superb rendering of the Laocoön in charcoal, expertly rendered from memory. -

Felsina Pittrice LIVES of the BOLOGNESE PAINTERS
CARLO CESARE MALVASIA’S Felsina pittrice LIVES OF THE BOLOGNESE PAINTERS Published for the Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington Harvey Miller Publishers An Imprint of Brepols Publishers THE FELSINA PITTRICE Count Carlo Cesare Malvasia’s Felsina pittrice, or Lives of the Bolognese Painters, first published in two volumes in Bologna in 1678, is one of the most important sources for the history and criticism of painting in Italy. Conceived in part as a response to Giorgio Vasari’s Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550/1568), the Felsina pittrice combines close observation with documentary history, and careful analysis with polemical debate. It offers the fullest account of Bolognese artists from Simone dei Crocefissi to Prospero and Lavinia Fontana, from Guercino to Elisabetta Sirani. The Carracci are treated as a family of artists, and their school (including Guido Reni, Domenichino, and Francesco Albani, among others) is documented by Malvasia in far greater detail than by any other biographer. The great art historian Luigi Lanzi (1732- 1810) said that no other school in Italy had been described by a more capable pen, and he considered the two volumes of the Felsina pittrice to be “a treasure of the most beautiful knowledge gathered from the pupils of the Carracci, whom Malvasia knew, and who helped him in this work, which was, however, accused of sometimes burning with an excessively patriotic zeal.” 2. THE CRITICAL EDITION Accusations of excessive passion for his local school, combined with unjustified charges of forgery and unreliability, have for centuries clouded the reception and understanding of Malvasia’s extraordinarily important text, which was last edited and published in 1841-44. -

Reconsidering Center-Periphery Pedagogy
Art and Design Review, 2019, 7, 150-173 http://www.scirp.org/journal/adr ISSN Online: 2332-2004 ISSN Print: 2332-1997 Le Accademie Bolognese e Romana: Reconsidering Center-Periphery Pedagogy James Hutson Art History Department, Lindenwood University, St. Charles, MO, USA How to cite this paper: Hutson, J. (2019). Abstract Le Accademie Bolognese e Romana: Recon- sidering Center-Periphery Pedagogy. Art and This article seeks a reevaluation of the relationship between the Carracci Ac- Design Review, 7, 150-173. cademia degli’Incamminati and the Accademia di San Luca in Rome with re- https://doi.org/10.4236/adr.2019.73014 gards to structure, goals and pedagogy. For although the perceived pedagogi- Received: July 13, 2019 cal goals of the Carracci, especially the prosaic Annibale, and the most Accepted: August 9, 2019 well-known Scholastic academician associated with the Roman Accademia, Published: August 12, 2019 Federico Zuccaro, have traditionally been viewed as conflicting, the early his- tory of the academy in Rome can be seen to parallel the Bolognese. Each was Copyright © 2019 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. established to address the uncertain and evolving nature of the profession This work is licensed under the Creative seen in each city, leading to a demand for a new type of educational institu- Commons Attribution International tion for the studiosi giovani; the curricula developed were designed to meet License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ the new andragogical challenges of these new “open” art academies; and, fi- Open Access nally, their foundations were designed with reformatory goals in mind due to their association with the same educatori riformanda. -
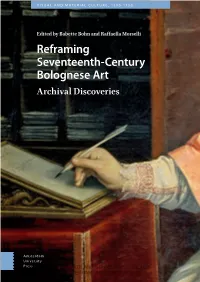
Observing Protest from a Place
VISUAL AND MATERIAL CULTURE, 1300-1700 Bohn & Morselli (eds.) Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Reframing Seventeenth-CenturySeventeenth-century Bolognese Art Archival Discoveries Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Bolognese Seventeenth-Century Reframing FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Visual and Material Culture, 1300–1700 A forum for innovative research on the role of images and objects in the late medieval and early modern periods, Visual and Material Culture, 1300–1700 publishes monographs and essay collections that combine rigorous investigation with critical inquiry to present new narratives on a wide range of topics, from traditional arts to seemingly ordinary things. Recognizing the fluidity of images, objects, and ideas, this series fosters cross-cultural as well as multi-disciplinary exploration. We consider proposals from across the spectrum of analytic approaches and methodologies. Series Editor Dr. Allison Levy, an art historian, has written and/or edited three scholarly books, and she has been the recipient of numerous grants and awards, from the National Endowment for the Humanities, the American Association of University Women, the Getty Research Institute, the Dumbarton Oaks Research Library of Harvard University, the Whiting Foundation and the Bogliasco Foundation, among others. www.allisonlevy.com. FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Reframing Seventeenth-Century Bolognese Art Archival Discoveries Edited by Babette Bohn and Raffaella Morselli Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Guido Reni, Portrait of Cardinal Bernardino Spada, Rome, Galleria Spada, c. -
103-Santa Maria Della Concezione
Santa Maria della Concezione dei Cappuccini The church of Our Lady of the Conception of the Capuchins is a 17th century convent church on Via Vittorio Veneto, close to Piazza Barberini, in the modern rione Ludovisi (part of the historic Rione Colonna). The church is also known as Santa Maria Immacolata (Our Lady the Immaculate) and Chiesa dei Cappuccini (Church of the Capuchins). Capuchin church dedication is to the Blessed Virgin Mary, under her aspect of the Immaculate Conception. This is the first church in Rome with this particular dedication, for the Franciscan Friars Minor Capuchin (for whom it was built) were fervent proponents of the doctrine before it became a dogma. [1] [2] History The Capuchins are a Franciscan order, founded by Matteo da Bascio in 1525, when he set out to return the Franciscans to an exact interpretation of the Rule of St Francis. Their distinguishing characteristics of beards (which were not allowed to be trimmed) and a the wearing of a separate little hood called the capuce (hence the name) derived from the Camaldolese monks, who helped to defend the infant reform movement. [1] In the second half of the 16th century, Pope Gregory XIII granted the church of San Niccolò di Portiis, the present Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi, to the nascent Capuchins, and they erected their first purpose-built friary in Rome here. A new church was constructed in 1575 just to the west of the old one, with the apse abutting onto its former façade. This arrangement looks as if the friars used the old church as their choir chapel, as an identical arrangement occurs in many other Roman convents including their future church of Santa Maria della Concezione. -

I Bolognesi a Ferrara: Dai Carracci Ad Antonio Randa
www.museoinvita.it numero 1/2015 www.museoinvita.it/benati-bolognesi-a-ferrara/ I bolognesi a Ferrara: dai Carracci ad Antonio Randa Daniele Benati Il titolo di questa conferenza potrà apparire netto e forse curioso: I bolognesi a Ferrara: dai Carracci ad Antonio Randa. Se i Carracci sono notissimi, non altrettanto si può dire di Antonio Randa. Questo itinerario non è però scelto a caso. Esso parte da una constatazione che va un po’ controcorrente rispetto a quella che è la dimensione finora acquisita dagli studi, la quale tende ad accreditare a Ferrara nel Seicento un ruolo marginale come centro di produzione artistica. Il titolo di questa conferenza potrà forse apparire curioso: I bolognesi a Ferrara: dai Carracci ad Antonio Randa. Se i Carracci sono notissimi, non altrettanto si può dire di Antonio Randa. Questo itinerario non è però scelto a caso. Esso parte da una constatazione che va un po’ controcorrente rispetto a quella che è la dimensione finora acquisita dagli studi, la quale tende ad accreditare a Ferrara nel Seicento un ruolo marginale come centro di produzione artistica. Nell’immaginario collettivo Ferrara è una città dai molti aspetti, quasi caleidoscopica: è infatti nello stesso tempo la città rinascimentale per eccellenza ma anche la città della “deserta bellezza” cantata da D’Annunzio; la città di Lucrezia Borgia, ma anche quella cupa e asciutta dell’epoca delle Legazioni. Il libro molto bello di Eugenio Riccòmini del 1969, Seicento ferrarese, ci consegnava in modo assai suggestivo l’immagine di una città che, a seguito del passaggio sotto lo Stato della Chiesa, era diventata marginale, addirittura una specie di distaccamento periferico di guarnigione. -

INCONTRO CON LA PITTURA 24 Fondantico Di Tiziana Sassoli Via De’ Pepoli, 6/E - 40125 Bologna Tel
INCONTRO CON LA PITTURA 24 Fondantico di Tiziana Sassoli Via de’ Pepoli, 6/E - 40125 Bologna Tel. e Fax 051.265.980 [email protected] www.fondantico.it Restauro e revisione dei dipinti: Liliana e Rodolfo Giangrossi, Milano; Giovanni Pigoni e Davide Tirelli, Reggio Emilia; Licia Tasini, Pieve di Cento (Bologna). Segreteria e ufficio stampa: Maria Cristina Porpora Coordinamento redazionale: Edoardo Battistini © Fondantico - ottobre 2016 Fondantico arte e antiquariato ITINERARI D’ARTE Dipinti e disegni dal XIV al XIX secolo Catalogo a cura di Daniele Benati Testi di Daniele Benati Alessandro Brogi Giacomo A. Calogero Gianluca Del Monaco Massimo Francucci Federico Giannini Irene Graziani Fabio Massaccesi Milena Naldi Anna Ottani Cavina Tommaso Pasquali Elisabetta Sambo Matteo Solferini 4 NOVEMBRE - 23 DICEMBRE 2016 er il ventiquattresimo “Incontro con la pittura” Fondantico ha raccolto una scelta insolitamente ampia di dipinti e disegni, il cui nucleo più corposo P è costituito, secondo la tradizione ormai trentennale della galleria, dagli antichi maestri emiliani. La passione per l’arte e la ricerca, svolta tra importanti collezioni private e aste di tutto il mondo, ha reso possibile una mostra che conta ben trentatré autori e quarantatré opere che spaziano dal Trecento all’Ottocento: da qui il titolo scelto di “Itinerari d’arte”. Il consueto appuntamento autunnale, atteso da collezionisti e appassionati d’arte, si apre con un prezioso trittico del bolognese Simone dei Crocifissi e una Madonna dell’umiltà di Antonio Orsini, protagonista del tardogotico a Ferrara. Ben rappresentati sono il Cinquecento e il Seicento felsinei: quest’ultimo anche grazie alla presenza di due capiscuola come Guido Reni, di cui si espone un’intensa Lucrezia, e il Guercino, al quale spetta un toccante San Giuseppe col Bambino. -

Santa Maria Della Concezione Dei Cappuccini
Santa Maria della Concezione dei Cappuccini The church of Our Lady of the Conception of the Capuchins is a 17th century convent church on Via Vittorio Veneto, close to Piazza Barberini, in the modern rione Ludovisi (part of the historic Rione Colonna). The church is also known as Santa Maria Immacolata (Our Lady the Immaculate) and Chiesa dei Cappuccini (Church of the Capuchins). Capuchin church dedication is to the Blessed Virgin Mary, under her aspect of the Immaculate Conception. This is the first church in Rome with this particular dedication, for the Franciscan Friars Minor Capuchin (for whom it was built) were fervent proponents of the doctrine before it became a dogma. [1] [2] History The Capuchins are a Franciscan order, founded by Matteo da Bascio in 1525, when he set out to return the Franciscans to an exact interpretation of the Rule of St Francis. Their distinguishing characteristics of beards (which were not allowed to be trimmed) and a the wearing of a separate little hood called the capuce (hence the name) derived from the Camaldolese monks, who helped to defend the infant reform movement. [1] In the second half of the 16th century, Pope Gregory XIII granted the church of San Niccolò di Portiis, the present Santa Croce e San Bonaventura dei Lucchesi, to the nascent Capuchins, and they erected their first purpose-built friary in Rome here. A new church was constructed in 1575 just to the west of the old one, with the apse abutting onto its former façade. This arrangement looks as if the friars used the old church as their choir chapel, as an identical arrangement occurs in many other Roman convents including their future church of Santa Maria della Concezione. -

Catalogo Delle Pitture Della Regia Galleria
Fondazione Memofonte onlus Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche ___________________________________________________________________________________________ 1775-1792 CATALOGO DELLE PITTURE DELLA R. GALLERIA COMPILATO DA GIUSEPPE BENCIVENNI GIÀ PELLI DIRETTORE DELLA MEDESIMA * PARTE I CORRIDORI c. 2 Indice Quadri dei corridori, numero 135 - della Stanza d’Amore, 28 - della Tribuna, 25 - della prima Stanza dei quadretti fiamminghi, 145 - della seconda Stanza, 209 - del Gabinetto delle medaglie, 34 - della Stanza dell’Emafrodito, 48 - della Sala della Niobe, 4 - ritratti dei pittori - ritratti di Uomini illustri numero 628 [Di questo Catalogo esistono due redazioni (ABU, ms. 463 ins. 10 e ins, 4); la trascrizione qui pubblicata presenta la prima versione integrata con le rare varianti espresse in parentesi tonda e testo corsivo. Le annotazioni a margine sono invece precedute dall’asterisco. La sezione dei manufatti antichi (sculture, iscrizioni, sarcofagi ecc.) esiste solo nella seconda redazione e qui integralmente trascritta]. c. 4 Indice Parte I a Quadri dei corridori Parte II a Quadri del Gabinetto delle monete e medaglie moderne - della Stanza di Amore - del Gabinetto delle miniature ______________________________________________________________________________________________ www.memofonte.it Fondazione Memofonte onlus Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche ___________________________________________________________________________________________ - della Tribuna - del Gabinetto dei disegni - della prima Stanza dei quadri fiamminghi - della 2 a Stanza dei medesimi Parte III a Quadri del Gabinetto delle medaglie Collezione dei Ritratti de’ pittori Quadri della Stanza dell’Ermafrodito - della Sala di Niobe - del Gabinetto delle pitture antiche Appendice L’indice dei pittori è in un volume in 4° a parte. c. 5 Prefazione * Ho fatto un discorso a parte sopra la pittura da servire d’introduzione al presente catalogo ed è indirizzato in forma di lettera al .. -

ATINER's Conference Paper Series ART2015-1520
ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2014-1176 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series ART2015-1520 Hercules and Rinaldo: Annibale Carracci’s Invenzione of Tasso’s Epic Hero Esthy Kravitz-Lurie PhD Candidate Department of Art Ben-Gurion University Israel 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ART2015-1520 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. This paper has been peer reviewed by at least two academic members of ATINER. Dr. Gregory T. Papanikos President Athens Institute for Education and Research This paper should be cited as follows: Kravitz-Lurie, E. (2015). "Hercules and Rinaldo:Annibale Carracci’s Invenzione of Tasso’s Epic Hero", Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: ART2015-1520. Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. All rights reserved. Reproduction is allowed for non-commercial purposes if the source is fully acknowledged. ISSN: 2241-2891 17/07/2015 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: ART2015-1520 Hercules and Rinaldo: Annibale Carracci’s Invenzione of Tasso’s Epic Hero Esthy Kravitz-Lurie PhD Candidate Department of Art Ben-Gurion University Israel Abstract This paper discusses Annibale Carracci’s formation of Rinaldo, Tasso’s epic hero, in his rendition of the scene in which he is subjugated to Armida’s love in her enchanted palace.