Costruzioni Teatrali Dell'alfieri
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Best Entertainment in Turin"
"Best Entertainment in Turin" Created by: Cityseeker 6 Locations Bookmarked Royal Theater of Turin "Tradition & Prestige" The idea of building the Teatro Regio Torino started in 1713 when the Duke of Savoy became the King of Piedmont, but they had to wait until 1738 before any work began. Designed by Filippo Juvarra, it was built by Benedetto Alfieri and opened to the public in 1749. A fire in 1936 and bombings during World War II destroyed the Regio, which was then rebuilt by Dario Crespi with a plan by the architect Carlo Molino and the engineer Marcello Zavelani-Rossi in 1966, and reopened in 1973. There is a large plaque on the ground at the entrance to the theater which has the dates 1740-1973 engraved in Roman numerals. The Baroque style is luxurious and perfectly suited to a theater which offers the most famous operas in the world. +39 011 881 5557 www.teatroregio.torino.it/ [email protected] Piazza Castello 215, Giardino en Reale, Turin Teatro Carignano "The Oldest Theater in Turin" The stage in this theater dates from the end of the eighteenth century, which lends it an enviable prestige, which is further enhanced by its extraordinary central position, dominating the whole of Piazza Carignano, one of the most elegant squares in Turin. It is now home to the Stabile of Turin, founded in 1955, one of the most prestigious public theatres, with a by Marco Plassio wide choice of shows from the best directors with excellent performances by the best Italian actors. +39 011 517 6246 www.teatrostabiletorino.it Piazza Carignano 6, Turin Il Circolo dei Lettori "Entertainment, Events and Regional Cuisine" Housed in the beautiful 17th century Palazzo Graneri della Roccia, Il Circolo dei Lettori is a dynamic space for events like book launches, readings, workshops and more. -

SUGGESTIONS for POSSIBLE SHORT TRIPS to Get An
SUGGESTIONS FOR POSSIBLE SHORT TRIPS To get an introduction about the area near the conference: Why You Really Should Visit Italy's Outstanding Barolo Wine Region https://www.forbes.com/sites/catherinesabino/2018/10/28/why-you-really-should-visit-italys- outstanding-barolo-wine-region/#7bd3de632f89 Note that the Langa district is best visited by car. Because of its territory, the district is not accessible by train (except for Alba, which is connected to the railway system). However, driving in the Langa district should not be a problem since it is in the countryside and not in a big city. For reference, Bra and Alba have ~30,000 people each. Some of the villages referenced below are much smaller: Pollenzo (a subdivision of Bra) and Barolo have only ~700 people. Furthermore, besides the picturesque hills and the historic castles and buildings, this area is also about food and wine. So you can pair some of the suggestions below with the restaurant suggestions also available on the conference website. There are also several wine tours that are normally organized in the area and, besides the suggestions below, you can just search online for what suits your interest. 1) Tour of the Barolo Langa district: Barolo, La Morra, and Verduno Note: Requires a car. Also, distances are short and so one can break these itineraries into smaller ones as desired. Barolo (https://en.wikipedia.org/wiki/Barolo,_Piedmont) is the town in the middle of the vineyards of nebbiolo grapes that produce the famous wine of the same name. It is a medieval village developed at the foot of the castle. -

BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 Bilancio Di Esercizio 2006
FONDAZIONE DI TORINO BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 Bilancio di Esercizio 2006 FONDAZIONE DI TORINO BILANCIO DI ESERCIZIO 2006 FONDAZIONE DI TORINO Sovrintendente Walter Vergnano Consiglio d’Amministrazione Presidente Sergio Chiamparino Sindaco della Città di Torino Vicepresidente Giovanni Zanetti Consiglieri Evelina Christillin Maria Luisa Cosso Elsa Fornero Maria Luisa Pacciani Vittorio Sette Walter Vergnano Sovrintendente Segretario Franco Ferrari Collegio dei Revisori dei Conti Presidente Nadia Ribaudo Revisori Paola Martinelli Luigi Puddu Società di revisione Pitagora Revisione S.r.l. ALBO DEI FONDATORI STATO ITALIANO AZIENDE METROPOLITANE DEL COMUNE DI TORINO Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino SpA Gruppo Torinese Trasporti SpA Società Metropolitana Acque Torino SpA Sostenitori della Fondazione associati all’Unione Industriale di Torino: Autostrada Torino Milano SpA, Carrozzeria Bertone SpA, Cartiere Burgo SpA, Carpano SpA, CSP SpA, Ergom Automotive SpA, Ferrero SpA, Luigi Lavazza SpA, Manifattura Tessile di Nole SpA, Martini & Rossi SpA, Newfren SpA, Pininfarina SpA, Prisma SpA, Sagat - Turin Airport, Gruppo Comital Saiag SpA, SKF Industrie SpA. ADERENTI ALLA FONDAZIONE CIET Srl Tenuta La Fiammenga Unioncamere Piemonte circoli e associazioni Lions Club Torino Regio PARTNERS SOSTENITORI Alcatel Alenia Space Montblanc BENEMERITI DELLA FONDAZIONE Vittorio Bertone Gianfranco Carbonato Francesca Cilluffo Pietro Fraire Gianluigi Frigerio Antonio Maria Marocco Sergio Merlo Max Pellegrini -

TORINO - 80 - 18/06/11 - Pag
Pagina Fisica: LASTAMPA - TORINO - 80 - 18/06/11 - Pag. Logica: LASTAMPA/CRONACA/29 - Autore: MASMAN - Ora di stampa: 17/06/11 21.24 T1 T2 PR CV LA STAMPA 80 Dove andiamo SABATO 18 GIUGNO 2011 U BRONSON eletto, il nuovo Pontefice entra in IL RAGAZZO CON LA .... 90 minuti. Uscito dal carcere, il guar- ··· Azione. Regia di Nicolas Win- crisi in quanto si ritiene inadatto al ··· Drammatico. Regia di Jean-Pier- diano notturno Alì si dedica alla sua ding Refn, con Tom Hardy e Kelly La classifica dei film più visti ruolo: interviene uno psicanalista. re e Luc Dardenne, con Jérémie Renier famiglia: durante uno scontro tra Adams. Durata: 92 minuti. La sto- LIBERA USCITA e Cécile De France. Durata: 87 minuti. polizia e manifestanti a Teheran la ria vera di Michael Gordon Peter- ·· Commedia. Regia di Bobby e Pe- Il dodicenne Cyril viene messo dal pa- moglie viene uccisa, lui si vendica. son, il detenuto più violento delle ter Farrelly, con Owen Wilson e Ja- dre in un centro di accoglienza per Produzione iraniana. carceri inglesi. son Sudeikis. Durata: 105 minuti. l’infanzia: durante una fuga, incontra TUTTI PER UNO I film CORPO CELESTE Per rivitalizzare i loro matrimoni, una parrucchiera che si prende cura ··· Drammatico. Regia di Romain ··· Drammatico. Regia di Alice due mogli concedono ai mariti una di lui. Dagli autoridi «Rosetta». Goupil, con Valeria Bruni Tedeschi e Rohrwacher, con Yle Vianello e settimana di totale libertà. Dai cine- RED Linda Doudaeva. Durata: 90 minuti. Mi- Salvatore Cantalupo. Durata: 98 asti di «Tutti pazzi per Mary». -

UNIVERSITY of CALIFORNIA RIVERSIDE Guarino
UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Guarino Guarini: His Architecture and the Sublime A Thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Master of Arts in Art History by Carol Ann Goetting June 2012 Thesis Committee: Dr. Kristoffer Neville, Chairperson Dr. Jeanette Kohl Dr. Conrad Rudolph Copyright by Carol Ann Goetting 2012 The Thesis of Carol Ann Goetting is approved: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Committee Chairperson University of California, Riverside ACKNOWLEDGMENTS This thesis would not be possible without the financial support of the University of California, Riverside and the Gluck Fellows Program of the Arts which enabled me to conduct primary research in Italy. Words cannot express enough the gratitude I feel towards my advisor Dr. Kristoffer Neville whose enthusiasm, guidance, knowledge and support made this thesis a reality. He encouraged me to think in ways I would have never dared to before. His wisdom has never failed to amaze me. I was first introduced to the work of Guarino Guarini in his undergraduate Baroque Art class, an intriguing puzzle that continues to fascinate me. I am also grateful for the help and encouragement of Drs. Conrad Rudolph and Jeanette Kohl, whose dedication and passion to art history has served as an inspiration and model for me. I am fortune to have such knowledgeable and generous scholars share with me their immense knowledge. Additionally, I would like to thank several other faculty members in UCR’s History of Art department: Dr. Jason Weems for giving me an in-depth understanding of the sublime which started me down this path, Dr. -

L'offerta Culturale Di Torino E I Progetti Avviati, Alla Conclusione Del Mandato Nel Giugno 2011. Arte Antica Il Museo Egizio In
L'offerta culturale di Torino e i progetti avviati, alla conclusione del mandato nel giugno 2011. Arte antica Il Museo Egizio in occasione delle Olimpiadi del 2006 è stato rinnovato nel suo statuario con l'intervento di Dante Ferretti. All'inizio del 2015 verrà inaugurato il nuovo Museo, raddoppiato nello spazio espositivo (progetto Aimaro Isola), arricchito di tutti i servizi di un moderno museo e riallestito dallo stesso Dante Ferretti. Sarà il museo di antichità egizie più suggestivo del mondo. La Galleria Sabauda, pinacoteca di arte antica ricca soprattutto di capolavori fiamminghi, si sta spostando dalla sede storica che si trovava ai piani superiori del Museo Egizio, alla manica nuova di Palazzo Reale. Anch'essa sarà ultimata per l'inizio del 2015. Il Polo Reale (una sorta di Ermitage) comprende in un unico percorso di visita il Museo di Archeologia (con una nuova ala dedicata alla Torino romana), la nuova Galleria Sabauda, il Palazzo Reale, l'Armeria Reale, la Biblioteca Reale (con l'autoritratto di Leonardo da Vinci e altri 12 suoi disegni), Palazzo Chiablese (dove vi saranno le biglietterie e i servizi per tutto il Polo), i Giardini Reali. Nello stesso sistema edilizio, al di là della Prefettura, si trova l'Archivio di Stato di eccezionale bellezza e ricchezza. Il Museo Civico di Arte Antica di Palazzo Madama (edificio che testimonia 2000 anni di storia, con porta romana incorporata, castello medioevale dei D'Acaja, facciata barocca-neoclassica di Filippo Juvarra) contiene sezioni di arte gotica, rinascimentale, barocca, ampio spazio dedicato all'arte decorativa (soprattutto porcellane) e giardino medioevale. La città romana comprende la Porta Palatina (la meglio conservata al mondo) e il teatro romano. -
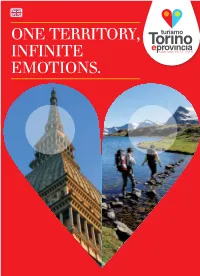
One Territory, Infinite Emotions
www.turismotorino.org ONE TERRITORY, TORINO • Piazza Castello/Via Garibaldi INFINITE • Piazza Carlo Felice • International Airport (interactive totem) Contact centre +39.011.535181 [email protected] EMOTIONS. BARDONECCHIA Piazza De Gasperi 1 +39.0122.99032 [email protected] CESANA TORINESE Piazza Vittorio Amedeo 3 +39.0122.89202 [email protected] CLAVIÈRE Via Nazionale 30 +39.0122.878856 [email protected] IVREA Piazza Ottinetti +39.0125.618131 [email protected] PINEROLO Viale Giolitti 7/9 +39.0121.795589 [email protected] PRAGELATO Piazza Lantelme 2 +39.0122.741728 [email protected] SAuze d’OULX Viale Genevris 7 +39.0122.858009 [email protected] SESTRIERE Via Louset +39.0122.755444 [email protected] SUSA Corso Inghilterra 39 +39.0122.622447 [email protected] A CITY YOU City Sightseeing Torino is a valuable ally in your time spent WOULDN’T EXPECT in Torino. By means of this “panoramic” double-decker bus you will be able to discover the city’s many souls, travelling on two lines: “Torino City Centre” and If you decide to stay in Torino “Unexpected Torino”. You can’t get more or the surrounding areas for your convenient than that… holiday, our Hotel & Co. service lets www.turismotorino.org/en/citysightseeing you reserve your stay at any time directly online. Book now! ot www.turismotorino.org/en/book .turism orino.o ww rg/ w en Lively and elegant, always in movement, nonetheless Torino is incredibly a city set in the heart of verdant areas: gently resting on the hillside and enclosed by the winding course of the River Po, it owes much of its charm to its enchanting location at the foot of the western Alps, watched over by snowy peaks. -

Il "Vivavoce Tour" Di Francesco De Gregori Si Arricchisce Di Nuove
GIOVEDì 5 FEBBRAIO 2015 Dal 20 marzo Francesco De Gregori sarà in tour nei palasport e nei teatri di tutta Italia con "Vivavoce Tour", spettacolo con cui l'artista presenterà live "Vivavoce", accompagnato dalla sua band formata da Guido Il "Vivavoce Tour" di Francesco De Guglielminetti (basso e contrabbasso), Paolo Giovenchi (chitarre), Lucio Gregori si arricchisce di nuove Bardi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), date ad Avellino, Ferrara, Bassano Alessandro Arianti (hammond e piano), Stefano Parenti (batteria), Elena del Grappa e Bolzano Cirillo (violino e cori), Giorgio Tebaldi (trombone), Giancarlo Romani (tromba) e Stefano Ribeca (sax). Parte il 20 marzo dal PalaLottomatica di Roma Queste le date ad oggi confermate del "Vivavoce Tour": 20 marzo: ROMA - PalaLottomatica LA REDAZIONE 23 marzo: MILANO-ASSAGO - Mediolanum Forum 25 marzo: FIRENZE - Nelson Mandela Forum [email protected] 27 marzo: PORDENONE - Pala Forum SPETTACOLINEWS.IT 28 marzo: BOLOGNA - Unipol Arena 3 aprile: NAPOLI - Pala Partenope 19 aprile: CESENA - Nuovo Teatro Carisport 20 aprile: ANCONA - Teatro Delle Muse 23 aprile: AVELLINO - Teatro Carlo Gesualdo - NUOVA DATA 24 aprile: BARI - Teatro Team 27 aprile: PALERMO - Teatro Politeama 28 aprile: CATANIA - Teatro Metropolitan 30 aprile: CATANZARO - Pala Gallo 6 maggio: CREMONA - Teatro Ponchielli 9 maggio: MANTOVA - Gran Teatro Palabam Pag. 1 / 2 12 maggio: FERRARA - Teatro Comunale - NUOVA DATA 13 maggio: BRESCIA - Pala Banco 14 maggio: BERGAMO - Teatro Creberg 16 maggio: PARMA - Teatro Regio 19 maggio: REGGIO EMILIA - Teatro Romolo Valli 20 maggio: TORINO - Teatro Colosseo 23 maggio: SANREMO (Imola) - Teatro Ariston 25 maggio: GENOVA - Teatro Carlo Felice 26 maggio: VARESE - Teatro di Varese 28 maggio: BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) - Palasport - NUOVA DATA 29 maggio: BOLZANO - Palasport Bolzano (via Resia) - NUOVA DATA Pag. -

The Versailles Opéra Nancy R
The Versailles Opéra Nancy R. Rivers Before the middle of the eighteenth century innovations opera house design in Western Europe. Yet most architectural in the realm of opera house design in France had been rela- historians today are only vaguely familiar with the innovative tively modest. Voltaire first decried the inadequacy of French components that Gabriel integrated within its interior design. theater design in 1749.1 In his L’Architecture françoise of 1752 Distinguished scholars have laid a historical foundation Jacques-François Blondel also disparagingly compared the that enables one to understand the socio-political context in designs of theaters and opera houses in France to those of which the Versailles Opéra was created.3 There is currently, Italy, calling for striking reforms in theater architecture however, no scholarly publication that adequately conveys the throughout France.2 Several architects responded to his call, significance of Gabriel’s final design for the Opéra, leaving inaugurating significant innovations in French opera house readers with an incomplete understanding of his accomplish- design between the years 1753 and 1790. One of these was ments there. Missing are an explanation of Gabriel’s choice Ange-Jacques Gabriel (1698-1782), who constructed the Opéra for the truncated oval plan and a consideration of the indi- at Versailles (Figure 1). Born into one of the leading architec- vidual elements incorporated into the interior design that had tural dynasties in France, Gabriel was a descendant of the an impact upon the structure as a whole. Gabriel’s inclusion renowned seventeenth-century French classical architect of these elements demonstrates his knowledge of Italian the- François Mansart. -

(Museo Nazionale Del Risorgimento) Giardini Reali Palazzo Madama
home page > luoghi > ...visitare Palazzo Reale Torino, Piazzetta Reale 1 È la prima e la più importante tra le residenze sabaude del Piemonte, teatro della politica del regno sabaudo per almeno tre secoli, il Palazzo Reale di Torino è collocato nel cuore della città, nella centralissima piazza Castello, da cui si diramano le principali arterie del centro storico: via Po, via Roma, via Garibaldi e via Pietro Micca. Palazzo Carignano (Museo Nazionale del Risorgimento) Torino, Via Accademia delle Scienze 51 Palazzo Carignano, progettato nella seconda metà del Seicento da Guarino Guarini, è un edificio storico situato nel centro di Torino ed è considerato da sempre uno dei più pregevoli esempi di Barocco europeo. Insieme a Palazzo Reale e a Palazzo Madama fa parte dei più importanti edifici storici della città. Giardini Reali Torino, Piazza Castello 189 Si trovano dietro Palazzo Reale e terminano in corso san Maurizio. Si accede ad essi da Piazza Castello, passando per l'ingresso di Palazzo Reale. Furono progettati nel 1697 da André Le Nôtre, “padre” del parco di Versailles. Palazzo Madama Torino, Piazza Castello 19 Sito nel cuore di Torino, in quello che doveva essere il castrum romano (ovvero il centro geografico della città), Palazzo Madama sorge su quella che, al tempo dell'antica Roma, era chiamata Porta Decumana. Agli inizi del I secolo qui si aveva la via d'accesso alla città dal lato del fiume Po, che andava, per la sua strategica posizione, difesa accuratamente: dopo la caduta dell'Impero Romano, la porta venne trasformata in un forte, atto alla difesa cittadina. Palazzo dell'Accademia delle Scienze (Museo Egizio - Galleria Sabauda) Torino, Via Accademia delle Scienze 6 Il Palazzo dell'Accademia delle Scienze è un imponente edificio seicentesco. -

Programme and Tours Connections Between Teatro Regio Castello Del Valentino Torino Esposizioni and Circolo Eridano
EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK THIRD INTERNATIONAL MEETING PROGRAMME AND TOURS CONNECTIONS BETWEEN TEATRO REGIO CASTELLO DEL VALENTINO TORINO ESPOSIZIONI AND CIRCOLO ERIDANO Bus Stop PO Bus Stop n. Marconi 18 Bus Stop n. Donizetti 18 EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK THIRD INTERNATIONAL MEETING PROGRAMME AND TOURS Welcome to the Third International EAHN Meeting in Turin After the two successful International Meetings in Guimarães (2010) and Brussels (2012), we are now gathering in Turin for our Third International Conference. Turin, “the nicest village in the world” for Montesquieu, “one-company town” for so many 20th-century observers, has many histories that can speak for it. In the last fifteen years, Turin’s cultural offer and its tourist accommodation capacity have widely increased. The city is reorganizing its economic identity also by promoting and being host to an array of cul- tural activities, exhibitions and conventions related to the cultural heritage, considered in its broad range of artistic, architectural, environmental as- sets and resources. World-famous events have reshaped Turin’s public im- age. The Winter Olympic Games (2006), the exhibition of the Holy Shroud (2010), and the celebrations of the 150th anniversary of the Unification of Italy (2011), put much energy into the connection between mega-events and cultural elaboration, through an extensive programme of exhibitions, historic symposia and thematic itineraries. Turin is home to a lively community of historians and has attracted the inter- est of architectural and urban historians during most of the 20th century. The city’s baroque architecture gained the early attention of scholars such as Albert Erich Brinckmann, who in 1931 dedicated to Turin and Pied- mont his book Theatrum novum Pedemontii: Ideen, Entwürfe und Bauten von Guarini, Juvarra, Vittone. -

I CONCERTI DI MAGGIO Sul Palco Dello Sferisterio Rispettivamente Il 20 E Il 21 Giugno
Articles I CONCERTI DI MAGGIO Sul palco dello Sferisterio rispettivamente il 20 e il 21 giugno 26 aprile 2019 (Milano) 6 maggio - Ultimo, Nelson Mandela Forum (Firenze) 7 maggio - Alessandra Amoroso, Palapartenope (Napoli) 7 maggio - Elisa, Teatro degli Arcimboldi (Milano) 7 maggio - Fiorella Mannoia, Teatro Verdi (Firenze) 7 maggio - Giorgia, Mediolanum Forum (Assago) 7 maggio - Tokio Hotel, Fabrique (Milano) 7 maggio - Sananda Maitreya, Teatro delle Celebrazioni (Bologna) 8 maggio - Dido, Teatro degli Arcimboldi (Milano) 8 maggio - Fiorella Mannoia, Teatro Regio (Parma) 8 maggio - Marco Mengoni, Palazzo dello Sport (Roma) Rimani aggiornato con il calendario dei concerti di R101. Ogni 8 maggio - Metallica, Milano Summer Festival - Ippodromo Snai mese, l’elenco in continuo aggiornamento dei live dei maggiori (Milano) artisti italiani e internazionali in giro per l’Italia. 8 maggio - Ultimo, Mediolanum Forum (Assago) 9 maggio - Alessandra Amoroso, Palaflorio (Bari) 1 maggio - Marco Mengoni, Mediolanum Forum (Assago) 9 maggio - Alvaro Soler, Mediolanum Forum (Assago) 1 maggio - Thegiornalisti, Arena Verona 9 maggio - Elisa, Palais Saint Vincent (Saint Vincent) 2 maggio - Elisa, Teatro Europauditorium (Bologna) 9 maggio - Sananda Maitreya, Auditorium Parco della 2 maggio - Marco Mengoni, Mediolanum Forum (Assago) Musica - Studio Borgna (Roma) 3 maggio - Alessandra Amoroso, Palazzo dello Sport (Roma) 9 maggio - Tokio Hotel, Atlantico (Roma) 3 maggio - Elisa, Teatro Europauditorium (Bologna) 10 maggio - Alessandra Amoroso, Palaflorio (Bari)