Eastern Canon Law
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Vaticano, Papa Francesco Sceglie Un Sacerdote Calabrese, Don Fabio Salerno, Come Suo Segretario Personale
Primo piano - Vaticano, Papa Francesco sceglie un sacerdote calabrese, don Fabio Salerno, come suo segretario personale. Roma - 02 ago 2020 (Prima Pagina News) Per i calabresi, ma soprattutto per la città di Catanzaro, è una notizia inattesa ma “straordinaria”. Papa Francesco ha infatti scelto un italiano come suo segretario personale, don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. A darne notizia ufficiale è stato questa mattina il portavoce Vaticano, Matteo Bruni. “Nel contesto di un normale avvicendamento di persone, disposto da Papa Francesco per i collaboratori della Curia Romana” - comunica alla stampa Matteo Bruni - monsignor Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Pontefice dall’aprile 2014, conclude il suo servizio. “Mons. Gaid continuerà l’attuale incarico di membro dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana”, l’organismo che promuove i valori proposti nel “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato nel febbraio dell’anno scorso ad Abu Dhabi da Papa Francesco e il grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb. Don Salerno è nato a Catanzaro il 25 aprile 1979. E stato ordinato sacerdote il 19 marzo 2011, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito il Dottorato in ‘Utroque iure’ presso la Pontificia Università Lateranense in Roma. Dopo essere stato alunno della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha prestato servizio come Segretario della Nunziatura Apostolica in Indonesia e della Missione Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa in Strasburgo. Attualmente, lavora presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. -

Particular Laws of the Syro-Malabar Church Got Under Way Not Long After the Promulgation of the Code of Canons Statutes of the Superior Tribunal
front inside SYNODAL NEWS BULLETIN OF THE SYRO-MALABAR MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH BULLETIN OF THE SYRO-MALABAR MAJORARCHIEPISCOP AL CHURCH Vol. 11 No. 1 May 2003 EDITORIAL BOARD Mar George Punnakottil, Mar Jacob Manathodath, Mar Thomas Chakiath, Fr. James Kallumkal V.C. (Chief Editor) and Fr. Jose Porunnedom. INFORMATION FOR SUBSCRIBERS The present subscription rate of Synodal News is Rs.50 Per annum (Overseas US$ / Euro 15.00). In case you want to contact us for any reason please quote your subscription number. Please pay the subscription by Money Order or Demand Draft. On PARTICULAR LAWS technical reasons we don’t accept cheques. Normally two numbers of Synodal News are published in a year. OF THE SYRO-MALABAR CHURCH Back issues of SYNODAL NEWS are available at the following rates: Vol.1(1993), no.1, Rs.15/-; Vol.2 (1994), no. 1, Rs. 15/-(Vol.2, no.2, not available); Vol.3(1995), nos 1-3, Rs.45/-; Vol.4 (1996), nos.1&2, Rs.30/-; Vol.5 (1997), nos. 1 and 2, Rs. 50/-; Vol.6 (1998), nos. 1 and 2, Rs. 50/-; Vol.7 (1999), nos.1&2, Rs. 30/-; Vol.8 (2000), nos. 1 and 2, Rs. 50/-; Vol. 9 (2001), nos. 1&2, Rs. 30; Vol.10 (2002), no.1, Rs.15/- (postage extra). For further information please write to: Editor SYNODAL NEWS Mount St. Thomas Thrikkakara P.O. Kochi 682 021, India E-mail: [email protected] Published by the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Curia Vol. 11 No. 1 May 2003 Mount St. Thomas, PB No. -

Develop India YEAR 12, VOL. 31, ISSUE 617, 26 JULY-2 AUG., 2020.Pmd
DEVELOP INDIA English Weekly Newspaper Prayagraj (Allahabad); Sunday; Year 12, Vol. 31, Issue 617, 26 July-2 Aug., 2020 Download DIG App : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.developindiagroup.dig&hl=en_IN Download DIG App : https://play.google.com/store/apps/details?id=in.co.developindiagroup.dig&hl=en_IN PRICE-10/- DEVELDEVELDEVELOPOPOP INDIAINDIAINDIA English Weekly Newspaper YEAR 12, VOL. 31, ISSUE 617, 26 JULY-2 AUG., 2020 PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) PAGE-8 CCRGA issues notice to Delhi Govvvernment Science and Technology Budgets The Supreme Court mandated Committee on Content Regulation in Government Advertising Demand for Grants 2020-21 Analysis : AgAgAgriclture and Farararmers WWWel-el-el- (CCRGA) on Monday issued a notice to The scientific breakthrough in India started pre- tries. India has only 140 researchers per fare Government of NCT of Delhi on an adver- independence by C V Raman, Vikram Sarabhai 1,000,000 population, compared to 4,651 in the tisement of the Delhi Government which The Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare has two Departments: (i) Agriculture, Coopera- and many other well known Indian scientists United States. "MECHANICS - Oscillations and had appeared in newspapers on the 16th tion and Farmers’ Welfare, which implements policies and programmes related to crop husbandry science and technology in India. Indian Insti- Properties of Matter" written originally by J.C. July, 2020. and farmers’ welfare, and manages agriculture inputs, and (ii) Agricultural Research and Educa- tute of Science, Banglore. Post-independence Upadhyaya - M.sc., Ph.D., F.Inst.P. (London) a tion, which coordinates and promotes agricultural research and education in the country. -
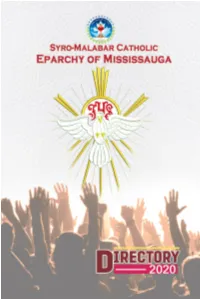
2020 Directory
1 ..................................................................................... PRAYER FOR THE EPARCHY OF MISSISSAUGA God our loving Father, we praise and thank you for the establishment of the Eparchy of Mississauga. Pour out your Spirit, endue with the choicest heavenly blessings and all the necessary graces and gifts of the Holy Spirit on all of us to build up the Syro-Malabar Church in Canada, for the Glory of God. In the name of Jesus we ask you to send your Spirit on our Bishop, Priests, Religious and all Men and Women, Young and Old to respond to your call for renewing the families and building up the community. Holy Mary, Mother of God, Pray for us. St. Joseph, patron of Canada, Pray for us St Thomas, Patron of our Eparchy, Pray for us. 2 3 ST. THOMAS PATRON OF THE EPARCHY 4 His Holiness Pope Francis.......................................................................... 5 The Catholic Church ................................................................................... 8 State of Vatican City ................................................................................... 10 The Roman Curia ........................................................................................ 11 His Excellency the Most Reverend Luigi Bonazzi ................................. 15 Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB)............................. 16 Episcopal Commissions and Standing Committees ............................. 18 Ecclesiastical Jurisdictions .......................................................................... -
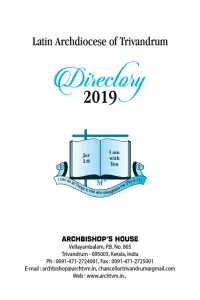
Directory2019.Pdf
Title : Directory 2019 Archdiocese of Trivandrum Approved by : Most Rev. Dr. Soosapakiam M Archbishop of Trivandrum Published by : Chancery, Latin Archdiocese of Trivandrum First Edison : 19 March 2019 Designing & Printing : St. Joseph’s Press Trivandrum, 0471-2322888 copyright : curia, Archdiocese of Trivandrum private circulation only ACKNOWLEDGEMENTS “Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.” (1 Chronicles 16,34) “Latin Archdiocese of Trivandrum - Directory 2019” is a collection of information of persons and institutions in the Archdiocese of Trivandrum. This work attempts to narrate briefly an overall view of the archdiocese that helps the reader to have a bird’s eye view. The “Directory” is divided into six Sections namely, Introduction, Archdiocese, Parishes, Priests, Religious, and Institutions. Each section is subdivided into further parts. The text in these parts contains the list and composition of different archdiocesan bodies like consultors, finance council, senate of priests, archdiocesan pastoral council, ministries and advisory boards besides addresses of different parishes, diocesan offices, institutions, religious houses etc. I sincerely thank Archbishop Soosa Pakiam M. who instructed me to initiate this work for the good of all; also, thank Auxiliary Bishop Christudas R. for his guidance. Thanks to Reverend Parish priests, priests, Religious men and women and others who generously helped us in providing sufficient matter for the work. I thankfully remember seminarians Sanchon Alfred who helped at the initial works of editing; and Brothers Ignatious Julian, Thomas D’Cruz, Herin Herbin who did the data collection at the parish level also Bro Franklin David who helped at the final stage of the work. -

The Catholic Standard, Sunday, July 5
VOL. 82 NO. 26 Electronic Edition GHANA’S NATIONAL CATHOLIC WEEKLY ESTD. IN 1938 SUNDAY, JULY 5, 2020 – SATURDAY, JULY 11, 2020 PRICE GH¢2.00 ‘You Reap What You Sow’ We are convinced that the rule of law is based on “democratic principles that are inspired not only by the power Warn CENCO Bishops of the majority, but also by the recognition of fundamental moral people”, say the members of the Standing values respectful of human dignity, Committee of the National Episcopal life and intangible and inalienable Conference of the Democratic Republic of r i g h t s f r o m e v e r y m a n . A the Congo (CENCO) in a message on the Reconsider Portrayal parliamentary majority, however bill of reform of the judiciary deposited in legal it may be, loses its legitimacy the Parliamentary Assembly by the when it is disconnected from the government. of Jesus as White: interests and well-being of the Continued on page 3 Archbishop of Canterbury Story on page 3 Govt. Grants Page 13 Additional Incentives ‘We Must Rely on Our Strengths’ to Frontline Health Workers – COPAB to African States See back page Vatican Releases New Catechesis Directory Story on * Nun leads a practice for some of the children who will receive page 3 first communion before Pope Francis in Rakovski, Bulgaria. African Media Practitioners Recall Memorable Moments with U.S. Cleric Who “married” Media 2 THE CATHOLIC STANDARD Electronic Edition Sunday, July 5 – Saturday, July 11, 2020 CATHOLIC Archbishop Paglia Calls for Reform in Healthcare System World News from “the integrity of scientific an online meeting held between research, to its freedom in terms the Pontifical Academy, the of economic profit.” Dicastery for Promoting Integral Speaking at the forum, H u m a n D e v e l o p m e n t , a n d sociologist Gianni Tognoni, representatives of Latin American T h e P r e s i d e n t o f t h e denounced the "fragmentation" Bishops' Conferences (CELAM), of governments' and scientists' Pontifical Academy for Life, which comprises Colombia, Archbishop Vincenzo Paglia, responses to the crisis. -

Higher Committee of Human Fraternity Calls for Global Day of Prayer on May 14 in Response to COVID-19
Higher Committee of Human Fraternity Calls for Global Day of Prayer on May 14 in Response to COVID-19 Members of the Higher Committee of Human Fraternity (HCHF) meeting with Pope Francis and Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grand Imam of Al-Azhar (Photo: AETOSWire) ABU DHABI, United Arab Emirates, Business Wire , 8 May 2020 The Higher Committee of Human Fraternity (HCHF), called on religious leaders and faithful around the world to a day of fasting, prayers and supplications for the good of all humanity on Thursday, May 14 for an end to the novel coronavirus (COVID-19) pandemic. The call is part of the Committee’s (HCHF) efforts to realize the objectives of the Document on Human Fraternity. It invites people around the world to lay all their differences aside and come together and assume their responsibilities against this virus, the first and true enemy of humanity in this era. Judge Mohamed Abdel Salam , Secretary-General of the Committee (HCHF) said: “The overwhelming response with this call for prayer from leaders and peoples around the world is a true testament to human solidarity and grants us hope in achieving global unity based on human fraternity principles for the safety, security and health of all mankind.” He also noted that seeing all believers come together in prayers and supplications for an end to this pandemic is dream come true of a universal human unity, which is much needed now more than ever. “We will implore God Almighty for his grace and mercy and trust that He will respond to the hopes of millions of faithful asking to be saved from this deadly pandemic,” he continued. -

Waste and War Top Agenda of Joy for the Church
NEW SERIES: CANONISATIONS: PM’s CHRISTIANITY Journeys of Special preview remarks win faith on paths reports plus support but not to sainthood. crossword. Gerald Warner’s Page 24 Pages 7, 8, 14, 16 Pages 3, 10 No 5566 VISIT YOUR NATIONAL CATHOLIC NEWSPAPER ONLINE AT WWW.SCONEWS.CO.UK Friday April 25 2014 | £1 Canonisation excitement nears fever pitch ahead of ceremony due to draw 5 million pilgrims By Daniel Harkins Park will be able to tell their children and grandchildren ‘I THE Vatican and churches in saw a saint,’ which is quite a Rome made final preparations boast!” he said. this week for Sunday’s Pope Francis took the unusual unprecedented double Canon- step of waiving the normal isation of Pope John Paul II requirement for two miracles and Pope John XXIII. before the Canonisation of Pope More than five million people John XXIII, with the Church are expected to arrive in Rome saying such a requirement has for the Canonisations, and always been debated. churches in the city will stay Mr Convery said the Pope open all night before the cere- believes the universal devotion mony to accommodate pilgrims to ‘Papa Roncalli’ is grounds for and offer a prayer vigil. canonisation. In a sign of the event’s global “He also sees in Pope John, a reach, the Canonisations will be humble man of farming stock shown on television and in cine- from a village near Bergamo in mas around the world. In the northern Italy, a role model for UK, Sky3D and Sky Arts will the kind of humble and joyous broadcast live from St Peter’s Church that he wishes to encour- Square and the Scottish faithful age,” Mr Convery added. -

Acta Apostolicae Sedis
An. et vol. CIII 2 Decembris 2011 N. 12 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Citta` del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA BENEDICTI PP. XVI LITTERAE DECRETALES Quibus beatae Iuliae Salzano Sanctorum honores decernuntur. BENEDICTUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam « Dedit quoque in corde eius, ut alios doceret » (Ex 35, 36). Unum quidem fuit beatae Iuliae Salzano, Domini amorem docere eundemque vivere, sic eius dilecti discipuli in ipso Beatae corde legere potuerunt, exemplo cotidiano eius vitae eiusque verbis, ardentis caritatis fidem. Beata Iulia Salzano in oppido Sanctae Mariae Capuae Veteris die XIII mensis Octobris anno MDCCCXLVI quarta ex septem liberis nata est. Quattuor annos nata patrem amisit atque familia eam curis demandavit Sororum sanctae Ioannae Antidae Thouret in loco v. d. San Nicola La Strada (intra fines provinciae Casertae). Itaque earum in domo christianam culturalemque institutionem est adepta. Studiorum curriculis perfectis, diplomate magistrae litterariae est honestata atque anno MDCCCLXV munus 784 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale docendi Casoriae obtinuit. Oppidum istud eiusque ager in altera saeculi XXIX parte officina facta est sanctorum. Hic beata Iulia eos convenit qui futuri erant sancta Catharina Volpicelli et beatus Ludovicus de Casoria, qui indicia moderationemque ei praebuerunt ad novum institutum religiosum condendum. Cum sacrum Cor Iesu adamaret, inde ab initio pluris magistra est aestimata. Inventionis facultatibus praebita, quam ferventis precationis vita extulit, Spiritu Sancto agente, Congregationem Sororum Catechistarum a Sacro Corde condidit. Compluribus difficultatibus superatis, die XXI mensis Novembris anno MCMV religiosum vestimentum induit et una cum octo sociis vota religiosa nuncupavit. Anno MCMX a Summo Pontifice benedictionem obtinuit novae Religiosae Communitatis. -

DIRECTORY 2016 & Patron - Diocese of Chanda Papal Ministry Motto - "Service in Dialogue of Truth and Love" the First Bishop & Architect of Chanda
EPARCHY OF CHANDA - DIRECTORY 2016 & Patron - Diocese of Chanda Papal Ministry Motto - "Service in Dialogue of Truth and Love" The First Bishop & Architect of Chanda BISHOP JANUARIUS PALATHURUTHY CMI (1962 - 1990) Motto - "Universal Family" (Viswa Kutumb) Motto - "Let us share everything dynamically divine" (Sambhajemahi Dhivyani) Director 2016 EPARCHY OF CHANDA C 2016 Copyright Reserved, Diocese of Chanda DIRECTORY 2016 Published by : The Diocesan Curia Bishop's Home, Ballarpur - 442 701 Chandrapur Dt., Maharashtra State India Printed by : Devdan Printers, Diocese of Chanda, Ballarpur - 442 701 BISHOP'S HOME Chandrapur Dt., Maharashtra State Ballarpur P. O., Chandrapur Dt. - 442 701, (M.S.), INDIA. India E-mail : [email protected] Ph. : 07172 - 240537 Cover Photo : St. Thomas Cathedral, Ballarpur 03 04 EPARCHY OF CHANDA Director 2016 Director 2016 EPARCHY OF CHANDA CATHOLIC CHURCH: ROMAN CURIA THE CATHOLIC CHURCH IN ASIA ........................... 20 Page No 1. Federation of Asian Bishops' Conference (FABC) 1. THE SECRETARIATE OF STATE ........................... 12 2. Pontifical Mission Organization (PMO) I. General Affairs THE CATHOLIC CHURCH IN INDIA ........................ 22 II. Relationship with Civil Governments 1. The Apostolic Nunciature in India III.Secretariate for the Economy 2. Catholic Bishops' Conference of India (CBCI) 2. CONGREGATIONS .................................................. 14 A. Offices of the CBCI ..................................................... 23 I. Congregation for the Doctrine of Faith 1. Doctrine II. Congregation for the Eastern Churches 2. Clergy and Religious III.Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments 3. Dialogue and Desk for Ecumenism IV. Congregation for the Cause of Saints 4. Education and Culture V. Congregation for the Bishops 5. Health Care VI.Congregation for the Evangelization of Peoples 6. -

Novembre 2019 Tariffa Regime Libero: Poste S.P.A.Italiane Spedizione in Abbonamento Postale - - ROMA DCB 70%
1 numero 61 - novembre 2019 Tariffa Regime Libero: Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale 70%DCB - ROMA - Postale Abbonamento in Spedizione ItalianeS.p.A. Poste Libero: Regime Tariffa SOMMARIO 2019 novembre 61 - per il Medioriente numero Finestra - - Il nostro Editoriale ..............................................................2 - Voi e il Medio Oriente, Don Andrea ...................................4 - Nasce ad Abu Dhabi un Comitato per il Documento sulla Fratellanza ..............................................6 - Giornata del dialogo cristiano-islamico ............................. 9 - Il Filo d’erba verde: In Algeria i musulmani riaprono una chiesa chiusa dalle autorità ......................................... 13 - Premio Don Andrea Santoro: don Andrea Santoro, «la bellezza della vita spesa per amore e con amore» ........ 15 e intervento del Cardinale Vicario Angelo De Donatis ......16 - Alla scoperta della Turchia Cristiana: Eufemia e Olimpia, storie di sante dal passato cristiano della Turchia ............. 19 - I Martiri dei nostri tempi: Mons. Salvatore Colombo “Vescovo dei poveri e martire della carità” ........................ 24 e “Abouna” Frans, pane spezzato per il popolo siriano .... 26 - Corso di Icone in Cappadocia. Brevi risonanze .................29 - Incontro per ricordare i Martiri di Algeria ad un anno dalla beatificazione .......................................... 32 - Programma 2019 - 2020 ....................................................... 33 IIll nnoossttrroo EEddiittoorriiaallee Carissimi abbiamo iniziato il nostro cammino comunitario mercoledì 9 ottobre sotto 2 la protezione di Sant’Abramo, con la Finestra di preghiera settimanale de- dicata all’approfondimento del “Documento sulla Fratellanza Umana”, do- cumento firmato da Papa Francesco e dal grande Imam di Al-AzharAhamad Al-Tayyeb, che ci accompagnerà fino a Natale. Potete trovare il documento integrale sul n.60 del giornalino (scaricabile dal sito) oppure scaricare le tracce settimanali della Finestra di Preghiera sempre dal sito. -

By a Thesis Submitted to the Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, Canada, in Partial Fulfillment of the Requirem
FINANCE OFFICER IN THE SYRO-MALABAR MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH by Matthew CHANGANKARY A thesis submitted to the Faculty of Canon Law Saint Paul University, Ottawa, Canada, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Canon Law Ottawa, Canada Saint Paul University 2012 © Matthew Changankary, Ottawa, Canada, 2012 ABSTRACT The promulgation of the CCEO and the elevation of the Syro-Malabar Church sui iuris to the status of a major archiepiscopal Church, on 16 December 1992, are important milestones in the recent history of the Church. The new status of the Syro- Malabar Church necessitated a revised system of administration of its temporal goods. Previously the administration of ecclesiastical goods of the Syro-Malabar Church was ruled predominantly by the motu proprios Postquam apostolicis litteris, Cleri sanctitati, and customary law both at the eparchial and parish levels. In the present situation a new ecclesiastical office, that of the finance officer of the major archiepiscopal Church, was created. The thesis presents the office of finance officer and examines critically the canonical aspects of his/her status and duties. It analyzes the canons contained in CCEO related to temporal goods, as well as other universal and particular ecclesiastical norms. In particular, the sources include various synodal decrees, eparchial/diocesan statutes of the Syro-Malabar Church, and relevant particular laws of the respective major archiepiscopal Churches. Pertinent Indian civil laws are also considered in the context of the functions of the finance officer. The thesis provides a historical perspective of the financial administration of the Syro-Malabar Church, and then continues to situate the office of the finance officer in the organizational structure of the financial administration of the Syro-Malabar Church.