San Clemente Di Ocrida: Allievo E Maestro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Snow Man and Bait by David Albahari
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Masters Theses Graduate School 8-2006 Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari Damjana Mraovic University of Tennessee - Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Mraovic, Damjana, "Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari. " Master's Thesis, University of Tennessee, 2006. https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/1746 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Damjana Mraovic entitled "Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari." I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, with a major in English. Amy Elias, Major Professor We have read this thesis and recommend its acceptance: Allen Dunn, Lisi M. Schoenbach Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) To the Graduate Council: I am submitting herewith a thesis written by Damjana Mraović entitled “Politics of Representations: Snow Man and Bait by David Albahari.” I have examined the final electronic copy of this thesis for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts, with a major in English. -

Srpska Knji@Evnost Na Kraju Veka, Iz Generacije U Generaciju
Zoran \eri} SRPSKA KNJI@EVNOST NA KRAJU VEKA, IZ GENERACIJE U GENERACIJU Ne ulaze}i u spekulacije o tome {ta je kraj na{eg veka (a mnogo ih je, ne samo me|u istori~arima i politi~arima, ve} i me|u filosofima i knji`evnim teoreti~arima), nastoja}e- mo da damo pregled najzna~ajnijih autora i naslova srpske knji`evnosti u poslednjih de- setak godina. U~ini}emo to, najpre, po `anrovima, hronolo{ki, a delimi~no i poeti~ki, kriti~ki vrednuju}i ono {to su srpska knji`evna kritika i razni `iriji za nagrade, ve} izdvo- jili. Bilo kako da izdvajamo, po svim kriterijumima, o~igledno je da su delatne razli~ite generacije, od najstarije do najmla|e, i da se iz godine u godinu pa`nja kritike i ~itala~- ke javnosti nepredvidljivo menja – biraju}i za predmet svojih interesovanja ~as zrelog pi- sca, pri kraju knji`evne karijere, ~as po~etnika, mladog, ili do tog trenutka nedovoljno zapa`enog, ili nerealizovanog starijeg pisca. Roman je, nesumnjivo, naj~itanija knji`evna forma, i u Srbiji i Crnoj Gori. Po razli~i- tim izve{tajima, od izdava~a, knji`evnih `irija, novina i ~asopisa, na srpskom jeziku se svake godine pojavi vi{e od 100 romana. Za poslednjih desetak godina, ta brojka prela- zi 1000. A ipak se govori o krizi romana, koja je, naravno, u vrednosnom smislu, jer se po kvantitetu srpska romaneskna produkcija mo`e meriti sa mnogim drugim velikim na- cionalnim knji`evnostima. NIN-ova nagrada za roman godine, koja se dodeljuje gotovo pola veka, dobar je pokazatelj de{avanja, pre svega, knji`evnog stanja, mo}i i nemo}i pojedinih autoriteta, izdava~kih ku}a, medija, ali i interesovanja javnosti za pojedinog pisca i njegovo, tako uo~eno, delo. -

Serbia in 2001 Under the Spotlight
1 Human Rights in Transition – Serbia 2001 Introduction The situation of human rights in Serbia was largely influenced by the foregoing circumstances. Although the severe repression characteristic especially of the last two years of Milosevic’s rule was gone, there were no conditions in place for dealing with the problems accumulated during the previous decade. All the mechanisms necessary to ensure the exercise of human rights - from the judiciary to the police, remained unchanged. However, the major concern of citizens is the mere existential survival and personal security. Furthermore, the general atmosphere in the society was just as xenophobic and intolerant as before. The identity crisis of the Serb people and of all minorities living in Serbia continued. If anything, it deepened and the relationship between the state and its citizens became seriously jeopardized by the problem of Serbia’s undefined borders. The crisis was manifest with regard to certain minorities such as Vlachs who were believed to have been successfully assimilated. This false belief was partly due to the fact that neighbouring Romania had been in a far worse situation than Yugoslavia during the past fifty years. In considerably changed situation in Romania and Serbia Vlachs are now undergoing the process of self identification though still unclear whether they would choose to call themselves Vlachs or Romanians-Vlachs. Considering that the international factor has become the main generator of change in Serbia, the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia believes that an accurate picture of the situation in Serbia is absolutely necessary. It is essential to establish the differences between Belgrade and the rest of Serbia, taking into account its internal diversities. -

Disillusioned Serbians Head for China's Promised Land
Serbians now live and work in China, mostly in large cities like Beijing andShanghai(pictured). cities like inlarge inChina,mostly andwork live Serbians now 1,000 thataround andsomeSerbianmedia suggest by manyexpats offered Unofficial numbers +381 11 4030 306 114030 +381 Belgrade in Concern Sparks Boom Estate Real Page 7 Issue No. No. Issue [email protected] 260 Friday, October 12 - Thursday, October 25,2018 October 12-Thursday, October Friday, Photo: Pixabay/shanghaibowen Photo: Skilled, adventurous young Serbians young adventurous Skilled, China – lured by the attractive wages wages attractive the by –lured China enough money for a decent life? She She life? adecent for money enough earning of incapable she was herself: adds. she reality,” of colour the got BIRN. told Education, Physical and Sports of ulty Fac Belgrade’s a MAfrom holds who Sparovic, didn’t,” they –but world real the change glasses would rose-tinted my thought and inlove Ifell then But out. tryit to abroad going Serbia and emigrate. to plan her about forget her made almost things These two liked. A Ivana Ivana Sparovic soon started questioning questioning soonstarted Sparovic glasses the –but remained “The love leaving about thought long “I had PROMISED LAND PROMISED SERBIANS HEAD HEAD SERBIANS NIKOLIC are increasingly going to work in in towork going increasingly are place apretty just than more Ljubljana: Page 10 offered in Asia’s economic giant. economic Asia’s in offered DISILLUSIONED love and had a job she ajobshe had and love in madly was She thing. every had she vinced con was Ana Sparovic 26-year-old point, t one FOR CHINA’S CHINA’S FOR - - - BELGRADE INSIGHT IS PUBLISHED BY INSIGHTISPUBLISHED BELGRADE for China. -
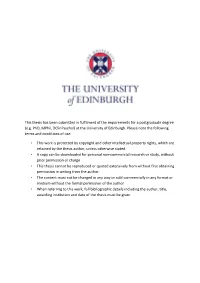
This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: • This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. • A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. • This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. • The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. • When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Cinematic Representations of Nationalist-Religious Ideology in Serbian Films during the 1990s Milja Radovic Doctor of Philosophy The University of Edinburgh March 2009 THESIS DECLARATION FORM This thesis is being submitted for the degree of PhD, at the University of Edinburgh. I hereby certify that this PhD thesis is my own work and I am responsible for its contents. I confirm that this work has not previously been submitted for any other degree. This thesis is the result of my own independent research, except where stated. Other sources used are properly acknowledged. Milja Radovic March 2009, Edinburgh Abstract of the Thesis This thesis is a critical exploration of Serbian film during the 1990s and its potential to provide a critique of the regime of Slobodan Milosevic. -

Izmena I Dopuna Konkursne Dokumentacije 2/2013
На основу члана 63. став 5 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” 124/2012) наручилац врши следећу измену Предмет: Измена и допуна конкурсне документације 2/2013 на страни 7 конкурсне документације у обрасцу понуде за партију бр. 1 књиге на српском језику у ОПИС ПОСЛА уместо књиге из спецификације бр 1. треба да стоји књиге из спецификације бр 4. Додаје се Спецификација бр 4. Издавач или Наслов Аутор одговарајуће Комада A planine odjeknuše Haled Hoseini Laguna 3 Rukopis otkriven u Akri Paulo Koeljo Laguna 3 Jovanovo zaveštanje Vanja Bulić Laguna 3 Tamo daleko Vuk Drašković Laguna 3 Utočište Nikolas Sparks Laguna 2 Let Vladimir Arsenijević Laguna 3 Solomonova pesma Toni Morison Laguna 2 Godine koje su pojeli sklakavci 2 Borislav Pekić Laguna 2 Obećanje krvi-Vampirska akademija Rišel Mid Laguna 2 Neraskidiva veza-Vampirska akademija Rišel Mid Laguna 2 Poslednja ţrtva-Vampirska akademija Rišel Mid Laguna 2 Male priče David Albahari Čarobna knjiga 2 Sto jada Emir Kusturica Novosti 2 Spasitelj Ju Nesbe Laguna 2 Marija Jovanović- Zvuci iz podmornice Marija Jovanović izdavač 2 Inferno Den Braun Solaris 2 Zajedno sami Marko Šelić VEGA MEDIA 2 U zemlji krvi I idiota Vedrana Rudan VBZ 2 Sjaj slobode Suzan Kolins Vulkan 3 Lov na vatru Suzan Kolins Vulkan 3 Huverova slagalica Robert Ladlam Vulkan 2 Obnaţena pred tobom Silvija Dej Čarobna knjiga 2 Prepletena s tobom Silvija Dej Čarobna knjiga 2 Veo tajni Harold Robins Vulkan 2 Sva lica izdaje Harold Robins Vulkan 2 Mali mi je ovaj grob Biljana Srbljanović Samizdat B92 2 Insajder, moja priča -

S Francuskog Prevela Zorica Miškovid. - Sarajevo : Izdavačko Preduzede "Svjetlost", 1967 (Sarajevo: NP "Oslobpđenje")
02001 821.133.1 82-822 SAGAN, Fransoa Čudesni oblaci / Fransoa Sagan; s francuskog prevela Zorica Miškovid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1967 (Sarajevo: NP "Oslobpđenje"). - 148 str.; 17 cm. - (Biblioteka "Džepna knjiga" 403) POD/004016 POD/021257 02002 821.163.41 82-822 ANDRID, Ivo Mustafa Madžar i druge priče / Ivo Andrid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1965 (Sarajevo: NP "Oslobođenje"). - 223 str.; 17 cm. - (Biblioteka "Džepna knjiga" 341) POD/004017 POD/004018 02003 821.111(73)-31 82-822 LUIS, Sinkler Bebit : knjiga prva / Sinkler Luis; preveo s engleskog Borivoje Nedid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1966 (Beograd: Grafičko preduzede "Novi dani"). - 237 str.; 17 cm. - (Džepna biblioteka Izabranih djela) POD/004019 PO/005067 POD/004020 POD/004021 POD/007371 02004 821.111-31 82-822 SINKLER, Luis Bebit : druga knjiga / Sinkler Luis; s engleskog preveo Borivoje Nedid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1966 (Beograd: Grafičko preduzede "Novi dani"). - 222 str.; 17 cm. - (Džepna biblioteka Izabranih djela) POD/004022 POD/004023 PO/005065 POD/005066 POD/013715 POD/021401 02005 821.163.41-32 82-822 PETROVID, Veljko Pesma u podne / Veljko Petrovid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1966 (Beograd: Grafičko preduzede "Novi dani"). - 263 str.; 17 cm. - (Džepna biblioteka Izabranih djela) PO/004024 POD/020507 02006 821.112.2 82-822 MAJER, Konrad Ferdinand Peskarino iskušenje - Anđela Borđija / Konrad Ferdinand Majer; s njemačkog preveo Konstantin Petrovid. - Sarajevo : Izdavačko preduzede "Svjetlost", 1966 (Beograd: Grafičko preduzede "Novi dani"). - 277 str.; 17 cm. - (Džepna biblioteka izabranih djela) PO/004026 POD/004027 POD/004762 POD/019270 POD/004025 02007 821.111-31 82-822 TEKERI, Viliem Mekpis Vašar taštine : III knjiga / Viliem Mekpis Tekeri; s engleskog preveo Mihailo Đorđevid. -

The Media in Dark Times a View of the Media in Serbia Filip David It Is
The Media in Dark Times A View of the Media in Serbia Filip David It is the opinion of many that the disintegration of Yugoslavia and the present bloody war would not have been possible without the propaganda role of the state media, particularly radio and television. A monopoly of information already existed in its fullest form in Tito's Yugoslavia. Then too there were 'black lists' of banned personalities and an index of prohibited subjects. No criticism was allowed of Tito himself or his actions, the Yugoslav national army, the communist system, self-management or brotherly unity. It is true that in some of its features, Yugoslav communism was more liberal than that of Eastern Europe or the Soviet Union and that there was an occasional relaxation of censorship and party control, but there was never a moment when the media was free to act without ideological pressure. Having lost its ideological basis after the collapse of the Great Eastern Empire of communism, the ruling oligarchy took on nationalism as its new ideology. In Serbia, this conversion took place through what was known as 'the anti-bureaucratic revolution', which represented an introduction to the disintegration of Yugoslavia, but about the same time prefaced a gory venture into war. All the worst features of the old regime were passed on: demagogy, manipulation of people and ideas, the use of force against the truth, an Orwellian twisting of the meaning of words. People spoke of peace when they meant war, cited justice while setting up a system of gross injustice. Truth became another name for lies and life was praised by glorifying death. -

Slavica Bruxellensia, 5 | 2010 La Littérature Serbe Avant Et Après La Chute Du Mur De Berlin 2
Slavica bruxellensia Revue polyphonique de littérature, culture et histoire slaves 5 | 2010 Après 1989 La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin Milivoj Srebro Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/slavica/295 DOI : 10.4000/slavica.295 ISSN : 2034-6395 Éditeur Université libre de Bruxelles - ULB Édition imprimée Pagination : 7-20 ISSN : 2031-7654 Référence électronique Milivoj Srebro, « La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin », Slavica bruxellensia [En ligne], 5 | 2010, mis en ligne le 15 février 2010, consulté le 03 mai 2019. URL : http:// journals.openedition.org/slavica/295 ; DOI : 10.4000/slavica.295 Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019. Les contenus de Slavica bruxellensia sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France. La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin 1 La littérature serbe avant et après la chute du mur de Berlin Milivoj Srebro Introduction 1 La chute du Mur de Berlin, qui a sonné le glas du communisme en Europe n’a pas eu le même impact sur la vie intellectuelle et littéraire dans tous les anciens pays communistes. Si cet important événement historique a effectivement ouvert une nouvelle ère dans l’espace culturel de l’ex-bloc soviétique – une ère où les écrivains pouvaient enfin espérer jouir pleinement de la liberté d’expression –, il s’est inscrit dans un contexte socioculturel différent en ex-Yougoslavie, pays qui se trouvait alors déjà au bout du gouffre. -

Žiri 1967-2017
1. BITEF Predrag Bajčetić, (1934-2018) reditelj, pozorišni, filmski, radio i televizijski glumac , producent, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu / director, theater, film, radio and television actor, production, professor at the Faculity of Dramatic Arts in Belgrade Dejan Čavić, (1934-), srpski pozorišni, filmski, radio i televizijski glumac i reditelj / Serbian theater, film, radio and television actor and director Jovan Ćirilov, (1931-2014), srpski dramaturg, teatrolog, kritičar, umetnički direktor Beogradskog Internacionalnog Teatarskog Festivala – BITEFA / Serbian dramaturge, theater expert, critic, art director of the Belgrade Internacional Theatre Festival – BITEF Ljubomir Draškić, (1937-2004), srpski filmski, televizijski i pozorišni reditelj / Serbian film, television and theater director Boro Drašković, (1935-), srpski filmski, televizijski, radio i pozorišni reditelj, scenarista, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu i na mnogim inostranim univerzitetima (SAD, Indija, Kuvajt, Irak, Mađarska, Norveška…). Piše kratke priče, scenarija, radio-drame i drame. Nagrađivan u zemlji i inostranstvu. / Serbian film, television, radio and theater director, screenwriter, professor of the Academy of Arts in Novi Sad and at many foreign universities (USA, India, Kuwait, Iraq, Hungary, Norway ...). He writes short stories, scripts, radio dramas and drama. Awarded in Serbia and abroad Borislav Mihajlović – Mihiz, (1922-1997), srpski književni kritičar, pesnik, dramski pisac, scenarista, upravnik biblioteke Matice srpske / Sebian literary critic, poet, playwriter, screenwriter, head of Library of Matica Srpska Slobodan Selenić, (1933-1995), srpski kritičar, pisac, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, dopisni je član SANU. Dobitnik je mnogih nagrada, između ostalih NIN-ove nagrade. Studirao je dramu na Beogradskom univerzitetu, a postdiplomske studije u Bristolu 1950 / Serbian critic, writer, professor at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, member of the Serbian Academy of Sciences and Arts – SANU. -

Theoretical Aspects of the Research to the Capacity of the Security System from the Symbolic Approaches
THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH TO THE CAPACITY OF THE SECURITY SYSTEM FROM THE SYMBOLIC APPROACHES DOI: 10.5937/vojdelo1506141M Zoran Milosavljević Institute for Political Studies in Belgrade Jovan Krstić Association of Public Prosecutors of Serbia he Symbolic Approach to Security System Reform (SSR T Symbolic Policy Capacity Building) is a set of ideas and concepts that sends a clear message to the environment that Serbia has broken with authoritarian regimes and their corresponding security systems of the past. As an illustration of the epochal meaning of this approach, the laborious and, based on the latest events, largely incomplete reform of the security services in Pakistan can be used. One of the tasks of social science is making a global assessment on the situation of Human Security. The United Nations has to address it, but our nation needs a serious reconsideration of Common Values (the general security values to be protected) and Public Interest (so ‒ called policy of persecution). Why? Because the interest of the citizens is generally neglected by the bureaucracy by prioritizing the interests of various collectives from the state itself to the interest groups, political parties across the country (that same bureaucracy). Concept of the Economic Security is weak (although the most important, including freedom of the market, environment protection, protection of consumers etc.) because we have no long-term Development Strategy, which would be the basis of good Security Culture. If we consistently consider a system and security as such, we note that something is missing in the list of protected property, as priorities, the lack of protection of certain human rights in the corpus iuris of Human Rights (specifically the right to equal access of citizens to private property and private enterprise). -

The Literary Testimony of Jewish Women Writers in Post-World War II Yugoslavia
Studia Judaica 21 (2018), nr 1 (41), s. 55–76 doi:10.4467/24500100STJ.18.004.9174 Dina Katan Ben-Zion A Symphony of Unique Voices: The Literary Testimony of Jewish Women Writers in Post-World War II Yugoslavia Abstract: The first part of this article endeavors to give an idea about the scope and impact of dealing with Jews and Jewish issues in the literature of the former Yugoslavia, so as to provide a frame of reference for presenting in the second part the literary testimonies of several less-known Yugoslav Jewish women writers. In the second part, the writings of thirteen Jewish women writers will be presented. Their writings represent personal testimonies of literary heroines, while reveal- ing some of the writers’ literary strategies to preserve past-time memories, which in many ways characterize the specific feminine experience of a Yugoslav Jewish woman in the postwar period.1 Keywords: Jewish women writers, female outlook in literature, cultural legacy, dual belonging, strategies of preserving the memory, individual testimony and collective memory. Foreword As a translator and literary scholar who as a child came to Israel from the former Yugoslavia, I have for many years engaged in translating into Hebrew the best-known ex-Yugoslav writers, as well as researching Jewish themes that permeate a considerable part of the literature written in this 1 In the Appendix, I have listed the names of 37 Jewish women writers in the former Yugoslavia. An extensive study dealing with the writings of four of them may be found in my Ph.D. thesis, followed by a book named Nashim kotvot ‘olam: sofrot yehudiyot be- Yugoslavia leshe-avar (Jerusalem, 2013) as well as in the article “The Feminine Voyage in the Post-Holocaust Jewish Literature of Former Yugoslavia,” published in Interkulturalnost 7 (2014), 186–191.