Concilio Vaticano I (1869-1870)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inventaire Des Documents D'interet Canadien Dans Lesarchives De La
Giovanni Pizzorusso - Matteo Sanfilippo Inventaire des documents d'interet canadien dans les Archives de la Congregation "de Propaganda Fide" sous Ie pontificat de Pie IX (1846-1878) Rome - Ottawa Centre academique canadien en Italie - Universite St-Paul 2001 TABLE DES MATIERES I-XXIV INTRODUCTION XXV REMERCIEMENTS XXVI LISTE DES ABREVIATIONS 1-68 PREMIERE PARTIE Acta 69-146 DEUXIEME PARTIE Scritture Originali riferite nelle Congregazioni Generali 147-363 TROISIEME PARTIE Scritture riferite nei Congressi: America Settentrionale 365-409 QUATRIEME PARTIE Scritture riferite nei Congressi: America Centrale et autres (Belgio-Olanda, Collegio Urbano, Collegi Vari, Francia, Germania, Irlanda, Scozia, Stato temporale) 411-596 CINQUIEME PARTIE Udienze 597-754 SIXIEME PARTIE Lettere 755-760 SEPTIEME PARTIE Brevi e Bolle 761-792 INDEX DES DEMANDES DE DISPENSES DE MARIAGE 793-876 INDEX ANALYTIQUE INTRODUCTION par Giovanni Pizzorusso et Matteo Sanfilippo I 1. La documentation de la Propagande sous Ie pont~ficat de Pie IX Le pontificat de Pie IX correspond a un moment-de de I'evolution de I'Eglise catholique romaine a son sommet ainsi que dans ses diverses composantes, Canada y compris. L'autorite spirituelle et politique de Rome est remise en question dans tout I'Occident chretien. Avec la fin de la Restauration, de nouvelles regles du jeu s'imposent et donc de nouvelles fa90ns d'exercer l'autorite. Pie IX s'y essaie des son election en 1846, mais il doit deux annees plus tard faire face a la revolution dans ses propres Etats, fuir a Gaete et attendre pour rentrer a Rome que les Fran9ais veuillent bien venir y remettre l'ordre. -

Conclave 1846
1 ASDNA Archivio Storico Diocesano di Napoli Conclave del 1846 Raccolta di documenti da varie fonti 2 Conclave del 1846 da Wikipedia. Durata Dal 14 al 16 giugno 1846 Luogo Palazzo del Quirinale, Roma Partecipanti 50 Scrutini 4 Decano Ludovico Micara Camerlengo Tommaso Riario Sforza Protodiacono Tommaso Riario Sforza Veto Dell'imperatore Ferdinando I d'Austria contro il cardinale Tommaso Bernetti Eletto Giovanni Maria Mastai Ferretti, papa PIO IX. Il conclave del 1846 venne convocato a seguito della morte del papa Gregorio XVI, avvenuta a Roma il 1º giugno dello stesso anno. Si svolse, per l'ultima volta, al Palazzo del Quirinale dal 14 al 16 giugno, e, dopo quattro scrutini, venne eletto papa il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, vescovo di Imola, che assunse il nome di Pio IX. L'elezione venne annunciata dal cardinale protodiacono Tommaso Riario Sforza. I cardinali elettori Il collegio cardinalizio[1], alla morte di Gregorio XVI, era composto da 62 cardinali, più 6 in pectore che non furono però mai proclamati. Di questi 62, 2 cardinali erano stati nominati da Pio VII, 7 da Leone XII, e gli altri 53 da Gregorio XVI. Dei 62 cardinali solo 8 erano stranieri, e precisamente: Schwarzenberg, arcivescovo di Salisburgo, Gaisruck di Milano (a quei tempi città imperiale), De Bonald di Lione, Bernet di Aix, Cienfuegos di Siviglia, Carvalho di Lisbona, Sterckx di Malines, De La Tour d'Auvergne, vescovo di Arras. Nessuno di questi partecipò al conclave. Gli altri 54 cardinali erano tutti italiani, e di questi 50 presero parte all'elezione: mancavano i cardinali Villadicani Arcivescovo di Messina, Giacomo Monico Patriarca di Venezia, Ignazio Cadolino, Arcivescovo di Ferrara e Placido Maria Tadini Arcivescovo di Genova. -
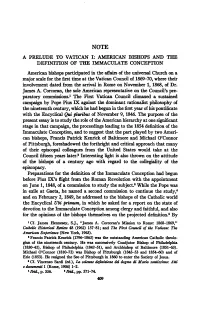
A Prelude to Vatican I: American Bishops and the Definition of The
NOTE A PRELUDE TO VATICAN I: AMERICAN BISHOPS AND THE DEFINITION OF THE IMMACULATE CONCEPTION American bishops participated in the affairs of the universal Church on a major scale for the first time at the Vatican Council of 1869-70, where their involvement dated from the arrival in Rome on November 1, 1868, of Dr. James A. Corcoran, the sole American representative on the Council's pre paratory commissions.1 The First Vatican Council climaxed a sustained campaign by Pope Pius IX against the dominant rationalist philosophy of the nineteenth century, which he had begun in the first year of his pontificate with the Encyclical Qui pluribus of November 9, 1846. The purpose of the present essay is to study the role of the American hierarchy at one significant stage in that campaign, the proceedings leading to the 1854 definition of the Immaculate Conception, and to suggest that the part played by two Ameri can bishops, Francis Patrick Kenrick of Baltimore and Michael O'Connor of Pittsburgh, foreshadowed the forthright and critical approach that many of their episcopal colleagues from the United States would take at the Council fifteen years later.2 Interesting light is also thrown on the attitude of the bishops of a century ago with regard to the collegiality of the episcopacy. Preparations for the definition of the Immaculate Conception had begun before Pius IX's flight from the Roman Revolution with the appointment on June 1,1848, of a commission to study the subject.8 While the Pope was in exile at Gaeta, he named a second commission to continue the study,4 and on February 2, 1849, he addressed to the bishops of the Catholic world the Encyclical Ubi primum, in which he asked for a report on the state of devotion to the Immaculate Conception among clergy and faithful, and also for the opinions of the bishops themselves on the projected definition.6 By 1 Cf. -

Cologne Cathedral
Arnold Wol Cologne Cathedral Its History – Its Artworks Edited and extended by Barbara Schock-Werner About this Cathedral Guide Arnold Wol, who was ‘Dombaumeister’ (cathedral architect) at Cologne Cathedral between 1972 and 1998, created this guide in collaboration with Greven Verlag, Cologne. His wealth of knowledge on the history of the cathedral and his profound knowledge of the interior have both gone into this book, and there are no other publications that do justice to both of these aspects in equal measure. is book presents the reader with the full spectrum and signicance of the architectural and artistic creations that Cologne Cathedral has on oer. In addition, the fold-out oor plan is a useful orientation aid that allows cathedral visitors to search for informa- tion on individual objects. Six editions of this book have now been published. Arnold Wol has overseen all of them. For this new edition he has tasked me with bringing the text up to date in line with the latest research and introducing the new- ly added artworks. e publisher has taken this opportunity to implement a new layout as well. Nevertheless, for me this guide remains rmly linked with the name of the great ‘Dombaumeister’ Arnold Wol. Barbara Schock-Werner Former Dombaumeister (1999–2012) Hint for using this guide: in the text that follows, the architectural features are labelled with capital letters, the furnishings, fittings, artworks, and other interesting objects with numbers. The letters and numbers correspond to those on the fold-out floor plan at the back. The tour starts on page 10. -

Conclave Kindle
CONCLAVE PDF, EPUB, EBOOK Robert Harris | 484 pages | 04 May 2017 | Cornerstone | 9781784751845 | English | London, United Kingdom Conclave PDF Book In practice, any cardinal who intends not to accept will explicitly state this before he receives a sufficient number of votes to become pope, as Giovanni Colombo did in October The papal tailor will have prepared garments to dress a pope of any size - small, medium or large - but some last-minute adjustments may be required. Episcopate of the bishop of Rome. The Vatican Today. Also, at Pope Francis' first appearance, he led the faithful first in prayers for his predecessor and asked them for prayers for himself before imparting the Urbi et Orbi blessing. During the time between the Pope's resignation and the election of his successor, the college of cardinals will govern the Church, headed by Cardinal Tarcisio Bertone, as the cardinal camerlengo - or chamberlain. What Does 'Eighty-Six' Mean? In the Portuguese section of Vatican Radio reported that at the conclusion of the conclave, the newly elected Pope Francis bestowed his cardinalitial zucchetto on Archbishop Lorenzo Baldisseri , the secretary of that conclave, [] and on 22 February at Pope Francis' first consistory, Baldisseri was formally made a cardinal with the title of Cardinal-Deacon of Sant'Anselmo all'Aventino. Beginning in , a successful election is also accentuated by bells ringing at the appearance of the white smoke. It was Pius XII who made this change in Adrian V abolished Gregory X's strict regulations in , but Celestine V , elected in following a two-year vacancy, restored them. -

IKZ 2 Hallebeek (065 100)
VU Research Portal The Old Catholic Synods. Traditional or Innovative Elements within the Constitution of the Church? Hallebeek, J. published in Internationale Kirchliche Zeitschrift 2011 document version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in VU Research Portal citation for published version (APA) Hallebeek, J. (2011). The Old Catholic Synods. Traditional or Innovative Elements within the Constitution of the Church? Internationale Kirchliche Zeitschrift, 101(Heft 2), 65-100. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. E-mail address: [email protected] Download date: 02. Oct. 2021 The Old Catholic Synods Traditional or Innovative Elements within the Constitution of the Church? Jan Hallebeek 1. Introduction In 1928, at the eleventh international Old Catholic Congress in Utrecht, Dr Adriaan van den Bergh (1883–1943), professor of canon law, philoso- phy and apologetics at the Old Catholic Seminary (Amersfoort),1 deliv- ered a lecture on the Louvain canonist Zeger-Bernard van Espen (1646–1728) and his significance for the Old Catholic Churches. -

Souvenir of the Laying of the Cornerstone of St. Francis Church
H k if LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN ILLINOIS HIS" AL SURVEY -^' eti^c 1851 1926 SOUVENIR OF THE LAYING OF THE CORNERSTONE OF t. iFranna OI!|urrI| Teutopolis, Illinois July 20, 1851 HISTORICAL SKETCH OF IHE VILLAGE OF 0^Ut0|J0ltS AND OF t. iFramis fansl| BY EUGENE HAGEDORN, O. F. M. Author of **Beitraege zur Geschichte von Teutopolis und Umgegend," etc. 1839 1926 "Local history more than any other, commands the most inter- ested attention for the reason that it is a record of events in which we have a peculiar interest, as many of the participants travelled the rugged and thorny pathway of life as our companions, acquaintances, and relatives.''—.V. Berry. "History of Effingham County, P. 200. POPE PIUS XL \-MJL/^~'^-v—.^l^ ^^'^^-'=^^V.O-v_^_>00,J^ RT. REV. JAMES A. GRIFFIN, D. D. Bishop of Springfield in Illinois VERY REV. MARTIN STRUB, 0. F. M. Provincial of The Sacred Heart Province Introduction The 20th of July of this year, 1926, mark-; the seventy-fifth anniversary of the laying of the cornerstone of the present church at Teutopolis,—a joyous event, indeed, for the people of the parish. Elaborate preparations were made to cele- brate this event in a becoming manner. As a contribution to this celebration, and also as a lasting memorial of it, the Reverend Pastor, Isidore Fosselmann, 0. F. M., requested the writer to compile a Jubilee Souvenir which was to contain an histori- cal sketch of the pai'ish and town. The following pages are the answer to this request. -

In the Shadow of the Kulturkampf
In the Shadow of the Kulturkampf: Perceptions of the Milderungsgesetzen in Dutch Catholic media, from 1880 to 1884 Thomas Kerstens Abstract This is a transnational research on the way Dutch Catholic media perceived the Kulturkampf in Germany from 1880 to 1884. This dissertation examines two Dutch Catholic newspapers and one magazine to explain three things. Firstly, what the main motives of Dutch Catholic media were to report on German social struggles after 1880. Secondly, how the Milder- ungsgesetzen – that were intended to end this social struggle – influenced the content of the reports of Dutch Catholic media. Thirdly, to what extent the German social struggles were put in an international perspective by these media. The conclusion adds to the debate that ques- tions the nineteenth century as the ‘age of the nation state’. In the Shadow of the Kulturkampf: Perceptions of the Milderungsgesetzen in Dutch Catholic media, from 1880 to 1884 Thomas Kerstens 27-06-2014 In the Shadow of the Kulturkampf Thomas Kerstens Table of Contents Introduction ....................................................................................................................... 3 Chapter 1: The Kulturkampf ............................................................................................ 8 Chapter 1.1. Windthorst Speaks ............................................................................ 8 Chapter 1.2. Social Consequences .......................................................................... 12 Chapter 1.3. A Historical Dimension -

The True and False Infallibility of the Popes, Will Speedily Appear in an English Translation, I Refrain from Doing So
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com THE TRUE AND THE FALSE Infallibility of iThe Popes. A CONTROVERSIAL REPLY TO DR. SCHULTE. ST Dr. JOSEPH JFESSLER, Late Bishop of St. Fatten, in Awtria, and Secretary- General of the Vatican Council. A Work honoured by a Brief of Approbation from His Holiness Pope Pius IX. ftnuMlatcfe from fyc ttltfrt Coition VY PERMISSION OF THE EDITORS OP THE LATE BISHOP FESSLER'S WORKS. New York : THE CATHOLIC PUBLICATION SOCIETY, No. 9 WARREN STREET. i875- THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY LIBRARY CONTENTS. I. True and False Infallibility.— Fessler. II. Mr. Gladstone's Expostulation Unravelled. — Bishop Ullathorne. Submission to a Divine Teacher. — Bishop Vaughan. Syllabus for the People. JSx trad from a Brief addressed to Bishop Fessler by his Holiness Pope Pius IX. April vj, 1871. ' . Peropportunum autem et utilissimum existimavimus retudisse te audaciam Professoris Schulte incitantis saeculares Potestates ad- versus dogma Pontificiae infallibilitatis ab cecumenica Vaticana Syno- do definitae. Non omnes enim, inter laicos praesertim, rei indolem perspectam habent ; et Veritas luculenter exposita multas abigere so- let ab honestorum mentibus obliquas opiniones, saepe cum lacle haustas, aliosque confirmare in recta sententia et adversus insidias munire. Quamobrem si hujusmodi commenta refellere pergas, op- time certe merebis de sanctissima religione nostri. et Christiano po- pulo, quem, uti bonus Pastor, a venenatis pascuis abduces. Pergra- tum Nos tibi profitemur animum, cum ob volumen oblatum, turn ob amantissimas litteras tuas ; tibique amplam apprecamur obsequii de- votionisque tuae mercedem ' Translation. -

Wilhelm Emmanuel Von Ketteler: His Social and Political Philosophy
This dissertation has been microfilmed exactly as received 67-3970 BOCK, Edward Cornelius, 1922- WILHELM EMMANUEL VON KETTELER: HIS SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY. The University of Oklahoma, Ph.D., 1967 History, modem University Microfilms, Inc., Ann Arbor, Michigan THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE WILHELM EMMANUEL VON KETTELER: HIS SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillm ent of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY BY EDWARD CORNELIUS BOCK Norman, Oklahoma 1967 WILHELM EMMANUEL VON KETTELER: HIS SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY ^PROVED BY U) lJULlo^ ki-• [VUuJlP U~. L ■ DISSERTATION COMMITTEE PREFACE Circumstances and environment are important in the determination of interests. Born into the lowest social class, I experienced the ravages of the Great Depression in my early youth. My father took a lively interest in the various proposed solutions to the Great Depression, Because of this 1 acquired a desire to study social and political history. Above all, I felt that, since the roots of the Great Depression lay in the past, history could teach means to avoid future p itfa lls for society. Men of the past who proposed solutions to social and economic problems always challenged my curiosity. In early youth I studied the encyclicals Rerum Novarum of Pope Leo XIII and Quadraqesimo Anno of Pope Pius XI wi th the aid of commentaries. During the same period I read every history book in the small village library, I main tained this interest, especially in social history, until senior college, when Thomistic philosophy began to take most of my attention. -

Fonds Lionel Saint-Georges Lindsay (CL08)
Secteur des archives privées de la Ville de Lévis Finding Aid - Fonds Lionel Saint-Georges Lindsay (CL08) Generated by Access to Memory (AtoM) 2.4.0 Printed: August 30, 2018 Language of description: French Secteur des archives privées de la Ville de Lévis Bibliothèque Saint-David 4 rue Raymond-Blais Lévis Québec Canada G6W 6N3 Telephone: 418-835-4960, poste 8851 Email: [email protected] http://archiveshistoriques.ville.levis.qc.ca/index.php/fonds-lionel-saint-georges-lindsay Fonds Lionel Saint-Georges Lindsay Table of contents Summary information .................................................................................................................................... 16 Administrative history / Biographical sketch ................................................................................................ 16 Scope and content ......................................................................................................................................... 17 Arrangement .................................................................................................................................................. 17 Notes .............................................................................................................................................................. 17 Access points ................................................................................................................................................. 18 Collection holdings ....................................................................................................................................... -

Joseph Hubert Reinkens (1821-1896) Und Eduard Herzog (1841-1924)
Brüder im Bischofamt : Freunde fürs Leben : Joseph Hubert Reinkens (1821-1896) und Eduard Herzog (1841-1924) Autor(en): Berlis, Angela Objekttyp: Article Zeitschrift: Internationale kirchliche Zeitschrift : neue Folge der Revue internationale de théologie Band (Jahr): 101 (2011) Heft 3-4 PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-405085 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Brüder im Bischofsamt - Freunde fürs Leben Joseph Hubert Reinkens (1821-1896) und Eduard Herzog (1841-1924) Angela Berlis Lieber Freund! Diese Zeilen sollen Dir nur beweisen, dass ich Deiner gedenke. Dass ich in Liebe u.