Le Fortificazioni Urbane Di Età Moderna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ARTES. JOURNAL of MUSICOLOGY Vol
“GEORGE ENESCU” NATIONAL UNIVERSITY OF ARTS IAŞI FACULTY OF PERFORMANCE, COMPOSITION AND MUSIC THEORY STUDIES RESEARCH CENTER “THE SCIENCE OF MUSIC” DOCTORAL SCHOOL – MUSIC FIELD ARTES. JOURNAL OF MUSICOLOGY vol. 23-24 ARTES 2021 RESEARCH CENTER “THE SCIENCE OF MUSIC” ARTES. JOURNAL OF MUSICOLOGY Editor-in-chief – Prof. PhD Laura Vasiliu, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Senior editor – Prof. PhD Liliana Gherman, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania SCIENTIFIC COMMITTEE Prof. PhD Gheorghe Duțică, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Prof. PhD Maria Alexandru, “Aristotle” University of Thessaloniki, Greece Prof. PhD Valentina Sandu-Dediu, National University of Music Bucharest, Romania Prof. PhD Pavel Pușcaș, “Gheorghe Dima” National Music Academy, Cluj-Napoca, Romania Prof. PhD Mirjana Veselinović-Hofman, University of Arts in Belgrade, Serbia Prof. PhD Victoria Melnic, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chișinău, Republic of Moldova Prof. PhD Violeta Dinescu, “Carl von Ossietzky” Universität Oldenburg, Germany Prof. PhD Nikos Maliaras, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Lect. PhD Emmanouil Giannopoulos, “Aristotle” University of Thessaloniki, Greece EDITORS Assoc. Prof. PhD Irina Zamfira Dănilă, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Assoc. Prof. PhD Diana-Beatrice Andron, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Lect. PhD Rosina Caterina Filimon, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Assoc. Prof. PhD Gabriela Vlahopol, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania Assist. Prof. PhD Mihaela-Georgiana Balan, “George Enescu” National University of Arts, Iași, Romania ISSN 2344-3871 ISSN-L 2344-3871 Translators: PhD Emanuel Vasiliu Assist. Prof. Maria Cristina Misievici DTP Ing. -

3° Trofeo “Città Di Letojanni” 10^ Prova Del Grand Prix Provinciale Dei Due Mari Letojanni (ME) - 15 Dicembre 2013 Classifica Assoluta - Km
3° Trofeo “Città di Letojanni” 10^ Prova del Grand Prix Provinciale dei Due Mari Letojanni (ME) - 15 Dicembre 2013 Classifica Assoluta - Km. 6,15 Ordine Numero Tempo Impiegato Media Ritardo Cat. Nome Società Arrivo Pettorale (GG:HH:MM:SS:MS (Km/h) sul primo ) 1 49 MM65 (1) Vinciguerra Francesco Marathon Club Taormina 00:00:25:50.399 04.12 2 200 NO_CM (1) Muscolino Emanuele 00:00:26:19.559 04.16 00:00:29.160 3 61 MF40 (1) Pistone Maria Forte Gonzaga 00:00:26:54.100 04.22 00:01:03.701 4 91 ASS_F (1) Satullo Livia Torrebianca 00:00:27:06.509 04.24 00:01:16.110 5 11 TF (1) Colafati Francesca Filippide Messina 00:00:27:26.639 04.27 00:01:36.240 6 48 MM60 (1) Barbera David Marathon Club Taormina 00:00:27:50.049 04.31 00:01:59.650 7 23 TF (2) Castorina Valentina Podistica Messina 00:00:27:52.779 04.32 00:02:02.380 8 28 MF40 (2) Indelicato Maria Podistica Messina 00:00:27:54.099 04.32 00:02:03.700 9 60 MF50 (1) Pirrone Giuseppina Forte Gonzaga 00:00:28:06.329 04.34 00:02:15.930 10 50 MM65 (2) Pilota Carmelo Marathon Club Taormina 00:00:28:17.000 04.35 00:02:26.601 11 59 MF40 (3) Oteri Caterina Forte Gonzaga 00:00:29:01.279 04.43 00:03:10.880 12 94 MF40 (4) Trifirò Domenica Lucia Club Atl. Torrese 00:00:29:08.259 04.44 00:03:17.860 13 95 MF45 (1) Lo Surdo Emilia Club Atl. -

Studi E Strumenti 4, 2001-2002
Archivio di Stato di Palermo Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica Quaderni Studi e strumenti 4 2001-2002 PREFAZIONE La Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Palermo aveva avviato, negli anni scorsi, una esperienza positiva con la pubblicazione dei Quaderni. Vorremmo continuare e, se possibile, stabiliz- zare quella esperienza. Nel programmare la attività dei Quaderni vorremmo prefiggerci degli obiettivi. Vorremmo saperci rivolgere in modo privilegiato agli utenti diretti della Scuola, ai numerosi giovani – e anche meno giovani – che hanno scelto e scelgono di accedere alla Scuola APD di Palermo. In questa prospettiva si privilegeranno i testi di interventi “esterni”, ad integrazione delle lezioni dei docenti interni delle varie discipline. Nell’alveo di una fortemente auspicata politica di valorizzazione del pa- trimonio archivistico, vorremmo potere dedicare uno spazio – auspicabil- mente sempre più vasto – alla edizione di strumenti di descrizione dei fondi e/o delle serie che si conservano presso il nostro Istituto. Vorremmo, se pos- sibile, dedicare una apposita sezione a specifiche ricerche che muovano dal- la analisi dei fondi che qui si conservano. L’impegno vorrà essere a che alla composizione delle suddette sezioni concorrano, prevalentemente, compe- tenze interne all’Archivio di Stato di Palermo ovvero competenze formatesi in attività collaborative con l’Istituto. Il che non esclude la collaborazione e l’interazione con competenze di diversa appartenenza. Nell’avviare la ripresa di una positiva esperienza è opportuno interro- garsi circa la missione, oggi, delle Scuole di APD. Da anni sembrava avviata una riforma che tenesse conto di nuove esigenze, di diverse prospettive che la professione degli archivisti vive. -

Obrazová Část
Obrazová část Obrazová část 1. Osmanská říše v dobách největší slávy Zdroj: Furfur. Osmanisches Reich von 1481 bis 1683. Wikimedia Commons [online] 13. 4. 2013. [v. 2014- 07-11]. Pod licencí CC BY-SA 3.0 (viz http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode). Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottoman_empire_de.svg 117 VÝCHODNÍ OTÁZKA 2. Bitva u Vídně v dobovém zpravodajství Zdroj: Leonhard Loschge. Battle of Vienna. Wikimedia Commons [online] 7. 8. 2008. [v. 2014-07-11]. Do- stupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Viena.jpg 118 Obrazová část 3. Turečtí sipáhijové z dob bitvy u Vídně Zdroj: G. Jansoone. Sipahis at the Battle of Vienna. Wikimedia Commons [online] 2. 7. 2006. [v. 2014-07- 11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Vienna.Sipahis.jpg?uselang=ru 4. Podpis míru ve Sremských Karlovcích. Při jednání byl poprvé použit kulatý stůl, aby žádná strana nebyla zvýhodněna Zdroj: Farkasven. Peace conference in Karlowitz. Wikimedia Commons [online] 29. 1. 2010. [v. 2014-07-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Negociation_of_the_peace_of_karlowitz.jpg 119 VÝCHODNÍ OTÁZKA 5. Východní část rakousko-turecké hranice po míru ve Sremských Karlovcích Zdroj: Panonian. Map of the Eyalet of Temesvar and Military Frontier in 1702. Wikimedia Commons [online] 14. 9. 2013. [v. 2014-07-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyalet_of_te- mesvar1699.png 120 Obrazová část 6. Mapa Evropy po Karlovickém míru (1700) Zdroj: Flanker. Western Europe in year 1700. Wikimedia Commons [online] 12. 3. 2008. [v. 2014-07-11]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_Europe_1700.jpg 121 VÝCHODNÍ OTÁZKA 7. -

Crop Prices in the Austrian Monarchy (1770–1816): the Role of Crop Failures and Money Inflation
ECONOMICS AND MANAGEMENT CROP PRICES IN THE AUSTRIAN MONARCHY (1770–1816): THE ROLE OF CROP FAILURES AND MONEY INFLATION J. Blahovec Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, Prague, Czech Republic The paper is based on data about local cereal prices in Bohemia recorded in the course of 46 years (1770–1816) by F.J. Vavák, Czech farmer living close to Prague. This information appeared in a series of his memoirs published within 1907–1938 and in 2009. The data analysis shows that annual means of prices of wheat, rye, and barley are relatively well correlated and can be used for illustration of the state monetary situation. A higher variation of the annual mean values was observed only in times of crop failure and was also related to the new harvest. The data obtained for pea differ from the data mentioned above. It was shown that the market prices were influenced mainly by crop failures caused by weather and climate and by the state monetary policies. The money purchasing power was influenced either by objective causes, like crop failures of reversible character, or by subjective changes caused mainly by inflationary monetary policies which in the case of Austria had conduced to a state bankruptcy. cereals; market; weather; monetary policy; bankruptcy doi: 10.1515/sab-2015-0026 Received for publication on January 16, 2015 Accepted for publication on June 24, 2015 INTRODUCTION for financing a powerful army, the problem was re- solved traditionally by various methods of credit. For Austria started to change from a conservative Middle this reason, Banco dell Giro (1703) was founded, and Age country to a better, centrally managed one in the after its closing down later in 1705 it was replaced by 18th century. -

Progetto Corsa Su Strada: È Tempo Di Bilanci E Premiazioni
Scritto da : Alessandro Calleri il : mercoledì, 25 gen, 2012 Progetto corsa su strada: è tempo di bilanci e premiazioni Giovedì 2 febbraio, nel corso della “Festa dell’Atletica”, l’assegnazione degli ambiti riconoscimenti ai vincitori per categoria della manifestazione, valida per il Campionato provinciale individuale e di società riservato ad Assoluti e Amatori/Master maschili e femminili. Quindici le tappe disputate, dal 29 maggio al 18 dicembre. Si svolgeranno giovedì 2 febbraio, durante l’attesa “Festa dell’Atletica”, in programma presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, le premiazioni dei vincitori relativi al “Progetto di Corsa su Strada” edizione 2011, valido per il Campionato provinciale individuale e di società riservato alle categorie Assoluti e Amatori/Master maschili e femminili. Le classifiche finali sono state stilate per effetto dei punti assegnati nel corso delle quindici tappe. In corso d’opera il calendario ha subito qualche modifica rispetto a quanto inizialmente predisposto su organizzazione del Comitato Provinciale FIDAL di Messina (con la collaborazione di Indomita Torregrotta, Podistica Capo d’Orlando, Atletica Nebrodi, Pol. Europa Messina, Marathon Club Taormina, Avis Castell’Umberto e Athlon San Giorgio). La manifestazione, che ha preso ufficialmente il via il 29 maggio 2011 con il trofeo Sant’Annibale per concludersi il 18 dicembre a Santa Teresa Riva, prevedeva gli ambiti riconoscimenti per i primi sei atleti di ogni categoria, maschile e femminile, le prime 6 società maschili e le prime 3 società femminili. Esaminando le graduatorie e soffermandosi sugli atleti classificati (almeno 10 le partecipazioni alle prove richieste per gli atleti, 12 per le società), a livello individuale gradino più alto del podio, tra gli Assoluti femminili, per Ines Pesavento (Club. -

CIRICE20 21 La Città Palinsesto / the City As Palimpsest
Con il patrocinio di / Under the patronage of Enti promotori/ Promoting institutions UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL’ICONOGRAFIA DELLA CITTÀ EUROPEA CIRICE 20_21 IX CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI / 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE 10-12 giugno 2021 / 10-12 june 2021 Teams / Participation Link: https://forms.office.com/r/GRMeaRcZ78 Università degli Studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 Dipartimento di Architettura, via Forno Vecchio, 36 La Città Palinsesto / The City as Palimpsest TRACCE, SGUARDI E NARRAZIONI SULLA COMPLESSITÀ DEI CONTESTI URBANI STORICI TRACES, GAZES AND NARRATIONS ON THE COMPLEXITY OF HISTORICAL URBAN CONTEXTS PROGRAMMA / PROGRAM André Corboz utilizzò il termine palinsesto per proporre un’efficace metafora (Le territoire comme palimpseste) tra il documento pergamenaceo e la città e/o il territorio su cui l’uomo applica il proprio fare. La pergamena, che dal Medioevo ha tramandato le scritture, era un materiale di grande pregio e veniva più volte riutilizzato, abraso, talvolta invertito e riscritto, pur non perdendo mai la propria ‘stratificazione’, di cui rimanevano leggibili le tracce. La città e il suo territorio sono come una pergamena, trasformati dall’azione della natura e dell’uomo, e dotati nei secoli di significati differenti in relazione alle società che li modificano, senza però cancellare i segni del tempo, sia naturali sia antropici. Gli studi, che si sono perfezionati nel corso degli anni, sono ancora attuali? La risposta è chiaramente affermativa e i layer che appaiono oggi sovrapponibili nei tessuti urbani e nei loro territori rappresentano per la nostra società un’eredità da non cancellare, ma, anzi, da conoscere ed esaltare. -

3° Trofeo “CURRI CHI TI PIGGHIU“ Memorial SALVATORE ALIBERTI 1° Batteria ( Cat
3° Trofeo “CURRI CHI TI PIGGHIU“ Memorial SALVATORE ALIBERTI 1° Batteria ( cat. Femminili ed Amatori da MM50 ) Pos. Pett Atleta Società Ctg Pos. Ctg 1 283 Fiammante Giuseppe Indomita Torregrotta M50 1 2 2647 Pollicino Giuseppe Pol. Milazzo M55 1 3 163 Buzzurro Vincenzo Stile Libero M50 2 4 2175 Balletta Tindaro Podistica Messina M50 3 5 2176 Tripodi Giovanni Podistica Messina M50 4 6 380 Catalfamo Francesco Pol. Milazzo M60 1 7 51 Latteri Francesco Podistica Messina M50 5 8 194 Mollura Antonino Stile Libero M50 6 9 230 Romano Filippo Forte Gonzaga M55 2 10 64 Salvo Salvatore Atl. Villafranca M60 2 11 11 Irrera Antonino Stile Libero M55 3 12 2198 Maio Giuseppe Pol. Milazzo M60 3 13 140 D’Andrea Francesco Podistica Messina M55 4 14 26 Speciale Domenico Stile Libero M50 7 15 2177 Triglia Giuseppe Podistica Messina M55 5 16 641 Lo Nardo Francesco Odysseus M50 8 17 127 Piccolo Mauro Stile Libero M50 9 18 355 Cosenza Salvatore Fiamma Messina M55 6 19 2200 Triglia Luigi Podistica Messina M55 7 20 457 Castorina Valentina Podistica Messina TF 1 21 102 Colafati Francesca Fidippide TF 2 22 477 Pensante Carmelo Podistica Messina M55 8 23 161 Smedile Giuseppe Proform Messina M55 9 24 2195 Repaci Gabriella Podistica Messina TF 3 25 27 Gasparro Carmela Podistica Messina F40 1 26 966 Barbera David M.C. Taormina M60 4 27 442 Pirrone Giuseppina Forte Gonzaga F50 1 28 410 Scolaro Domenico Forte Gonzaga M55 10 29 78 Indelicato Maria Podistica Messina F40 2 30 479 Bitto Davide Podistica Messina M50 10 31 917 Pilota Carmelo M.C. -

Fortalezas Y Castillos Españoles De Italia. La Fortificación Como Arte Real
111 Fortalezas y castillos españoles de Italia. La fortificación como Arte Real Antonio Sánchez-Gijón Doctor ABSTRACT The long-lasting sovereignty exercised by the houses of Aragón and of Spain over large parts of Italy required the deployment of a great number of defense fortified complexes: castles, walled cities and ports, fortresses and watch towers, powder bunkers, etc., in Sicily (XIV-XVIII centuries), Sardinia (XIV-XVIII), the old kingdom of Naples (XV-XVIII), the state of Milan and the Lombardy (XVI-XVIII) and several outposts of strategic significance as the Toscana Presidios, Piombino, Finale, Valtellina, etc. Monarchs took a keen interest in planning and executing these vast works, and military engineers raised the art of fortification to new heights. La España de los siglos XIV a XVIII hizo una contribución muy importante al patrimonio italiano de castillos y fortalezas. Los reinos de Sicilia, Cerdeña y Nápoles fueron incorporados a la Corona de Aragón, sucesivamente, en los siglos XIII, XIV y XV, El Milanesado entró a formar parte de los dominios imperiales de Carlos V en el siglo XVI. En este mismo siglo se incorporaron aún algunos pequeños señoríos, de especial valor estratégico, como los Presidios de Toscana, Finale Ligure, etc. Todos esos extensos territorios eran gobernados por virreyes o capitanes generales, en nombre del rey de España. Los reinos y estados italianos de los reyes españoles poseían, desde antes de su entrada en la órbita española, un patrimonio poliorcético de enorme importancia. La mayor parte de las fortalezas antiguas fueron conservadas por los españoles, y en muchos casos aumentadas y perfeccionadas. -

German Settlers in the Balkans and the Volga River Basin
Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences Volume 16 Issue 2 Article 14 2013 Colonial Dreams, Ambiguous Outcomes: German Settlers in the Balkans and the Volga River Basin Timothy Olin Purdue University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.butler.edu/jiass Part of the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Olin, Timothy (2013) "Colonial Dreams, Ambiguous Outcomes: German Settlers in the Balkans and the Volga River Basin," Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences: Vol. 16 : Iss. 2 , Article 14. Retrieved from: https://digitalcommons.butler.edu/jiass/vol16/iss2/14 This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Butler University. It has been accepted for inclusion in Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences by an authorized editor of Digital Commons @ Butler University. For more information, please contact [email protected]. Colonial Dreams, Ambiguous Outcomes: German Settlers in the Balkans and the Volga River Basin* TIMOTHY OLIN Purdue University ABSTRACT This article surveys the phenomenon of German colonization in Eastern Europe from a comparative perspective. On examination of the origins and outcomes of German settlement in the northern Balkans and southern Russia, a number of shared characteristics anD circumstances appear. From beginnings in multinational empires to Dissolution under the combined pressure of nationalism and communism, the German settler communities represent an interesting case study in the shift from an imperial to a national perspective in Eastern Europe. The Germans were successful in fulfilling the goals of the Russian and Habsburg imperial governments; they increased agricultural production and helped integrate the regions into the European sphere of influence. -
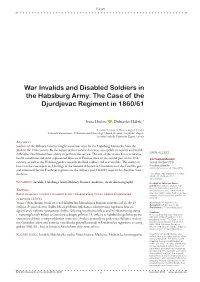
War Invalids and Disabled Soldiers in the Habsburg Army: the Case of the Djurdjevac Regiment in 1860/61
Essay War Invalids and Disabled Soldiers in the Habsburg Army: The Case of the Djurdjevac Regiment in 1860/61 Ivana Horbec1 , Dubravko Habek2,3 1 Croatian Institute of History, Zagreb, Croatia 2 University Department of Obstetrics and Gynecology Clinical Hospital “Sveti Duh”, Zagreb, 3 Croatian Catholic University, Zagreb, Croatia ABSTRACT: Soldiers of the Military Frontier fought numerous wars for the Habsburg Monarchy from the 16th to the 19th century. By the nature of their service they were susceptible to injuries and health difficulties that limited their ability to perform the service. The aim of this research was to analyse OPEN ACCESS health conditions and most represented illnesses of Frontiersmen in the second part of the 19th Correspondence: century, as well as the Habsburg policy towards disabled soldiers and war invalids. The analysis is Ivana Horbec PhD based on the case report and findings of the General Arbitration Commission of the Varaždin gen- [email protected] orcid.org/0000-0002-4898-2555 eral command for the Đurđevac regiment in the military year 1860/61, kept in the Austrian State Archives. This article was submitted to RAD CASA - Medical Sciences as the Essay EYWORDS K : Invalids, Habsburgs Army, Military Frontier, medicine, medicohistoriography Conflict of Interest State- ment: The authors declare that the research was conducted in Sažetak: the absence of any commercial or financial relationships that could be Ratni invalidi i vojnici s invaliditetom u Habsburškoj vojsci: prikaz Đurđevačke construed as a potential conflict of pukovnije 1860/61. interest. Vojnici Vojne krajine borili su se za Habsburšku Monarhiju u brojnim ratovima od 16. -

Società Cod. Pol. Messina ME099 Indomita Torregrotta ME100 Atl
Società Società Cod. Pol. Messina ME099 Indomita Torregrotta ME100 Atl. Villafranca ME102 Tyndaris Pattese ME103 Fiamma Messina ME104 Torrebianca ME110 Amatori S.C. Duilia ME112 Pol. Milazzo ME158 Atl. Torrese ME159 Forte Gonzaga Messina ME162 Avis Castell'Umberto ME328 Stilelibero ME391 Pol.Europa Messina ME402 Athlon S.Giorgio ME440 M.C. Messina ME468 M.C. Taormina ME471 Fidippide Messina ME512 Taormina Athletic Club ME529 Odysseus Messina ME540 Podistica Messina ME591 Proform Messina ME735 Atl. Nebrodi ME635 Podistica Capodorlando ME629 TF R S o G c C c G o a c a A l n i S a p a o a t R c M L t o i F r d n i q o e o i u i e d t M t u s m D r a o s a C ' e n o s a j e i T a d i a M a r r m t e n p e o Situazione Gare r n l t r a a a i a t r l e n e t c n i r r i i l s e i d e t a V i a o o n i n n o e t i N° Atleta Cod. Soc. Società Cat. Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Pos Pt Totale Fatte Saltate Stato N° 1 Colafati Francesca ME512 Fidippide Messina TF 3 13 3 13 0 0 2 14 3 13 3 13 0 0 1 15 2 14 0 95 7 2 In 3 1 Castorina Valentina ME591 Podistica Messina TF 4 12 2 14 0 0 3 13 2 14 4 12 1 15 0 0 1 15 0 95 7 2 In 3 3 Ciraolo Cristina ME591 Podistica Messina TF 2 14 1 15 0 0 0 0 1 15 2 14 0 0 0 0 0 0 0 58 4 5 Out 4 Tripepi Luigia ME591 Podistica Messina TF 1 15 0 0 0 0 1 15 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3 6 Out 5 Repaci Gabriella ME591 Podistica Messina TF 0 0 4 12 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 2 14 3 13 0 51 4 5 Out 6 Cannavo’ Alessandra ME591 Podistica Messina TF 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 8 Out 7 Negro