00 Copertina DEP N.39 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Searching for a New Freedom
searching for a newA freedom Companion to African American History499 Edited by Alton Hornsby, Jr Copyright © 2005 by Blackwell Publishing Ltd Chapter Twenty-nine Searching for a New Freedom HASAN KWAME JEFFRIES In the immediate aftermath of emancipation, the lives of former bondsmen and bondswomen failed to meet their basic expectations. Quite simply, their lives too closely resembled the status quo antebellum. Indeed, African Americans remained landless, lacked ownership of the fruits of their labor, lost the vote (through elec- toral fraud and discriminatory changes to state constitutions) shortly after they had received it, and were subject to vicious, vulgar, and random acts of racial terrorism as a result of the federal government being more interested in protecting the southern economy than in protecting black folk. In response, African Americans organized to implement their vision of freedom, which differed substantially from that of white southerners and white northerners. By agitating for their civil and human rights, especially for good-quality education, political participation, personal safety, and control of their own labor, the former slaves launched the fight for racial justice that continues to this day (Harding 1981). The most important link in this intergenerational struggle is the modern Civil Rights Movement. It represents the most highly organized manifestation of African Americans’ post-emancipation search for a new freedom and, if measured narrowly in legislative terms, the most successful. Popular interest in the Civil Rights Movement has swelled during the last two decades. Evidence of this trend is the surge in the number of feature-length films that explore aspects and events of the civil rights era, such as Freedom Song and Boycott. -

MICA-DEC-ENG-FINAL.Pdf
CONTENTS VOL-15 ISSUE -12 Editor N.K. Jain Advisors Neeraj Chabra K.C.Gupta Registered Office Mahendra Publication Pvt. Ltd. NOBEL 103, Pragatideep Building, Plot No. 08, Laxminagar, PRIZE District Centre, New Delhi - 110092 TIN-09350038898 2019 w.e.f. 12-06-2014 Branch Office Mahendra Publication Pvt. Ltd. E-42,43,44, Sector-7, Noida (U.P.) For queries regarding Interview 5 promotion, distribution & Current Affairs - One Liner 6-9 advertisement, contact:- [email protected] Spotlight 10 Ph.: 09208037962 The People 11-15 Owned, printed & published by News Bites 16-45 N.K. Jain Word of English - Etymology 46 103, Pragatideep Building, Plot No. 08, Laxminagar, Nobel Prize 2019 47-55 District Centre, New Delhi - 110092 Designation : Who's Who 56 Please send your suggestions and grievances to:- Quiz Time - General Awareness 60-67 Mahendra Publication Pvt. Ltd. UPSSSC Lower Subordinate Exam 2019 68-82 CP-9, Vijayant Khand, Gomti Nagar Lucknow - 226010 CRP PO Mains - Model Paper 2019 83-113 E-mail:[email protected] © Copyright Reserved # No part of this issue can be printed in Subscription form is on Pg 57 whole or in part without the written permission of the publishers. # All the disputes are subject to Delhi jurisdiction only. Mahendra Publication Pvt. Ltd. Editorial “This power of democracy is a matter of pride for our country, something which we must always cherish, preserve and further strengthen.” Atal Bihari Vajpayee Dear Aspirants, We feel delighted to present to you the "December 2019" edition of "Master In Current Affairs". MICA is a comprehensive magazine focused on both the intellectual and competitive nature of learning. -

Featuring Ernest J. Gaines
RESOU R C E S • S E R V I C E S • E VENTS FEB R UA R Y 2 0 0 9 Inside the Writer’s Workshop: Featuring Ernest J. Gaines he Library proudly comprehensive program, which announces the Gala will strengthen our community and Tkick-off for the Spring bring our diverse region together. 2009 Big Read: One Book/ Louisiana has an overall literacy One Community program, rate of 27%, and that includes the sponsored by The Big Read, Baton Rouge population. This East Baton Rouge Parish Library and the Baton Rouge modern classic by Louisiana’s Area Chamber. The event will begin with a soulful own native son Ernest Gaines is reception featuring a flavor-filled menu, continue with a particularly good choice for our a conversation with Ernest Gaines, and follow with a region, long plagued by a history of presentation of the classic film based on Gaines’ novel, low-literacy rates, racial injustice A Lesson Before Dying. The Gala will be held at the and unrest. A Lesson Before Dying’s topics of heroism, Baton Rouge Community College Magnolia Performing personal responsibility, compassion, forgiveness, social Arts Pavilion, on Thursday, February 12, at 6:00 p.m. justice, and dying with dignity are all subjects which After the FREE movie screening, audience members will cannot be separated from any exploration of the human participate in a moderated panel discussion. Admission experience. is free and open to the public. Copies of A Lesson Before Dying, accessible in a The Big Read: One variety of formats including print, audio, and movies, Book/One Community are available not only in libraries, but also in classrooms, is a community-wide churches, clubs, community centers, and businesses reading program where throughout the nine-parish area. -

Gandhiji's Historic Padayatra in Odisha
Odisha Review ISSN 0970-8669 Gandhiji's Historic Padayatra in Odisha Balabhadra Ghadai ahatma Gandhi was a humanist and country. The beginning of Gandhiji’s protest Mradical revivalist who fought not only against untouchability had a wonderful against colonialism and imperialism of response in Odisha. Gandhiji’s ‘fast unto foreigners but also fought against casteism, death’ in protest against ‘Communal Award religious hatred, superstitious practices, of August 1932’ was one of the most social oppression, economic exploitation etc. with equal vigour and dynamism. To him, the institution of untouchability was the “the most painful and difficult social problem, with history has ever cursed the civilized people. Moreover he argued the removal of untouchability as ‘key to Swaraj’. By Swaraj he did not simply mean liberation from foreign rule but it was a society free from all injustice and exploitation. The incorporation of removal of untouchability in the constructive programme of the National successful actions of his life which aroused Congress by Mahatma Gandhi made it a great anxiety in the millions in Odisha. The national concern and gave impetus to the Congress workers engaged themselves in uplift of the depressed classes all over the removal of untouchability in the state. The OCTOBER - 2019 65 Odisha Review ISSN 0970-8669 Harijan movement which he started under and Tarun Sahitya Samaj together with the banner of constructive programmes in purses of Rs.400 and Rs. 21 respectively. Odisha occupies a special place in the social Gandhiji felt, ‘the Harijan Movement history of modern India. Gandhiji visited is religious by nature. All great religions owe Odisha eight times. -

Worldwide Please Post in Your Temple
ISKCON - The International Society for Krishna Consciousness (Founder Acharya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) 2018 Newsletter WORLDWIDE PLEASE POST IN YOUR TEMPLE Harer nama harer nama harer namaiva kevalam kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha " In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way." Brhan-naradiya Puraṇa[38.126] Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare ataeva saba phala deha’ yāre tāre khāiyā ha-uk loka ajara amare Distribute this Krishna consciousness movement all over the world. Let people eat these fruits [of love of God] and ultimately become free from old age and death. Sri Caitanya Mahaprabhu (CC, Adi-lila 9-39) Table Of Contents Editorial 1 by Lokanath Swami The Padayatra Ministry is recruiting 3 Why do I love padayatra? 4 by Gaurangi Dasi Padayatra Worldwide Ministry and Website 6 Voices of worldwide padayatris 7 Prabhupada on his morning walk 24th Czech padayatra 14 by Nrsimha Caitanya Dasa This newsletter is dedicated to ISKCON Founder-Acarya, Highlights of the 2017 All India Padayatra 17 His Divine Grace by Acarya Dasa A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The Andhra Pradesh/Telangana padayatra 20 by Visnuswami Dasa “I am glad to learn that in Philadelphia they are increasing sankirtana. It is Bhaktimarga Swami’s walk across the US 21 our life and soul. Sankirtana should be increased as much as possible. -

(Nga) En Die On1wikkeling Van Sw Art Plaaslike Regering
NIE-GEWELDDADIGE AKSIE (NGA) EN DIE ON1WIKKELING VAN SWART PLAASLIKE REGERING : 'N IIlSTORIES-KRITIESE ONTLEDING - 1982 TOT 1994 deur PETRUS JACOBUS VIVIER DU TOIT voorge1e luidens die vereistes vir die graad DOCTOR LITTERARUM ET PIDLOSOPHIAE in die vak ONTWIKKELINGSADMINISTRASIE aan die UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA PROMOTOR: PROF F C DE BEER NOVEMBER 1995 (i) VOORWOORD Elke mens moet horn onderwerp aan die owerhede wat oor horn gestel is. (Romeine 13: 1) Dit was 'n besondere ervaring om 'n proefskrif te skryf oor plaaslike regering in 'n land waar onderwerping aan die owerhede vir baie jare bepaalde, eiesoortige knelpunte opgelewer het. Naas my opregte dank teenoor ons Hemelse Vader vir die geleentheid my gegun om hierdie navorsing onverhinderd te kon voltooi, wil ek graag die volgende persone en instansies bedank sonder wie se hulp en ondersteuning die mylpaal nie bereik kon word nie. * My promotor prof. Frik de Beer vir sy deeglike leiding en vriendelike hulp wat my deurgaans beskore was. * My kollegas van die Gauteng Provinsiale Regering (voorheen Transvaalse Provinsiale Administrasie) vir hulle ondersteuning en aanmoediging. * Die Gauteng Provinsiale Regering en die voormalige Transvaalse Provinsiale Administrasie vir finansiele ondersteuning. * Die Instituut vir Eietydse Geskiedenis aan Die Universiteit van die Oranje Vrystaat vir besondere moeite met die verkryging van spesifieke navorsingsmateriaal. * Die Unisa argiefpersoneel vir hulle hulp. * Mev. llrkia Bierman vir haar toegewydheid in die proeflees van die manuskrip. * Mevv. Fransie Badenhorst en Gillian Jooste vir die netjiese en korrekte wyse waarop hul die tikwerk afgehandel het. * Laastens, 'n baie spesiale woord van dank en waardering aan my vrou Cora vir haar liefde, aanmoediging en eindelose ure van "alleen wees" terwyl daar gewerk moes word. -

And the Environment Resistance, Social Change
Resistance, Social Change, and the Environment Introduction Environment is one of the key sites of global social change, with environ- mental activist groups seeking to draw attention to the effects of specific practices on the environment, and subsequently seeking to impact policy making and practices that shape the environment (Castells, 1996, 1997, 1998; della Porta & Diani, 2006; Rootes, 2004; Sklair, 1995). In our discus- sion of the politics of resistance in this chapter, we will specifically focus on global social change movements that emphasize local participation and processes of change, situated amidst the broader backdrop of claims making and presentation of arguments that seek to impact the realms of policy making and programming. Drawing upon examples from the global North as well as from the South, we will particularly examine the ways in which social change processes are constituted amidst policy frameworks and articulations across various global spaces. We will attend to the discursive pro- Chapter cesses and strategies through which resistive efforts Four of transforming environmental policies are played out. The voices of resistance weaved together in this 137 138 Resistance, Social Change, and the Environment chapter create opportunities for engaging in dialogue with alternative rationalities for organizing the environment and, more importantly, the knowledge about the environment. In the voices of resistance to the global politics of the environment, entry points are created for disrupting the monolithic narratives of global policies that are dictated by the powerful influences of transnational cor- porations (TNCs) in shaping global, national, and local environmental policies (Pezzullo, 2004; Rootes, 2002a, 2002b; Sklair, 1995; Smith, 2002; Yearley, 1994, 1996; Yearley & Forrester, 2000). -

Civil Rights + Black Baton Rouge a Brief History
THE MISSOURI COMPROMISE KANSAS-NEBRASKA ACT BROWN V. BOARD OF EDUCATION Missouri is admitted as a slave Repealing of The Missouri Supreme Court declares state laws establishing separate CIVIL RIGHTS + state and Maine as a free state to Compromise public schools for black and white students to be 1854 1954 preserve the balance of power in 1820 unconstitutional, overturning Plessy v. Ferguson. Congress and prohibited slavery DRED SCOTT DECISION BLACK BATON ROUGE in the Louisiana Territory north of THE Supreme Court declares The Missouri GREAT LITTLE ROCK NINE the The Mason-Dixon Line at 36° Compromise as unconstitutional, stating 30´ latitude 1857 MIGRATION President Eisenhower intervenes over an Arkansas Governor to Congress did not have the authority to force the admission of nine African American students into a A BRIEF HISTORY prohibit slavery in the territories 1910 through 1970s 1957 segregated high school NEW GOVERNMENT IN FRANCE Gradual movement of 6 million France passes a decree freeing all slaves EMANCIPATION PROCLAIMATION African-Americans (47% of all Blacks in CIVIL RIGHTS ACT in its colonies (not legally affecting 1794 13th, 14th, and 15th Ammendments to the Constitution the US) from the rural South of Jim Crow Segregation is outlawed in public places, and Spanish-ruled Louisiana at the time, but of the United States abolish slavery, recognize Black employment discrimination by race, color, 1865 to industrial jobs in the North and West 1964 further increasing fear of slave rebellion). citizenship, and create voting rights for Black men over the course of about 60 years. religion, sex or national origin is banned US INDEPENDENCE FROM BRITAIN PLESSY V. -

Study Guide for the 26Th Annual SU Ag Center and College of Agricultural, Family and Consumer Sciences Collegiate Black History Quiz Bowl February 20, 2020 T
Study Guide for the 26th Annual SU Ag Center and College of Agricultural, Family and Consumer Sciences Collegiate Black History Quiz Bowl February 20, 2020 T. T. Allain Building, 3rd Floor Prepared by Dr. Owusu Bandele Note: These are mostly last year’s questions and answers. They will be reworded this year. There are a few additional questions at the end for you to answer on your own. College 1 1. What was the title of Ralph Ellison’s classic novel? “Invisible Man” 2. ***Who founded the River Road African American Museum and in what city in Louisiana is it located? Kathe Hambrick, Donaldsonville 3. **Who is the only African American lady in the U.S. Senate and what other African American lady served as U.S. Senator? Kamala Harris, Carol Moseley Braun 4. On what date in 1965 was Malcolm X assassinated? February 21 5. Why are schools closed in Berkeley, California on May 19? Birthday of Malcolm X 6. ****Who delivered the eulogy at the funeral of Malcolm X and how did he describe Malcolm X in that eulogy? Ossie Davis, our Black shining prince 7. Ossie Davis and his wife Ruby Dee had roles in what Spike Lee Movie? “Do the Right Thing” 8. What famous Grammy-winning artist received major backlash in 2018 for claiming that slavery was a choice and being a proud supporter of Donald Trump? Kanye West 9. What was the name of the abolitionist newspaper founded by Frederick Douglass? The North Star 10. Why was the true North Star in the sky important to enslaved Africans and African Americans? The star helped runaways to find their way to the north. -

Strengthening Democracy Through Nonviolence
WORKSHOP DOCUMENT The Workshop Facilitators Strengthening Stuart Morton (UK) Democracy Thayaparan (Sri Lanka) Through Nonviolence Archana (Ind) Viv & Martha (USA) 9-18 December 2009 Venue Venue:Mahatma Gandhi Sewa Ashram, Joura, Morena SopAPA Document SECRETARIAT, Strengthening 2/3 BLOCK Democracy A, JANGPURA,Through Non-violence NIZAMUDDIN, NEW DELHI 110014 Phone; 011-24373998, Mobile: 91-9427700762 E-mail: [email protected] STRENGTHENING DEMOCRACY THROUGH NON-VIOLENCE Our Peace Builders First Row: (From Left) Martha Kemper, Viv Hawkins, Sherlin, Archana, Piyush Second Row: (From Left) Nasir, Mrutunjay, Stuart, Vishwatma, Thayaparan, Ganga Last Row: From Left: Vijay Bharatiya, Nishanta, Ashik, Harendra, Kinzang, Benzi, and Sonam Workshop Document: Strengthening Democracy Through Non-violence Page 2 WORK SHOP DOCUMENT CONTENTS 1. BACKGROUND : T HE CONTEXT OF THE WORKSHOP... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... .... ..4 2. EXPLORING THE THEME: DEMOCRACY ... ... ... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ..... ... 7 3. TRANSFORMING POWER ... POWER TO POWERLESS... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ....... ...8 4. VIOLENCE & NON VIOLENCE ... ... ... ... ... ...... ... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... 12 5. TOOLS FOR STRENGTHENING DEMOCRACY THROUGH NON-VIOLENCE 15 i. ALTERNATIVES TO VIOLENCE ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ... 16 ii.PILLARS OF POWER ... ... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... ...... ...... ... .. -

Report of the Activities of the Gandhi Study Circle (July 2017-April 2018)
1 Report of the activities of the Gandhi Study Circle (July 2017-April 2018) 21 September 2017 In collaboration with Loktantrashala, School for Democracy, the Gandhi Study Circle organized a lecture by P.V. Rajagopal of Ekta Parishad on “Mahatma Gandhi and the Theory of Non-Violence”. P. V. Rajagopal spoke on the significance of training in the methods of non-violence all across the world and of the use of the padayatra as active non-violence. 2 9 October 2017 The month long Gandhi Jayanti celebrations coincided with the inauguration of the Kalavati Gupta Hostel. This event was marked by: a welcome song by the Equal Opportunities Cell; a bhajan by Vasundhara Raturi of B.A. (Hons) Music; the hymn “Abide with Me” by the Western Music Society; and the Ram Dhun by Alaap. Nivedita Tuli spoke on “Indraprastha College’s Gandhian Connection”, and drew attention to different aspects such as the charkha society of the college that began in 1943 under the aegis of the Social Service League, and functioned till 1948. 3 13 October 2017 In collaboration with Loktantrashala, School for Democracy, the Gandhi Study Circle organized a lecture on “Gandhi in the Contemporary World” by Rajni Bakshi. Rajni Bakshi spoke on the continuing relevance of Gandhi and the methods of non-violence in an increasingly violent world. “Gandhi in the Contemporary World” lecture by Rajni Bakshi 4 14 October 2017 A screening of excerpts from the movie “Gandhi” was held, followed by a discussion of the movie as well as on the article “The Gandhi Everyone Loves to Hate” by Vinay Lal. -
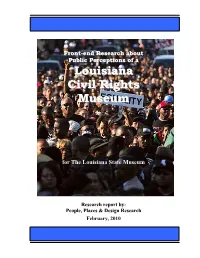
Summative Evaluation
lt Front-end Research about Public Perceptions of a LLoouuiissiiaannaa CCiivviill RRiigghhttss MMuusseeuumm for The Louisiana State Museum Research report by: People, Places & Design Research February, 2010 Front-end Research about Public Perceptions of a Louisiana Civil Rights Museum Contents Front-end Research: Executive Summary . 1 First Study: Intercept Interviews in New Orleans . 2 Research Conclusions . 3 A. Interest in Louisiana History . 5 B. Interest in Civil Rights . 6 C. Interest in Civil Rights Themes . 8 D. Initial Interest in Visiting . 9 E. Characteristics of the Sample . 10 Second Study: Focus Groups in Three Cities . 11 Research Conclusions . 12 Overview, Research Strategy, Principal Results Opportunities . 15 A. Interest in Cultural History . 16 B. Regional Differences in Louisiana . 25 C. Interest in Current and Historical Eras . 29 D. Top-of-Mind Associations with “Civil Rights”. 32 E. “Other” Civil Rights Movements . 36 Challenges . 43 F. Awareness of the Civil Rights Movement. 44 G. Louisianan Visitors to New Orleans . 46 H. Emotional Perceptions of Civil Rights . 48 I. Interest in “Cultural Conflict” . 50 J. Initial Interest in Visiting a Civil Rights Museum. 62 K. Sensitivity to Perceptions of Racism . 63 Research Report prepared by Brian Werner & Jeff Hayward People, Places & Design Research Northampton, Massachusetts February, 2010 Front-end Research about Public Perceptions of a Louisiana Civil Rights Museum 1 Executive Summary This “Front-end Research” report presents the results of two complementary audience studies, both intended to explore the public’s knowledge, interests and openness to Louisiana’s civil rights history. The first study is based on intercept interviews (primarily quantitative) of people at various locations in New Orleans.