Il Carteggio Fra Giovanni Vailati E Vito Volterra*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A New Vision of the Senses in the Work of Galileo Galilei
Perception, 2008, volume 37, pages 1312 ^ 1340 doi:10.1068/p6011 Galileo's eye: A new vision of the senses in the work of Galileo Galilei Marco Piccolino Dipartimento di Biologia, Universita© di Ferrara, I 44100 Ferrara, Italy; e-mail: [email protected] Nicholas J Wade University of Dundee, Dundee DD1 4HN, Scotland, UK Received 4 December 2007 Abstract. Reflections on the senses, and particularly on vision, permeate the writings of Galileo Galilei, one of the main protagonists of the scientific revolution. This aspect of his work has received scant attention by historians, in spite of its importance for his achievements in astron- omy, and also for the significance in the innovative scientific methodology he fostered. Galileo's vision pursued a different path from the main stream of the then contemporary studies in the field; these were concerned with the dioptrics and anatomy of the eye, as elaborated mainly by Johannes Kepler and Christoph Scheiner. Galileo was more concerned with the phenomenology rather than with the mechanisms of the visual process. His general interest in the senses was psychological and philosophical; it reflected the fallacies and limits of the senses and the ways in which scientific knowledge of the world could be gathered from potentially deceptive appearances. Galileo's innovative conception of the relation between the senses and external reality contrasted with the classical tradition dominated by Aristotle; it paved the way for the modern understanding of sensory processing, culminating two centuries later in Johannes Mu« ller's elaboration of the doctrine of specific nerve energies and in Helmholtz's general theory of perception. -

NSP4 Pragmatist Kant
Nordic NSP Studies in Pragmatism Helsinki — 2019 Giovanni Maddalena “Anti-Kantianism as a Necessary Characteristic of Pragmatism” In: Krzysztof Piotr Skowronski´ and Sami Pihlstrom¨ (Eds.) (2019). Pragmatist Kant—Pragmatism, Kant, and Kantianism in the Twenty-first Century (pp. 43–59). Nordic Studies in Pragmatism 4. Helsinki: Nordic Pragmatism Network. issn-l 1799-3954 issn 1799-3954 isbn 978-952-67497-3-0 Copyright c 2019 The Authors and the Nordic Pragmatism Network. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License. CC BY NC For more information, see http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Nordic Pragmatism Network, NPN Helsinki 2019 www.nordprag.org Anti-Kantianism as a Necessary Characteristic of Pragmatism Giovanni Maddalena Universit`adel Molise 1. Introduction Pragmatists declared their anti-Cartesianism at the first appearance of the movement, in Peirce’s series on cognition written for the Journal of Specu- lative Philosophy (1867–8). As is well known, the brilliant young scientist characterized Cartesian doubt as a “paper doubt”, by opposing it to sci- entists’ true “living doubt” (Peirce 1998 [1868], 115).1 Some readers have not understood the powerful novelty that his opposition to Cartesianism implies. According to Peirce, research does not proceed from skeptical, “paper” doubt. For Peirce, doubt is possible because of a previous cer- tainty, a position which is similar to the one held by Augustine (Augustine 1970). Research moves from one certainty to another; the abandonment of an initial certainty is only reasonable in the presence of a real and surprising phenomenon that alters one of the pillars on which it stands. -
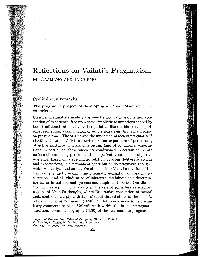
Reflections on Vailati's Pragmatism
Reflections on Vailati's Pragmatism M. CAAMANO AND P. SUPPES Preliminary remarks The pragmatic project of developing a richer notion of experience Classical pragmatists made a sustained effort to develop a new con ception of experience, free from some simplistic assumptions shared by both traditional rationalists and empiricists, like the idea that experi enceresults from a combination of simple sensations. In his main paper on pragmatism, "The origins and the fundamental idea.of pragmatism" (1909b), Giovanni Vailati characterized our experience of permanent, objective existence in terms of a certain kind of conditional expecta tions, in particular, those which are conditioned to certain deliberate actions of ours being performed. His experiential account of objective existence, based on a systematic relation between deliberate actions and expectations, is a permanent contribution to pragmatic thought, which we analyze and assess. We also consider Vailati's revision of the l"eircean pragmatic maxim, the pragmatic evaluation of meaningless assertions, and his vindication of inferential usefulness as a determin ing factor in both formal systems and empirical theories. Our discus sion will as well include a critical analysis of some less satisfactory aspects of Vailati's thought, whose Brentanian conception of mental facts contrasts sharply with James' sophisticated study of the mind in The Principles of Psychology (1890). But let us now make some prelim inary comments to place Vailati's work within the broader pragmatic tradition. Evans' bibliography (1930) of the references to pragmatism Logic and Pragmatism. Selected Essays QY Giovanni Vailati. C. Arrighi, P. Cantu, M. De Zan, and P. Suppes. Copyright © 2009, CSLI Publications. -

European Journal of Pragmatism and American Philosophy
European Journal of Pragmatism and American Philosophy XI-1 | 2019 European Pragmatism Vailati, Papini, and the Synthetic Drive of Italian Pragmatism Giovanni Maddalena Electronic version URL: http://journals.openedition.org/ejpap/1533 DOI: 10.4000/ejpap.1533 ISSN: 2036-4091 Publisher Associazione Pragma Electronic reference Giovanni Maddalena, « Vailati, Papini, and the Synthetic Drive of Italian Pragmatism », European Journal of Pragmatism and American Philosophy [Online], XI-1 | 2019, Online since 19 July 2019, connection on 21 July 2019. URL : http://journals.openedition.org/ejpap/1533 ; DOI : 10.4000/ejpap.1533 This text was automatically generated on 21 July 2019. Author retains copyright and grants the European Journal of Pragmatism and American Philosophy right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. Vailati, Papini, and the Synthetic Drive of Italian Pragmatism 1 Vailati, Papini, and the Synthetic Drive of Italian Pragmatism Giovanni Maddalena 1. Introduction 1 According to the standard interpretation, Italian pragmatism is split into two groups. On the one hand is the mathematician Giovanni Vailati, Peano’s former collaborator, and his disciple, the economist Mario Calderoni. On the other hand, there are the two “brats,” Giovanni Papini and Giuseppe Prezzolini, naïve philosophers with eccentric ideas. While Vailati and Calderoni followed Peirce’s mathematical and logical pragmatism, the other two articulated a “magical” pragmatism, a kind of relativist, post-modern version of the original American movement. This latter view can be found in Papini’s description of it,1 and the twofold description of the Italian pragmatism has become a common place of the scholarship. -

Giuseppe Peano and His School: Axiomatics, Symbolism and Rigor
Philosophia Scientiæ Travaux d'histoire et de philosophie des sciences 25-1 | 2021 The Peano School: Logic, Epistemology and Didactics Giuseppe Peano and his School: Axiomatics, Symbolism and Rigor Paola Cantù and Erika Luciano Electronic version URL: http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/2788 DOI: 10.4000/philosophiascientiae.2788 ISSN: 1775-4283 Publisher Éditions Kimé Printed version Date of publication: 25 February 2021 Number of pages: 3-14 ISBN: 978-2-38072-000-6 ISSN: 1281-2463 Electronic reference Paola Cantù and Erika Luciano, “Giuseppe Peano and his School: Axiomatics, Symbolism and Rigor”, Philosophia Scientiæ [Online], 25-1 | 2021, Online since 01 March 2021, connection on 30 March 2021. URL: http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/2788 ; DOI: https://doi.org/10.4000/ philosophiascientiae.2788 Tous droits réservés Giuseppe Peano and his School: Axiomatics, Symbolism and Rigor Paola Cantù Aix-Marseille Université, CNRS, Centre Gilles-Gaston-Granger, Aix-en-Provence (France) Erika Luciano Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Matematica, Torino (Italy) Peano’s axioms for arithmetic, published in 1889, are ubiquitously cited in writings on modern axiomatics, and his Formulario is often quoted as the precursor of Russell’s Principia Mathematica. Yet, a comprehensive historical and philosophical evaluation of the contributions of the Peano School to mathematics, logic, and the foundation of mathematics remains to be made. In line with increased interest in the philosophy of mathematics for the investigation of mathematical practices, this thematic issue adds some contributions to a possible reconstruction of the philosophical views of the Peano School. These derive from logical, mathematical, linguistic, and educational works1, and also interactions with contemporary scholars in Italy and abroad (Cantor, Dedekind, Frege, Russell, Hilbert, Bernays, Wilson, Amaldi, Enriques, Veronese, Vivanti and Bettazzi). -

Pragmatism and the Analysis of Meaning in the Philosophy of Giovanni Vailati
Differentia: Review of Italian Thought Number 3 Combined Issue 3-4 Spring/Autumn Article 20 1989 Pragmatism and the Analysis of Meaning in the Philosophy of Giovanni Vailati Robert E. Innis Follow this and additional works at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia Recommended Citation Innis, Robert E. (1989) "Pragmatism and the Analysis of Meaning in the Philosophy of Giovanni Vailati," Differentia: Review of Italian Thought: Vol. 3 , Article 20. Available at: https://commons.library.stonybrook.edu/differentia/vol3/iss1/20 This document is brought to you for free and open access by Academic Commons. It has been accepted for inclusion in Differentia: Review of Italian Thought by an authorized editor of Academic Commons. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Pragmatism and the Analysis of Meaning in the Philosophy of Giovanni Vailati Robert E. Innis 1. INTRODUCTION Giovanni Vailati's premature death in 1909, at the age of forty six, silenced a distinctive and original voice in Italian philosophy. In his work, so different in tone and method from Croce's idealism and anti-scientism, we find reflected and developed most of the great problems and themes which have come to the fore in twen tieth-century philosophy and semiotics. In spite of his remarkable linguistic skills, encompassing both modern and classical Ian- This essay is taken from part one of my book, Giovanni Vailati: Pragmatismand the Analysis of Meaning, to be published in the Foundations of Semiotics series by John Benjamins in Amsterdam. The book will also contain translations of Vailati's most important essays on pragmatism and language theory. -

Giovanni Vailati and the Art of Reasoning
Chapter 2 Giovanni Vailati and the Art of Reasoning Giovanni Maddalena There are some clichés in the reception of Vailati’s works and there is no more Vailatian exercise than to debunk them; and if it is not possible to do it with his same spirit of wit and lightness, it is hoped to have at least the same force of contents that the philosopher from Crema usually had. The first of these clichés considers Vailati as a precursor of analytic philoso- phy. This interpretation relies on a great number of data and many scholars adhere to it.1 According to this interpretation, Vailati was a pragmatist only in the provisional sense of the term: that is to say, if analytic philosophy had al- ready had a definite development, Vailati would have embraced it. Peirce’s logi- cal pragmatism was the closest theory to propositional analysis and this was the reason for Vailati’s adherence to the Florentine Leonardians’ strange com- panionship. It is thus a “second best choice” in which the thinker from Crema shared his experiences with less valuable fellows because of the lack of other philosophical points of reference matching his logical-mathematical training through which he could challenge the obsolete and parochial Italian culture. The second cliché is that if it is admitted that Vailati was actually an irreduc- ible pragmatist, his pragmatism would belong to the pure “Peircean” type, far from and critical of Papini and Prezzolini’s Nietzschean, occultist, and person- alist vagaries. According to this interpretation in Leonardo there was a coexis- tence of a “good” logical pragmatism, connected to Peirce’s famous pragmatic maxim, and a “bad” pragmatism, of a vague Jamesian ancestry.2 According to this standard two stripes theory, Vailati should be considered as the champion of Peirce’s correct pragmatist thought, with which he shares its settings and content. -

European Journal of Pragmatism and American Philosophy
European Journal of Pragmatism and American Philosophy III-1 | 2011 Contemporary Reassessment of William James a Century Later The Sign of the Four Italian Pragmatists Retold Giovanni Maddalena and Giovanni Tuzet Electronic version URL: http://journals.openedition.org/ejpap/877 DOI: 10.4000/ejpap.877 ISSN: 2036-4091 Publisher Associazione Pragma Electronic reference Giovanni Maddalena and Giovanni Tuzet, « The Sign of the Four », European Journal of Pragmatism and American Philosophy [Online], III-1 | 2011, Online since 01 July 2011, connection on 30 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/ejpap/877 ; DOI : 10.4000/ejpap.877 This text was automatically generated on 30 April 2019. Author retains copyright and grants the European Journal of Pragmatism and American Philosophy right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. The Sign of the Four 1 The Sign of the Four Italian Pragmatists Retold Giovanni Maddalena and Giovanni Tuzet AUTHOR'S NOTE A previous and partial version of this paper has been published as introduction of Maddalena-Tuzet 2007. 1 Italian pragmatism has been investigated many times by historians of philosophy, but rarely are scholars of Italian pragmatism, both Italian and foreign, actual pragmatists.1 That is why it has been so often misinterpreted. Here we want to justify the importance of this small group of people more as representatives of a pragmatist movement than as singular systematic thinkers. This paper aims to be a pragmatist contribution to the study of our four philosophers. A contribution that treats them for what they called themselves: Italian pragmatists. -

Wittgenstein and Pragmatism
European Journal of Pragmatism and American Philosophy IV-2 | 2012 Wittgenstein and Pragmatism Christiane Chauviré and Sabine Plaud (dir.) Electronic version URL: http://journals.openedition.org/ejpap/592 DOI: 10.4000/ejpap.592 ISSN: 2036-4091 Publisher Associazione Pragma Electronic reference Christiane Chauviré and Sabine Plaud (dir.), European Journal of Pragmatism and American Philosophy, IV-2 | 2012, « Wittgenstein and Pragmatism » [Online], Online since 24 December 2012, connection on 23 September 2020. URL : http://journals.openedition.org/ejpap/592 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ ejpap.592 This text was automatically generated on 23 September 2020. Author retains copyright and grants the European Journal of Pragmatism and American Philosophy right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 1 TABLE OF CONTENTS Symposia. Wittgenstein and Pragmatism Introduction to the Symposium “Wittgenstein and Pragmatism: A Reassessment” Christiane Chauviré and Sabine Plaud A New Look at Wittgenstein and Pragmatism Sami Pihlström Who’s Calling Wittgenstein a Pragmatist? Judy M. Hensley Streams and River-Beds James’ Stream of Thought in Wittgenstein’s Manuscripts 165 and 129 Anna Bocompagni Wittgenstein, Ramsey and British Pragmatism Mathieu Marion Experience and Nature Wittgenstein Reader of Dewey? Christiane Chauviré Training, Training, Training The Making of Second Nature and the Roots of Wittgenstein’s Pragmatism Michael Luntley Wittgenstein, Dewey, and the Practical Foundation of Knowledge Jörg Volbers Group Morality and Forms of Life Dewey, Wittgenstein and Inter-Subjectivity Rick Davis A Philosophical Bestiary Joseph Margolis A Pragmatist Conception of Certainty Wittgenstein and Santayana Guy Bennett-Hunter Having Social Practices in Mind. -

Bachelard, Enriques and Weyl: Comparing Some of Their Ideas
Bachelard, Enriques and Weyl: comparing some of their ideas Giuseppe Iurato Department of Physics, University of Palermo, IT E-mail: [email protected] Abstract. Some aspects of Federigo Enriques mathematical philosophy thought are taken as central reference points for a critical historic-epistemological comparison between it and some of the main aspects of the philosophical thought of other his contemporary thinkers like, Gaston Bachelard and Hermann Weyl. From what will be exposed, it will be also possible to make out possible educational implications of the historic-epistemological approach. 1. Introduction Even in modern textbooks and treatises on History of Philosophy and Philosophy of Science, both Italian1 and foreign, there exist neither a whole chapter nor few sections, devoted to the fundamental epistemological work of Federigo Enriques, whose philosophical thought is dismissed in few lines amongst the subjects related to the modern Italian Philosophy between the end of the 19th-Century and the beginning of the 20th- one. An exception is made by both some prefaces to the various anastatic reprints of Federigo Enriques works and some remarkable collective and proceeding works mainly edited by the Centro Studi Federigo Enriques in Livorno (IT). All that is quite unfair respect to the wide cleverness and acuteness of the forerunner Enriques’ thought: he has been remembered only for his high and celebrated contributions to Algebraic Geometry, and only recently a certain further attention has appeared towards this author2. An almost identical or similar fate has been undergone by Giovanni Vailati, almost to witness that absurd but real (and still effective) kind of reciprocal dislike that there exist, by both sides, between philosophers and scientists, which embed its historical roots into the secular dispute between Geisteswissenschaften on the one hand, and the Naturwissenschaften on the other hand3. -

Bachelard, Enriques and Weyl: Comparing Some of Their Ideas
Bachelard, Enriques and Weyl: comparing some of their ideas Giuseppe Iurato Department of Physics, University of Palermo, IT E-mail: [email protected] Abstract. Some aspects of Federigo Enriques mathematical philosophy thought are taken as central reference points for a critical historic-epistemological comparison between it and some of the main aspects of the thought of other his contemporary thinkers like Gaston Bachelard and Hermann Weyl. From what will be exposed, it will be also possible descry eventual educational implications of the historic-epistemological approach. 1. Introduction Even in the modern textbooks and treatises on History of Philosophy and Philosophy of Science, both Italian1 and foreign, there exist neither a whole chapter nor few sections, devoted to the fundamental epistemological work of Federigo Enriques, whose philosophical thought is dismissed in few lines among the subjects related to the modern Italian Philosophy between the end of the 19th-Century and the beginning of the 20th- one. Make an exception both some prefaces to the various anastatic reprints of the Federigo Enriques works and some remarkable collective and proceeding works mainly edited by the Centro Studi Federigo Enriques in Livorno (IT). All that is quite unfair respect to the wide cleverness and acuteness of the forerunner Enriques’ thought: he has been remembered only for his high and celebrated contributions to Algebraic Geometry, and only recently a certain further attention has appeared towards this author2. An almost same fate has been undergone by Giovanni Vailati, almost to witness that absurd but real (and still effective) kind of reciprocal dislike, by both sides, between philosophers and scientists, which embed its historical roots into the secular dispute between Geisteswissenschaften on the one hand, and the Naturwissenschaften on the other hand3. -

Vailati and Peirce
Chapter 3 Algebraic Grammar, Geometric Grammar: Vailati and Peirce Susanna Marietti During the last years of his life, Giovanni Vailati devoted himself more to the strenuous defense of pragmatism than to scientific research. He spoke of prag- matism as the philosophical current he adhered to. The twentieth century was beginning and we can hear in Vailati’s words some echoes that belong between Charles Sanders Peirce’s pragmatism and an anticipation of those verification theories of meaning that would be successful in Europe and then in the United States a couple of decades later. Vailati spoke of the advantages of applying the analysis in terms of expectations to the propositions we deal with. They consist: first of all in the possibility of obtaining some kinds of expression of our or others’ beliefs apt more than every other to clarify to which operations or researches we should resort in order to confirm or refute them; sec- ondly in the fact that it is easier to distinguish, among our statements, those that can indeed be confirmed or refuted from those that escape every sort of evidence or refutation in the strict sense of the word, since they only refer to states of consciousness, whose presence can only and without appeal be evaluated by the single individual, or since they only look like assertions, actually being just sentences without meaning.1 And further: one of the inclinations most distinctive of the new philosophical doctrine called “pragmatism”—and its very definition, if we accept the one given by the American mathematician Ch. S. Peirce who introduced it— consists in seeing in the process of deduction something more than an instrument directed to establish the truth of theories or of scientific or philosophical hypothesis.