Art. Mancinforte CIARL.INTEGRALE QMM
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quaderni Musicali Marchigiani 14
Quaderni Musicali Marchigiani 14 a cura di Concetta Assenza Pubblicazione dell’A.Ri.M. – Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI 14/2016 a cura di Concetta Assenza ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) via P. Bonopera, 55 – 60019 Senigallia www.arimonlus.it [email protected] QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 Comitato di redazione Concetta Assenza, Graziano Ballerini, Lucia Fava, Riccardo Graciotti, Gabriele Moroni Realizzazione grafica: Filippo Pantaleoni ISSN 2421-5732 ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA PER LA RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLE FONTI MUSICALI (A.Ri.M. – onlus) QUADERNI MUSICALI MARCHIGIANI Volume 14 a cura di Concetta Assenza In copertina: Particolare dell’affresco di Lorenzo D’Alessandro,Madonna orante col Bambino e angeli musicanti, 1483. Sarnano (MC), Chiesa di Santa Maria di Piazza. La redazione del volume è stata chiusa il 30 giugno 2016 Copyright ©2016 by A.Ri.M. – onlus Diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, riservati per tutti i Paesi. «Quaderni Musicali Marchigiani» – nota Lo sviluppo dell’editoria digitale, il crescente numero delle riviste online, l’allargamento del pubblico collegato a internet, la potenziale visibilità globale e non da ultimo l’abbattimento dei costi hanno spinto anche i «Quaderni Musicali Marchigiani» a trasformarsi in rivista online. Le direttrici che guidano la Rivista rimangono sostanzialmente le stesse: particolare attenzione alle fonti musicali presenti in Regione o collegabili alle Marche, rifiuto del campanilismo e ricerca delle connessioni tra storia locale e dimensione nazionale ed extra-nazionale, apertura verso le nuove tendenze di ricerca, impostazione scientifica dei lavori. -

Tebaldo E Isolina
Francesco Morlacchi (1784–1841) Tebaldo e Isolina Laura Polverelli • Sandra Pastrana • Anicio Zorzi Giustiniani Raúl Baglietto • Gheorghe Vlad • Annalisa D’Agosto Camerata Bach Choir, Poznań • Virtuosi Brunensis Antonino Fogliani CD1 78:11 * Ecco i bellici concenti 5:46 (Geroldo, Coro, Isolina, Ermanno, Francesco 1 Sinfonia Andantino scherzoso – Allegro 7:02 Tebaldo, Boemondo, Clemenza) MORLACCHI Act I CD2 64:47 (1784–1841) 2 No. 1. Introduzione: Da’ tuoi figli, dagli amici 7:56 Act II (Coro, Clemenza, Geroldo, Ermanno) 3 Recitativo: Cavalieri, oh! di quanto 2:12 No. 8. Scena ed Aria: Tebaldo e Isolina (Ermanno, Geroldo, Clemenza) 1 Oh, Sigerto!… Sigerto! 5:44 No. 2. Coro e Cavatina: (Isolina, Clemenza) Melodramma romantico in two acts (1822–25) (Dresden version, 1825) 4 Bella stella mattutina – 4:01 2 Ah! che intesi! me infelice!... 5:09 Libretto by Gaetano Rossi (1774–1855) Oh! come lieto il cor (Isolina, Clemenza, Coro, Ermanno) (Coro, Isolina) 3 Cara figlia!... 5:55 5 Ah lusinghiera imagine 5:01 (Ermanno, Isolina, Coro) Boemondo .......................................................................................... Anicio Zorzi Giustiniani, Tenor (Isolina, Coro) No. 9. Scena, Coro ed Aria: 6 Recitativo: Cavalieri, una figlia 2:50 4 Oh sposa!... Oh figlia!... – 4:09 ............................................................................................ Tebaldo Laura Polverelli, Mezzo-soprano (Isolina, Ermanno, Clemenza, Geroldo) Volto è all’occaso il dì Ermanno ................................................................................................Raúl -
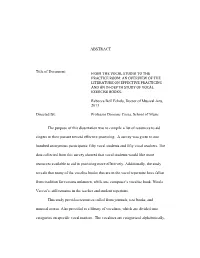
From the Vocal Studio to the Practice Room: an Overview of the Literature on Effective Practicing and an In-Depth Study of Vocal Exercise Books
ABSTRACT Title of Document: FROM THE VOCAL STUDIO TO THE PRACTICE ROOM: AN OVERVIEW OF THE LITERATURE ON EFFECTIVE PRACTICING AND AN IN-DEPTH STUDY OF VOCAL EXERCISE BOOKS. Rebecca Bell Echols, Doctor of Musical Arts, 2013 Directed By: Professor Dominic Cossa, School of Music The purpose of this dissertation was to compile a list of resources to aid singers in their pursuit toward effective practicing. A survey was given to one hundred anonymous participants: fifty vocal students and fifty vocal teachers. The data collected from this survey showed that vocal students would like more resources available to aid in practicing more effectively. Additionally, the study reveals that many of the vocalise books that are in the vocal repertoire have fallen from tradition for reasons unknown, while one composer’s vocalise book, Nicola Vaccai’s, still remains in the teacher and student repertoire. This study provides resources culled from journals, text books, and musical scores. Also provided is a library of vocalises, which are divided into categories on specific vocal matters. The vocalises are categorized alphabetically, by both the category and composer. The final chapter shows the results of the surveys. FROM THE VOCAL STUDIO TO THE PRACTICE ROOM: AN OVERVIEW OF THE LITERATURE ON EFFECTIVE PRACTICING AND AN IN-DEPTH STUDY OF VOCAL EXERCISE BOOKS. By Rebecca Bell Echols Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of DMA 2013 Advisory Committee: Professor Dominic Cossa, Chair Professor Martha L. Randall Professor Timothy McReynolds Professor Delores Ziegler Professor Denny Gulick, Dean’s Representative © Copyright by Rebecca Bell Echols 2013 Dedication I’d like to thank my friends, family, and mentors for all of their support not only throughout this process, but throughout my entire musical career. -

EJ Full Draft**
Reading at the Opera: Music and Literary Culture in Early Nineteenth-Century Italy By Edward Lee Jacobson A dissertation submitted in partial satisfacation of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Mary Ann Smart, Chair Professor James Q. Davies Professor Ian Duncan Professor Nicholas Mathew Summer 2020 Abstract Reading at the Opera: Music and Literary Culture in Early Nineteenth-Century Italy by Edward Lee Jacobson Doctor of Philosophy in Music University of California, Berkeley Professor Mary Ann Smart, Chair This dissertation emerged out of an archival study of Italian opera libretti published between 1800 and 1835. Many of these libretti, in contrast to their eighteenth- century counterparts, contain lengthy historical introductions, extended scenic descriptions, anthropological footnotes, and even bibliographies, all of which suggest that many operas depended on the absorption of a printed text to inflect or supplement the spectacle onstage. This dissertation thus explores how literature— and, specifically, the act of reading—shaped the composition and early reception of works by Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, and their contemporaries. Rather than offering a straightforward comparative study between literary and musical texts, the various chapters track the often elusive ways that literature and music commingle in the consumption of opera by exploring a series of modes through which Italians engaged with their national past. In doing so, the dissertation follows recent, anthropologically inspired studies that have focused on spectatorship, embodiment, and attention. But while these chapters attempt to reconstruct the perceptive filters that educated classes would have brought to the opera, they also reject the historicist fantasy that spectator experience can ever be recovered, arguing instead that great rewards can be found in a sympathetic hearing of music as it appears to us today. -
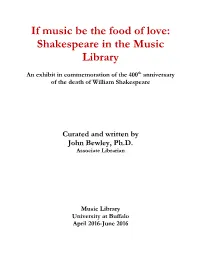
Shakespeare in the Music Library (PDF)
If music be the food of love: Shakespeare in the Music Library An exhibit in commemoration of the 400th anniversary of the death of William Shakespeare Curated and written by John Bewley, Ph.D. Associate Librarian Music Library University at Buffalo April 2016-June 2016 Music provides a kaleidoscopic array of perspectives through which scholars can view the works and influences of William Shakespeare. While many people are familiar with the most famous uses of Shakespeare in music in such works as Tchaikovsky’s Romeo and Juliet Overture-Fantasy, Verdi’s Shakespeare operas (Falstaff, Macbeth, and Otello), Mendelssohn’s incidental music for A Midsummer Night’s Dream, and Prokofiev’s Romeo and Juliet ballet, this exhibit will highlight some of the most significant topics related to the intersections of Shakespeare and music with some lesser-known examples from the holdings of the Music Library. The use of music in Shakespeare’s plays Music plays a significant role in Shakespeare’s plays through three guises: music performed as part of the play, references in the text to song titles, and the use of words with musical connotations. Shakespeare’s use of performed music in his plays was so extensive that only The Comedy of Errors is without music. One of the remarkable aspects of Shakespeare’s use of music is how integral it is to the dramatic structure in the plays. Some of the music serves as a direct part of the action, such as fanfares associated with processions or to mark royal entrances. In other instances Shakespeare used music as an agent for an action, such as when a lullaby is sung to put a character to sleep. -

Leggi Un Estratto
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA SEZIONE DI MUSICOLOGIA - DIP. DI LINGUE E LETTERATURE QUADERNI DI «ESERCIZI. MUSICA E SPETTACOLO» 19 collana diretta da Biancamaria Brumana Caro suono lusinghier… Tutti i libretti di Francesco Morlacchi I. Studi a cura di Biancamaria Brumana Morlacchi Editore Progetto di ricerca realizzato con il sostegno della Ricerche iconografiche: Biancamaria Brumana (Le opere) Emidio De Albentiis (I teatri) Redazione e impaginazione: Attilio Bartoli Langeli Biancamaria Brumana Gioia Filocamo Agnese Tomassetti RISTAMPE: 1. 2. 3. ISBN: 978-88-6074-541-5 copyright © 2013 by Morlacchi Editore, Perugia. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata. [email protected] | www.morlacchilibri.com. Chiuso in redazione il 20 febbraio. Finito di stampare nel mese di febbraio 2013 da Digital Print-Service, Segrate. INDICE Introduzione, di Biancamaria Brumana ............................. 7 Due ritratti di Francesco Morlacchi, di Emidio De Albentiis ............... 21 L E OPERE articoli di Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Gioia Filocamo, Gabriella Meattini Il poeta disperato (G. Ciliberti) .................................. 25 Il ritratto o sia La forza dell’astrazione (G. Filocamo) ................... 29 Corradino (B. Brumana) ....................................... 37 Enone e Paride (B. Brumana) ................................... 48 Oreste (B. Brumana) .......................................... 56 La principessa per ripiego (B. Brumana) -

Le Opere Europee 1800-1899 Michele Girardi (In Fieri, 20 Gennaio 2019)
Le opere europee 1800-1899 Michele Girardi (in fieri, 20 gennaio 2019) 1800 (2) Paris Les deux journées 16.I Nicholas Bouilly Luigi Cherubini Théâtre Feydeau melodramma, 3 Paris Le calife de Bagdad Charles Guillaume 16.IX Adrien Boïeldieu OC opera, 1 Etienne 1801 (1) Wien Die Geschöpfe des Prometheus Ludvig van 28.III Salvatore Viganò Hofburgtheater ballo eroico 2p Beethoven 1802 (2) Venezia Le metamorfosi di Pasquale, o 16.I T. San Moisé sia Tutto è illusione nel mondo Giuseppe Foppa Gaspare Spontini farsa giocosa per musica, 1 Venezia Werter e Carlotta Giulio Domenico primavera Vincenzo Pucitta T. San Moisé opera, 1 Camagna 1803 (1) 4.X Paris Anacréon, ou L’amour fugitif R. Mendouze Luigi Cherubini O opéra-ballet 1804 (3) Joseph Marie Paris La petite maison Armand Michel 12.V Gaspare Spontini OC (Feydeau) opéra-comique, 3 Dieulafoy e N. Gersin Dneprovskaja rušalka (L’ondina St Petersburg 17 Ferdinand Kauer Catterino Cavos Bol’šoj Kamenny T. del Dnepr) opera magico-buffa, 3 Victor-Joseph Étienne de Jouy e Paris Milton 12.XI Joseph Marie Gaspare Spontini OC (Favart) fait historique, 1 Armand Michel Dieulafo 1805 (2) Paris Julie, ou Le pot de fleurs 12.III Antoine Gabriel Jars Gaspare Spontini OC (Favart) comédie en prose, mêlée de chants, 1 Wien Fidelio Joseph von Ludvig van 20. I X Theater an der Wien opera, 3 (I vers.) Sonnleithner Beethoven 1806 (2) Paris Les deux aveugles de Tolède 28.I Benoît Marsollier Joseph Méhul OC opera, 1 Joseph von 29 Wien Fidelio Theater an der Wien opera, 3 (IIa vers.) Sonnleithner 2 1807 (3) Mosca Илья-Богатырь (Il’ja il prode) 12.I Ivan Krïlov Catterino Cavos Bol’šoj grande opera magico-buffa, 4 Paris Joseph 17.II Alexandre Duval Joseph Méhul OC drame en prose mêlé de chants, 3 Paris La Vestale 15.XII V. -

Adetu, E.G.: Biblical and Religious Symbols in Italian Romantic Opera
Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VIII: Performing Arts • Vol. 13(62) No.2 - 2020 https://doi.org/10.31926/but.pa.2020.13.62.2.1 Biblical and religious symbols in Italian romantic opera. Perspectives of musical hermeneutics Edith Georgiana ADETU1 Abstract: The 19th century brings in opera music new ways of thematic and stylistic approach. The escalation of revolutionary and political events influences the artistic life of the Italian nation, awakening in composers such as Rossini, Donizetti, Verdi another kind of spirituality. During this period, the Italian lyrical theater is moving towards new ways of expression, emphasizing the relationship between man and divinity. In these conditions, we can observe a stylistic evolution of the musical discourse, dominated by the influence of the biblical themes that the opera composers develop through dramaturgy. Numerous scenes taken from the Old Testament are found in the music of Italian operas from this period, marking an initiatory path of Italian spirituality and ethos of the nineteenth century. In this research we will present relevant musical examples from works such as Mose in Egitto - Rossini, Il diluvio universale - Donizetti, Nabucco - Verdi, Jerusalem – Verdi, highlighting the symbolic elements taken from the biblical text, rendered through music and stage action. Key-words: Opera, Italian Romanticism, Biblical symbols, Hermeneutics 1. Introduction: the science of hermeneutics and the understanding of opera music According to historical evidence and testimonies, the hermeneutic sciences developed accordingly with the evolution of society. “Plato approaches a hermeneutics of symbols, Aristotle leaves as a legacy a treatise on interpretation, Jewish and Christian theology deepens the understanding of holy books, and later, in the Middle Ages and Renaissance patristic theology and the art of interpreting philological texts stand out as branches of hermeneutic sciences” (Coroiu 2018, 34). -

Barber of Seville CLASSROOM STUDY GUIDE
The Barber of Seville CLASSROOM STUDY GUIDE MICHIGAN OPERA THEATRE Department of Education and Community Programs www.MichiganOpera.org Table of Contents Characters & Synopsis...........................................................................................3 The Creators.............................................................................................................6 A Closer Look..........................................................................................................10 Adaptations.........................................................................................................................12 18th Century Opera...........................................................................................................14 Opera in Popular Culture......................................................................................15 Discussion Questions............................................................................................16 In the Classroom.....................................................................................................17 Michigan Opera Theatre......................................................................................23 Contact & Sources................................................................................................25 MICHIGAN OPERA THEATRE 2 THE BARBER OF SEVILLE Characters & Synopsis Characters Rosina, Dr. Bartolo’s ward, mezzo-soprano Figaro, a barber and jack-of- all-trades, baritone Count Almaviva, a local nobleman, tenor -

Francesco MORLACCHI
Francesco MORLACCHI Variazioni sul Tema Nel cor piu non mi sento For Voice and Piano Per Voce e Pianoforte monographia conSONARTE Francesco MORLACCHI Variazioni sul Tema Nel cor piu non mi sento For Voice and Piano Per Voce e Pianoforte Edition by Alessandro Monga & Davide Verga conSONARTE LONDON AB -0001 CP ORCHESTRA Cembalo certato; Violino I, II, Viola, Continuo (Violoncello, Violone) Durata / Auffuhrungsdauer / Duration: ca 10 min. One ne nonsere henist velit et, ius aut dolum vollendebis dolorpo rrovit ut posaperore di dolum experum eatio. Voleserae volorit et liquo etusamenes explam, sit voluptur aceptae. Ximinte mquunt ut volorit enderfe rumqui cum ex et evendi doluptatum re consequia comni restiss itinita volorit volende rovidellitem aut volorum qui quam qui sollor asped qui se quae eius aboriaspit, odis diost, officim One ne nonsere henist velit et, ius aut dolum vollendebis dolorpo rrovit ut posaperore di dolum experum eatio. Voleserae volorit et liquo etusamenes explam, sit voluptur aceptae. Ximinte mquunt ut volorit enderfe rumqui cum ex et evendi doluptatum re consequia comni restiss itinita volorit volende rovidellitem aut volorum qui quam qui sollor asped qui se quae eius aboriaspit, odis diost, officim © Copyright 2015 by Consonarte / London, United Kingdom Printed 2015 All Rights Reserved / / Alle Rechte vorbehalten / Printed in Italy Any unauthorized reporduction is prohibited by law. ISMN 979-0-006-70267-2 Prefazione È la metà del XVII secolo quando il sipario del melo- nerà, sì, Metastasio, ma «per togliere l’inverisimilitudine dramma si leva sulla storia di Semiramide; e il suo ruolo della favolosa origine di lei» riconducendo tali aneddoti è, subito, quello di una eccezionale protagonista. -

The Clarinet and the Italian Opera Composers of The
THE CLARINET AND THE ITALIAN orchestra. As a young composer he wrote two of which were for flute, two clarinets, the canzonetta “Or che la notte,” for so- horn and orchestra and one for flute, clari- TH OPERA COMPOSERS OF THE 19 prano, clarinet and piano, dedicated to net, horn and orchestra. One of these was CENTURY* Lady Teresina Spadaro; the Piccola com- performed in an academy of the Collegio posizione (Concertino) for clarinet and di Musica di Napoli in December 1817: by Adriano Amore orchestra; the Larghetto in Fa maggiore […]signor Mercadante conducted as for two flutes, basset horn, two horns and Concertmaster and was the composer of (English translation by Antonio Pas- bassoon and two Studi (1821), of which six nice pieces, written with bright imagi- saro) the Primo for solo clarinet and the Sec- nation, correct style and a rare purity of ondo for clarinet and bass, both composed taste. The audience appreciated mostly a ontrary to common thought, al- for his friend, the clarinetist Francesco great Concerto for four wind instruments most every Italian opera composer Benigni, who played in the ’30s in differ- which gave to the young Mercadante the of the 19th century wrote instru- ent orchestras in Bergamo. In dedicating honor of the press. Cmental music and particularly music for these studies to him, Donizetti writes his The compositions written by Giovanni the clarinet. Some of them even learned its surname incorrectly (per l’amico Beg- Pacini (1796–1867) belong to his artistic technique—like Vincenzo Bellini, Save- nigni), while in the second it is correct (a maturity. -

Malibran Harps
Malibran recalled (Harps and tears) Alexander Weatherson No one knows when this multicomposer cantata in memory of Maria Malibran was actually conceived, nor who was responsible for the idea in the first place. Vaccai's letters tell us nothing of significance, nor do those of Donizetti and Mercadante. How and when its short list of composers was decided-upon too is a mystery, only the state of their autograph material - showing haste or otherwise - can supply a clue. This five-composer cantata came and went very quickly - it was performed just once and then went the way of all such lachrymose ephemera. Ephemera? Above is the frontispiece of the vocal score that followed in its wake, that is, after its single appearance on the stage at the Teatro alla Scala in Milan on 17 March 1837, five months or so after the disappearance of the great diva at the height of her fame. No one can accuse the theatre of failing her (as she failed the theatre on so many occasions) but her memorial cantata failed to survive. Now it is to reappear. Its protagonists were the very best that could be got together at short notice: Sofia Dell’Oca Schoberlechner, Francesco Pedrazzi, Pietro Milesi, Benedetta Colleoni-Corti, Marietta Brambilla, Teresa Brambilla, Ignazio Marini, Orazio Cartagenova, Carlo Marcolini, Carolina Lusignani and Felicità Baillou- Hilaret - a starry roster including all those in the current scaligero stagione with an added artist or two. And the cantata ended the season, the great theatre did not reopen again until the beginning of the following July.