GIUSTIZIA E LIBERTÀ» Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapter One: Introduction
CHANGING PERCEPTIONS OF IL DUCE TRACING POLITICAL TRENDS IN THE ITALIAN-AMERICAN MEDIA DURING THE EARLY YEARS OF FASCISM by Ryan J. Antonucci Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the History Program YOUNGSTOWN STATE UNIVERSITY August, 2013 Changing Perceptions of il Duce Tracing Political Trends in the Italian-American Media during the Early Years of Fascism Ryan J. Antonucci I hereby release this thesis to the public. I understand that this thesis will be made available from the OhioLINK ETD Center and the Maag Library Circulation Desk for public access. I also authorize the University or other individuals to make copies of this thesis as needed for scholarly research. Signature: Ryan J. Antonucci, Student Date Approvals: Dr. David Simonelli, Thesis Advisor Date Dr. Brian Bonhomme, Committee Member Date Dr. Martha Pallante, Committee Member Date Dr. Carla Simonini, Committee Member Date Dr. Salvatore A. Sanders, Associate Dean of Graduate Studies Date Ryan J. Antonucci © 2013 iii ABSTRACT Scholars of Italian-American history have traditionally asserted that the ethnic community’s media during the 1920s and 1930s was pro-Fascist leaning. This thesis challenges that narrative by proving that moderate, and often ambivalent, opinions existed at one time, and the shift to a philo-Fascist position was an active process. Using a survey of six Italian-language sources from diverse cities during the inauguration of Benito Mussolini’s regime, research shows that interpretations varied significantly. One of the newspapers, Il Cittadino Italo-Americano (Youngstown, Ohio) is then used as a case study to better understand why events in Italy were interpreted in certain ways. -

Quaderni-Savonesi-34.Pdf
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea n. 34 Savona, ottobre 2013 Aut. Trib. di Savona n. 463 del 27.8.1996. Poste Italiane S.p.A. sped. abb. post. - 70% - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46). Dir. comm.: Business Savona. l 30 ottobre del 1943, a poche settimane dalla decisione del Governo Badoglio di entrare in guerra contro la Germania, Savona subì un intenso bombarda- Imento da parte di oltre 150 aerei alleati che quasi distrusse un intero quartiere nella zona portuale, e mietè 113 vittime tra bambini, donne, anziani e provocò un ISTITUTO STORICO migliaio di feriti. La pubblicazione di questo numero dei “Quaderni savonesi” è resa possibile anche grazie al DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ contributo della Fondazione “A. M. De Mari” della Cassa di Risparmio di Savona e di Coop Liguria. CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA Abbiamo deciso di ricordare questa data in un incontro con i giovani studenti ed i Quaderni savonesi. Studi e ricerche sulla Resistenza e l’Età contemporanea. DI SAVONA loro insegnanti degli Istituti scolastici superiori con una relazione del prof. Anno 16, Nuova Serie n. 34, ottobre 2013. Leonardo Paggi, ordinario di storia contemporanea all'Università di Siena e con Autorizzazione del Tribunale di Savona n. 463 del 27.8.1996. Poste Italiane S.p.A. sped. abb. postale - 70% alcune comunicazioni di carattere locale intese ad illustrare il tragico coinvolgi- -D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004, n. 46). -

Refractory Migrants. Fascist Surveillance on Italians in Australia 1922-1943
Refractory Migrants. Fascist Surveillance on Italians in Australia 1922-1943 by Gianfranco Cresciani Gianfranco Cresciani emigrated University of New South Wales in from Trieste to Sydney in 1962. He 2005, in recognition of worked for EPT, the Ethnic Affairs “distinguished eminence in the field Commission and the Ministry for of history”. In 2004 the Italian the Arts of the NSW Government Government awarded him the on cultural and migration issues. In honour of Cavaliere Ufficiale 1989 and 1994 he was member of dell‟Ordine al Merito for facilitating the Australian Delegation re- cultural exchanges between Italy negotiating with the Italian and Australia. He has produced Government the Italo-Australian books, articles, exhibitions and Cultural Agreement. Master of Arts radio and television programs in (First Class Honours) from Sydney Australia and Italy on the history of University in 1978. Doctor of Italian migration to Australia. Letters, honoris causa, from the There are exiles that gnaw and others that are like consuming fire. There is a heartache for the murdered country… - Pablo Neruda We can never forget what happened to our country and we must always remind those responsible that we know who they are. - Elizabeth Rivera One of the more salient and frightening aspects of European dictatorships during the Twentieth Century, in their effort to achieve totalitarian control of 8 their societies, was the grassroots surveillance carried out by their state security organisations, of the plots and machinations of their opponents. Nobody described better this process of capillary penetration in the minds and conditioning of the lives of people living under Communist or Fascist regimes than George Orwell in his book Nineteen Eighty-Four (1), published in 1949 and warning us on the danger of Newspeak, Doublethink, Big Brother and the Thought Police. -

Il Fuoruscitismo Italiano Dal 1922 Al 1943 (*)
IL FUORUSCITISMO ITALIANO DAL 1922 AL 1943 (*) Possiamo organicamente dividere l’emigrazione politica, uno de gli aspetti più rilevanti della storia italiana durante i primi anni del regime fascista, in tre grandi periodi (1). Durante il primo, che va dal 1922 al 1924, tale esodo può apparire motivato da considerazioni economiche, proprio come era avvenuto per molti decenni; tuttavia, anche in questo periodo iniziale, in cui il fascismo non aveva ancora assunto il suo carattere dittatoriale, vi erano motivi politici che face vano capolino nella emigrazione. A migliaia di italiani che, senza un particolare interesse politico, avevano cercato lavoro sui mercati di Francia, Svizzera e Belgio, presto si aggiunsero numerosi altri la voratori, di idee socialiste od anarchiche, che avevano preso parte (1) Le seguenti statistiche possono dare un’idea delle variazioni nell’emigra zione. E’ impossibile, naturalmente, stabilire quanti emigrati fossero spinti prin cipalmente da motivi politici e quanti da considerazioni economiche. Le cifre sono prese dall’« Annuario Statistico italiano », Istituto centrale di Statistica, 1944-48, Serie V (Roma, 1949), I, 49. Anno Emigrazione verso Emigrazione verso Emigraz. ve la Francia l’Europa (Francia compr.) Paesi non Euro 1921 44.782 84.328 116.963 1922 99.464 155.554 125.716 1923 167.982 205.273 184.684 1924 201.715 239.088 125.282 1925 145.529 177.558 101.873 1926 111.252 139.900 122.496 1927 52.784 86.247 132.687 1928 49.351 79.173 70.794 1929 51.001 88.054 61.777 1930 167.209 220.985 59.112 1931 74.115 125.079 40.781 1932 33.516 58.545 24.803 1933 35.745 60.736 22.328 1934 20.725 42.296 26.165 1935 11.666 30.579 26.829 1936 9.614 21.682 19.828 1937 14.717 29.670 30.275 1938 10.551 71.848 27.99-* 1939 2.015 56.625 16.198 L’articolo è qui pubblicato per cortese concessione del « Journal of Central European Affairs » (University of Colorado, Boulder, Colorado) che l’ha pubbli cato il 1 aprile 1952 (voi. -

Machiavelli the Revolutionary: a Modern Reinterpretation
MACHIAVELLI THE REVOLUTIONARY: A MODERN REINTERPRETATION Susan A. Ashley Four hundred years and the space between the far ends of the political spectrum separate the advocate of princely power from the most prominent Italian Communist, Antonio Gramsci. Other than their reputations as in uential Italian political thinkers, little connects Machiavelli, the Renaissance Humanist, to Gramsci, a Marxist-Leninist proponent of proletarian revolution. And yet, Machiavelli gures pro- minently in Gramsci’s work. Gramsci provided a clear, confident reading of The Prince and its relationship to Machiavelli’s other writings, and he drew on Machiavelli’s ideas both to shape and to explain his own distinctive views of power and of revolution. This founder of the Italian Communist Party and Italian delegate to the Comintern used Machiavelli to reinvent Marx. In doing so, Gramsci also turned Machiavelli into a Marxist, his particular type of Marxist. Despite the evident differences between Italy in the Renaissance and in the twentieth century, Machiavelli and Gramsci shared some common ground. They lived in chaotic times, and both enjoyed political in u- ence, then experienced exclusion when power changed hands. In 1494, the citizens of Florence drove Piero de Medici out for collaborating too closely with the French who had invaded Italy. Machiavelli stepped in and played a prominent role in the new government. He served on a committee which advised the newly-established Grand Council on war and foreign affairs, and he participated in a commission charged with studying the creation of a civilian militia. Four years later, the Florentines established another government under the leadership of Pier Soderini. -

LA FUGA DI FILIPPO TURATI 1 Gennaio 2016 | Filed Under: Articoli and Tagged With: Antifascismo, Fascismo, Resistenza, Socialismo, Turati Di Roberto Poggi
LA FUGA DI FILIPPO TURATI 1 gennaio 2016 | Filed under: Articoli and tagged with: Antifascismo, Fascismo, Resistenza, Socialismo, Turati di Roberto Poggi - L’iniziativa non nacque dall’anziano leader socialista, ridotto all’ombra di sé stesso dopo l’instaurazione della dittatura fascista e la morte della compagna Anna Kuliscioff, ma da Carlo Rosselli. Il progetto di fuga verso la Svizzera si rivelò però troppo rischioso, così Turati fu fatto espatriare rocambolescamente in Corsica. Il dolore di Turati per la morte di Anna Kuliscioff fu straziante. La depressione e l’insonnia, di cui soffriva sin dalla giovinezza, tornarono a tormentarlo. Gli amici di una vita, Treves, Gonzales, Omodeo, Mondolfo, Tanzi, gli si strinsero attorno circondandolo con il loro affetto e le loro cure, ma quando alla sera rincasava nell’appartamento affacciato su Piazza Duomo, che per decenni aveva condiviso con Anna, i pensieri più cupi lo assalivano e lo tenevano sveglio sino all’alba. Nel dicembre del 1925, presentendo la fine imminente, Anna aveva confidato all’amica Bianca Pittoni: “Non avrei mai dovuto fare a Filippo il torto di morire prima di lui”. Era stata una sottoscrizione a favore delle vittime delle persecuzioni zariste, promossa nell’autunno del 1884 dagli ambienti dell’estrema sinistra milanese, a farli conoscere. Dopo alcuni mesi di scambi epistolari, nella primavera dell’anno successivo, avevano finalmente potuto incontrarsi a Napoli, dove Turati era stato inviato dal leader radicale Agostino Bertani per condurre una indagine sulle condizioni di vita dei contadini campani. Il ricordo della magia di quel momento li aveva accompagnati per tutta vita. Rievocando molti anni più tardi le impressioni di quel primo incontro Turati scrisse: “Io rimasi senza parole. -

Via Fratelli Rosselli
VIA FRATELLI ROSSELLI Via F.lli Rosselli unisce Via della Libertà a Via Amendola ed è una via piuttosto breve che, però, essendo al centro del paese vede un certo movimento in quanto si trova proprio dietro agli uffici della delegazione comunale e di altri uffici e studi tecnici. 2005 Via F.lli Rosselli E’ dedicata ai fratelli Carlo e Nello Rosselli, due importanti figure di politici, giornalisti e attivisti dell’antifascismo italiano. Due figure eroiche di cui tutti dovremmo conoscere le idee e la lotta che hanno condotto contro ogni tipo di dittatura. Carlo e Nello Rosselli Vissero a lungo in esilio a Parigi e furono uccisi a Bagnoles-de-l’Orne il 9 giugno 1937 da formazioni locali di estrema destra, molto probabilmente su ordine proveniente dai vertici del fascismo. Firenze: lapide in ricordo dei F.lli Rosselli Carlo, attivista antifascista, prima in Italia poi all'estero, fu il teorico del "socialismo liberale", un socialismo non marxista, riformista, ispirato al laburismo inglese. Carlo Rosselli Amelia Pincherle, madre di Carlo Sia la famiglia del padre, Giuseppe Emanuele Rosselli che quella della madre, Amelia Pincherle, erano state politicamente attive, nutrendo ideali repubblicani e partecipando alle vicende del Risorgimento italiano: Giuseppe Mazzini era morto nella casa pisana dei Rosselli e un Pincherle fu ministro del breve governo instaurato a Venezia da Daniele Manin. I Rosselli, di origini ebraiche-toscane, avevano abitato a Vienna, quindi si erano trasferiti a Roma, dove il 16 novembre 1899 nacque Carlo e l'anno dopo, il 29 novembre 1900, il terzogenito Nello. Nel 1903 i due coniugi si separarono. -

Consensus for Mussolini? Popular Opinion in the Province of Venice (1922-1943)
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM SCHOOL OF HISTORY AND CULTURES Department of History PhD in Modern History Consensus for Mussolini? Popular opinion in the Province of Venice (1922-1943) Supervisor: Prof. Sabine Lee Student: Marco Tiozzo Fasiolo ACADEMIC YEAR 2016-2017 2 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the PhD degree of the University of Birmingham is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of my words. 3 Abstract The thesis focuses on the response of Venice province population to the rise of Fascism and to the regime’s attempts to fascistise Italian society. -

Democrats and Dictators in Spain and Italy
University of Wisconsin-Madison HISTORY 201: Historian’s Craft Democrats and Dictators in Spain and Italy Van Vleck B223 Monday and Wednesdays, 2:30-3:45 pm Professor Giuliana Chamedes Spring 2020 Office Hours: Wednesdays, 4:15-6pm, and by appointment* Office: Humanities Building, Room 4124 Email: [email protected] Course Description This course introduces students to the exciting work historians do and it encourages them to don the historian’s hat and superhero cape. It does so through an in-depth investigation of a complex and timely topic: the rise and fall of democracy and dictatorship in Italy and Spain. Why did dictatorships in these southern European countries live long lives, and die sudden deaths? How did Italian and Spanish dictators and democrats exercise influence and build popular consent? What does everyday life look like for citizens in dictatorships and democracies? How, troublingly enough, can democracies sometimes morph into dictatorships? Finally, can we, as informed citizens, prevent democracy’s undoing? This course will investigate these and other questions through a range of sources, including literature and film. * Office hours by appointment only on 1/29; 2/5; 2/12; 3/4; 3/25; 4/1; and 5/6. 1 Course Objectives This course fulfills your General Education Communication B Requirement. Throughout this course, we will practice skills like critical thinking, evaluating evidence, constructing arguments, and engaging with opposing viewpoints in writing and in speech. By the end of the course, you will become proficient in asking scholarly questions, analyzing primary and secondary sources, and situating sources within their proper context. -
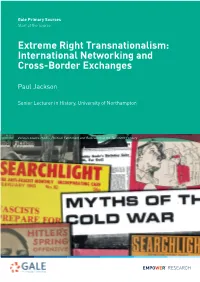
Extreme Right Transnationalism: International Networking and Cross-Border Exchanges
Gale Primary Sources Start at the source. Extreme Right Transnationalism: International Networking and Cross-Border Exchanges Paul Jackson Senior Lecturer in History, University of Northampton Various source media, Political Extremism and Radicalism in the Twentieth Century EMPOWER™ RESEARCH While many historians have devoted themselves to forms of anti-fascism: divisions within the left. The examining the dynamics of fascist movements and Italian Communist Party was also formed at this time, regimes, the topic of ‘anti-fascism’ has traditionally and while initially supportive of the Arditi del Popolo, been neglected. However, historians and other later it instructed its members to withdraw their academics are now starting to take greater interest in engagement. The Arditi del Popolo was shut down by the study of those who opposed nationalist and racist the Italian state by 1924, while the Italian Communist extremists, and are developing new approaches to Party was itself banned from 1926. Splits within the understanding these complex cultures. Some, such as left have often been a characteristic of anti-fascist Nigel Copsey, have been concerned with developing politics, and in Italy during the 1920s such anti- sober, empirical accounts, exploring left-wing, centre fascists were driven by competing ideas on how to and even right-wing forms of anti-fascism, presenting develop an anti-capitalist revolution. In this case, the it as a heterogeneous politicised identity. Others, such issue helped to foster discord between a more as Mark Bray, have been more concerned with eclectic and anarchist variant of anti-fascism and a developing unapologetically partisan readings of the more centralised Communist version. -

“25 Aprile: Savona Resiste”
“25 aprile: Savona rEsiste” PROGRAMMA 25 APRILE SAVONA – Fortezza del Priamar L’ANPI provinciale di Savona, nella convinzione che la Festa della Liberazione debba essere un momento di commemorazione e di riflessione, ma anche, appunto, di festa, organizza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di altre associazioni, un’iniziativa sul Priamar per il pomeriggio e la sera del 25 aprile. A partire dalle ore 15.00 , si apriranno gazebo e banchetti delle associazioni e spettacoli nella Piazza della Cittadella, dibattiti nel Baluardo di Santa Caterina, esposizioni nel Palazzo del Commissario, proiezioni nella Cappella sconsacrata. Il concerto serale , preceduto da un paio di gruppi di spalla, si terrà in Piazza del Maschio dalle ore 19.00 circa. Piazza della Cittadella : - 15.00 - apertura di gazebo e banchetti delle associazioni - 15.30 - sfilata e danze folcloristiche nordafricane [Amici del Mediterraneo] - 16.00 - ricordo dei partigiani fucilati nella fortezza del Priamar [ANPI] - 17.00 - coro dialettale “I Pertinace” - 18.00 - rappresentazione dello spettacolo Il processo di Savona di Vico Faggi [Cattivi Maestri] Baluardo di Santa Caterina : - 15.00 - La resistenza non va mai in crisi: dibattito a cura dei Giovani Democratici - 16.00 - incontro sulle “primavere arabe” con l’intervento del giornalista Touhami Garnaoui e del console tunisino a Genova Zied Bouzouita [TILT, Amici del Mediterraneo] - 17.00 - Dibattito sulla crisi del lavoro tra rappresentanti delle aziende in crisi e Consulta Provinciale Studenti [CGIL, CISL, UIL, -

This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from Explore Bristol Research
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from Explore Bristol Research, http://research-information.bristol.ac.uk Author: King, Amy Title: Italy’s secular martyrs the construction, role and maintenance of secular martyrdom in Italy from the twentieth century to the present day General rights Access to the thesis is subject to the Creative Commons Attribution - NonCommercial-No Derivatives 4.0 International Public License. A copy of this may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode This license sets out your rights and the restrictions that apply to your access to the thesis so it is important you read this before proceeding. Take down policy Some pages of this thesis may have been removed for copyright restrictions prior to having it been deposited in Explore Bristol Research. However, if you have discovered material within the thesis that you consider to be unlawful e.g. breaches of copyright (either yours or that of a third party) or any other law, including but not limited to those relating to patent, trademark, confidentiality, data protection, obscenity, defamation, libel, then please contact [email protected] and include the following information in your message: •Your contact details •Bibliographic details for the item, including a URL •An outline nature of the complaint Your claim will be investigated and, where appropriate, the item in question will be removed from public view as soon as possible. Italy’s secular martyrs: the construction, role and maintenance of secular martyrdom in Italy from the twentieth century to the present day Amy King A thesis submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements for award of the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts.