Valmareno, Via Brumal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Laboratorio Architettura Sostenibile CURRICULUM PROFESSIONALE
PROGETTO6ASSOCIATI – laboratorio architettura sostenibile CURRICULUM PROFESSIONALE PROGETTO6ASSOCIATI è uno studio di architettura formatosi a Cornuda nel 2006 indirizzato alla ricerca e alla progettazione dell’architettura sostenibile con particolare riguardo alla qualità bioecologica dell’abitare e degli spazi di relazione sociale. Lo studio si avvale di consulenti e collaboratori esterni che, pur non facendo parte stabilmente dell’organico, ne completano le competenze e la capacità di affrontare progetti complessi. Nel corso degli anni PROGETTO6ASSOCIATI si è occupato di: LAVORI PUBBLICI Comune di Cornuda - Riordino Urbanistico ed Edilizio delle Aree a servizi Centro - Nord (Aree scolastiche e Municipio). Progetto6associati con Allen architettura; 2006 Comune di Cornuda – Progetto nuovo Centro Civico e Biblioteca; Progetto6associati con Allen architettura 2006-2008 Comune di Montebelluna - Piano Particolareggiato Centro storico di Busta; 2010-2011; Comuni di Cornuda, Montebelluna, Crocetta del Montello - Realizzazioni Piani di Sicurezza per pubbliche manifestazioni; 2018 – 2020. CONCORSI Treviso – Concorso d’idee riqualificazione complesso “Tower House”; Progetto6associati, Fedro Archh, associati, Arch. Claudio Mistura. 2011. The PLAN – Concorso aperto di architettura “Crea un’installazione per Volvo V60 Plug-in-Hybrid”. 2013 COLLAUDI Redazione di Certificati di collaudo per immobili privati nei comuni di: Cornuda, Maser, Montebelluna, Paderno del Grappa, Paese, Ponzano Veneto, Riese Pio X°, Spresiano, Vittorio Veneto, Borgoricco (PD), Sesto al Reghena (PN). STRUTTURE RICETTIVE Rimini Progetto preliminare e definitivo per l’Hotel Fiera (albergo di 130 camere, con ristorante, piscina a spa). 2006 Repubblica Democratica del Congo – Mungbere – La cappella di Anoalite, Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, 2013 - 2015. (Pubblicata su LegnoArchitettura n. 30/2018. Susegana – Redazione Masterplan per insediamento turistico ricettivo Associazione “Le Querce Bianche”. -

COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 Marzo 2021
COMUNICATO STAMPA Treviso, 31 marzo 2021 VACCINAZIONE CON ACCESSO LIBERO DELLA CLASSE 1935 A CASTELFRANCO SARA’ SPERIMENTATO IL DRIVE-IN Sospesa la vaccinazione degli accompagnatori (n. 62/2021) Sarà sperimentata anche la vaccinazione in modalità drive-in nel corso del Vax Day di sabato 3 aprile, riservato alla classe del 1935. Il drive-in sarà attivo nel parcheggio della discoteca Melodi, a Castelfranco, e sarà riservato, esclusivamente, agli 86enni residenti nei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, per un totale di 419 persone che saranno avvisate dai rispettivi Comuni. I restanti cittadini residenti nel Distretto di Asolo faranno riferimento per la vaccinazione, invece, al Centro Polifunzionale di Vidor. Riepilogando le sedi vaccinali in cui gli 86enni potranno recarsi sabato 03 aprile sono le seguenti: - CVP di Oderzo “Foro Boario”: per i residenti nei Comuni dell’area Opitergino-Mottense - CVP di Villorba “Bocciodromo”: per i residenti nei Comuni dell’area di Treviso - CVP di Godega di Sant’Urbano “Campo Fiera”: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7 - CVP drive-in nel park discoteca Melodi: per i residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago - CVP di Vidor Centro Polifunzionale: per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 8 non rientranti tra quelli ammessi al drive-in. Di seguito l’elenco dei Comuni di riferimento dei cinque Centri vaccinali suindicati: Comuni dell’area Opitergino Mottense: Cessalto – -

Mogliano E Preganziol Oderzo Opitergino
ZONA EX ASL 7 ZONA EX ASL 8 ZONA EX ASL 9 MOGLIANO E OPITERGINO- TREVISO CITTA' TREVISO SUD TREVISO NORD ODERZO ZONA CONEGLIANESE-VITTORIESE CONEGLIANO VITTORIO VENETO PIEVE DI SOLIGO CASTELFRANCO PIANURA OVEST MONTEBELLUNA VALDOBBIADENE E PEDEMONTANA PREGANZIOL MOTTENSE 7 farmacie di Mogliano x 2 ATTENZIONE TURNO volte(14); farmacia di SPERIMENTALE FINO Campocroce x 1 volta CONTINUATO 24 H. FINO ALLE ORE 21,00 - 5 farmacie X 7 gg, si ALLE ORE 22,00 (se 25+1 farmacie+ 10 Abbinate x3 gg.= turno ogni 10 farmacie x 3 gg = 7 farmacie x 7 gg = 9 farmacie x 3 gg =cicli 22+4 +4 appoggio farmacie x 3 gg = cicli di 78 16 farmacie x 3 gg + 3 APPOGGIO = cicli di 48 GIORNO DATA 26+1 farmacie x 3 gg.= turni di 78 gg 26+1 farmacie x 3 gg.= turni di 78 gg (1); 3 farmacie di 3 gg=ciclo da 39 gg 9+4 farmacie+3 appoggio x 3 gg = cicli di 39 gg 25 Farmacie 25 Farmacie ripete ogni 35 gg non rosa) - 17 78 gg cicli di 30 gg cicli di 49 gg di 27 gg gg gg Preganziol x 1 volta farmacie + 9 x 3 gg= (3)→( totale 18); turno ogni 78 gg ognuno per 3 gg = ogni 54gg GORGO AL BADOERE DI VITTORIO VENETO - CASTELFRANCO - TREVISO - S. Bona SNC - TREVISO - Millioni SAS - S. BIAGIO - Bellavitis PREGANZIOL - ODERZO - Oderzo MONTICANO - Dr. SANTA LUCIA DI PIAVE - FREGONA- Dr.Pessa - PARE' DI CONEGLIANO - PIEVE DI SOLIGO - ONE' DI FONTE - Dr.ssa TREVIGNANO - PADERNO DEL GRAPPA MORGANO - Dr. -

The Walled Cities
(C) THE WALLED CITIES Even now, on visiting the historical centre of This gives it the peasant and very sweet Treviso , one can well understand how, since impression of a city whose history flows with the most ancient times, its inhabitants were the River that crosses it. In Roman times, closely bound to the surrounding landscape the layout of Tarvisium, which was made a and fully exploited the potential offered by the municipium and assigned to the Claudia tribe, nature of the place. The earliest settlement was followed the two main roads that crossed to established in the 14th to 13th century BC, on a form a quadruvium, as testified to by a wall fluvial island in the River Sile, before expanding mounted stone plaque on the south side of the over the centuries to the surrounding areas in Baptistery, to the left of the Cathedral. On the part made inhabitable by reclamation work. north façade, this construction, which was built Until recently, the River was an important in the 11th and 12th century also maintains trading and communication route that a Roman funeral stele, in line with that 20 connected directly with the Adriatic Sea. somewhat frequent taste of using historical St Tomaso gate (Treviso) Fadalto Nove Botteon Savassa BassaSonego Osigo Passo San Boldo Luca PROVINCE OF Longhere Breda Mezzavilla Pra De Radego Revine LagoSerravalle Fregona Montaner BELLUNO S. Maria Olarigo Fratte Lago Borgo VillaCosta Anzano Rugolo Nogarolo Caiada Sarmede Sotto Croda Colmaggiore VITTORIO VENETO Palu' Tovena Ceneda Alta Cappella Maggiore Soller -

TASTY ROUTES PROSECCO and with Little Farmhouses
13 Fregona VITTORIO VENETO Revine Lago Sarmede PROVINCE WHERE IS THE 31 6 OF PORDENONE Cappella Maggiore MeschioMeschio Cison PROVINCE di Valmarino A28 Cordignano Follina Situata nella regione Veneto, PROVINCE Miane Tarzo Colle Umberto OF TREVISO? a nord-est dell’Italia, a pochi OF BELLUNO 9 6 Orsago chilometri da Venezia, Segusino Godega la provincia di Treviso può 25 Refrontolo San Pietro San Fior di Sant’Urbano di Feletto VALDOBBIADENE 16 Treviso essere raggiunta tramite: 1 Farra di Soligo CONEGLIANO Pieve di Soligo 14 Gaiarine Milan Autostrade: A27 VE-BL Codognè Venice Pederobba 24 Sernaglia San Vendemiano Vidor della Battaglia (uscite di Vittorio Veneto Possagno PiavePiave Moriago Portobuffolè Cavaso 10 30 Susegana Bologna 12 26 del Tomba della Battaglia Nord e Sud, Conegliano, Mareno di Piave LivenzaLivenza Crespano Paderno del Grappa Nervesa Santa Lucia 15 Monfumo Mansuè Treviso Nord e Sud, del Grappa di Piave Vazzola Fontanelle 6 Cornuda della Battaglia Meduna Castelcucco Crocetta PiavePiave Mogliano Veneto), A4 TO-TS 8 23 7 11 27 di Livenza Located in the Veneto 22 Borso del Montello del Grappa Maser Giavera del Montello Spresiano San Polo di Piave Gorgo al Monticano region, in the North-East of (uscita di Cessalto) Fonte 20 3 ASOLO Caerano San Marco Arcade Cimadolmo Italy, just a few kilometres Aeroporti: A. Canova (TV) Volpago del Montello DOV’ÉODERZO LAMotta San Zenone Ormelle di Livenza from Venice, the Province of M. Polo (VE) degli Ezzelini MONTEBELLUNA Povegliano 18 PROVINCIA Treviso can be easily Linee ferroviarie: Altivole Maserada sul Piave 5 Villorba reached by: Cessalto Venezia-Udine, PiavePiave Riese Pio X Trevignano Motorways: PonteDI di Piave TREVISO?Chiarano A4 Loria Ponzano Veneto Breda di Piave Venezia-Belluno, Salgareda Fagarè A27 VENICE-BELLUNO A28 Vicenza-Treviso. -

Relazione Previsionale E Programmatica -.:: Comune Di San
Comune San Fior Provincia di Treviso RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2016 - 2017 Pag. 1 INDICE GENERALE Sommario SEZIONE 1 – CARATTERISTICHE GENERALI ............................................................................................................................................................................... 3 1.1 Popolazione .................................................................................................................................................................................................................................... 4 1.2 Territorio ......................................................................................................................................................................................................................................... 6 1.3.1 - Personale ................................................................................................................................................................................................................................... 7 1.3.2 - Strutture ..................................................................................................................................................................................................................................... 9 1.3.3 - Organismi Gestionali ............................................................................................................................................................................................................ -
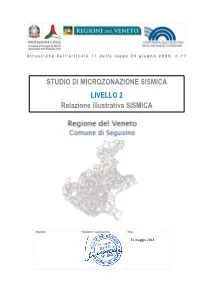
Relazione MS 2 Segusino V6
STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 2 Relazione illustrativa SISMICA 31 maggio 2018 Comune di Segusino TV: microzonazione sismica livello 2 SOMMARIO 1 INTRODUZIONE E GENERALITA’ 3 1.1 Generalità ............................................................................................................................................. 4 1.2 Riferimenti normativi ......................................................................................................................... 5 1.3 Ambiti di studio ................................................................................................................................... 7 2 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE 9 2.1 Generalità ............................................................................................................................................. 9 2.2 Definizione della pericolosità di base ............................................................................................. 11 2.3 Sismicità storica del comune ........................................................................................................... 13 2.4 Sismicità minore e strumentale ....................................................................................................... 17 2.5 La classificazione sismica del territorio comunale ....................................................................... 18 2.6 I sistemi di faglie attive .................................................................................................................... 20 2.6.1 -

Comuni Di Pederobba, Valdobbiadene E Cornuda; 2
IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO Comuni di: Pederobba, Valdobbiadene, Cornuda Periodo di indagine: 11 Gennaio – 28 Febbraio 2011 30 Marzo – 29 Maggio 2011 Realizzato a cura di A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Treviso Ing. L. Tomiato (direttore) Servizio Sistemi Ambientali Dr.ssa M. Rosa (dirigente responsabile) Ufficio Reti Monitoraggio Dr.ssa C. Iuzzolino Dr. F. Steffan P.i. G. Pick Redatto da: Dr.ssa M. Rosa, Dr.ssa C.Iuzzolino, Dipartimento Regionale Laboratori di Arpav Dr. F. Steffan ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Direzione Generale Via Matteotti, 27 35131 Padova Tel. +39 049 82 39341 Fax. +39 049 66 0966 E-mail [email protected] www.arpa.veneto.it Dipartimento di Treviso Servizio Sistemi Ambientali Via Santa Barbara , 5/A 31100 Treviso Tel. +39 0422 558 541/2 Fax +39 0422 558 516 E-mail: [email protected] Luglio 2012 Indice 1. Introduzione, obiettivi e metodologia del monitoraggio 2 1.1 I siti di monitoraggio ed i parametri di qualità dell’aria 2 2. Valutazione e discussione dei risultati 5 2.1 Particolato atmosferico PM10 5 2.1.1 Valutazione comparata del PM10 – confronto tra i siti in funzione dell’attività del cementificio 6 2.2 Benzo(a)pirene (BaP) ed altri idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 10 2.3 Arsenico (As), Cadmio (Cd), Nichel (Ni), Piombo (Pb) ed altri metalli 13 3. Conclusioni 16 Appendice I. Il quadro di riferimento normativo 18 Riesame della zonizzazione in attuazione del DLgs 155/2010 21 1 di 24 1. -

La Strada Dell'archeolgia
Assessorato alla Cultura e al Turismo PianoPiano Tererritorialeritoriale Turisticouristico LaLa StradaStrada dell’Archeolgiadell’Archeolgia (antica(antica e medioevale)medioevale) “ MarcaMarca Storica”Storica” cod Siti 01 Castello di San Zenone Monte Castellaro S. Zenone degli Ezzelini Castello 02 Castello di Fonte Fonte Alto Fonte Castello 03 Castelàr di Rovèr Cunial Possagno Castello 04 Castello del Col Muson Col Muson Castelcucco Castello 05 Città di Asolo Braida Asolo Castello 06 Torre di Santa Giustina Casonetto-S. Giustina Asolo Castello 07 Castello di Castelciès Castelciés – San Martino Cavaso del Tomba Castello 08 Castel della Bastìa S. Giorgio Cavaso del Tomba Castello 09 Mura della Bastia Onigo Pederobba Castello 10 Castello di Maser Roccolo Maser Castello 11 Castello di Monfumo Chiesa Monfumo Castello 12 Rocca di Cornuda Madonna della Rocca Cornuda Castello 13 Castello di Crespignaga Santi Ermagora e Fortunato Maser Castello 14 Castelli di Monfumo Castelli di Monfumo Monfumo Castello 15 Fortificazioni medievali di Oderzo Oderzo Città murata 16 Castello di Collalto Collalto Susegana Castello 17 Castello di Colfosco Colfosco Susegana Castello 18 Castello di San Salvatore S.Salvatore Susegana Castello 19 Citta murata di Serravalle Serravalle Vittorio Veneto Città murata 20 Le fortificazioni di Ceneda Ceneda Vittorio Veneto Castello 21 La torre di S. Floriano San Floriano Vittorio Veneto Castello 22 Castello Brandolini astello Brandolini Cison di Valmarino Castello 23 Torri di Credazzo Credazzo Farra di Soligo Castello 24 Motte di Castelminio Castelminio Resana Castello 25 Torre di Rai Rai San Polo di Piave Castello 26 Castello di Cordignano Castelat Cordignano Castello 27 Castello di Conegliano Conegliano Veneto Città murata 28 Citta murata di Castelfranco Castelfranco Veneto Città murata 29 Città murata di Portobufolè Portobufolè Città murata 30 Citta murata di Oderzo Oderzo Aree archeologiche 31 Piazza S. -

SUAP Informazioni
SUAP informazioni Rassegna delle principali novità normative di interesse per lo Sportello Unico delle Attività Produttive n.2 Gennaio 2018 NOVITA' Il Comune di Treviso ha approvato le modifiche al Protocollo d’intesa dell’Organismo di Gestione della Destinazione (OGD) delle Città d’arte e Ville venete del territorio trevigiano e relativo Regolamento con deliberazione di Consiglio n. 71 del 20 dicembre 2017, consultabile sul sito del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.treviso.it/delibere/dettaglio? openagent&nodo=1.1.1&uid=394E5DF2DA16FA78C125820F0038C7E0 Di seguito potete consultare il nuovo Protocollo d'intesa e il relativo Regolamento. Prot. n. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'OGD CITTA' D'ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO TREVIGIANO PREMESSO che: • in data 3 luglio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” che rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo nel Veneto; • punto saliente della nuova normativa è il concetto di “destinazione”, ossia delle località o degli ambiti territoriali nei quali ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o con una gamma di prodotti; • l'art. 9 della citata legge prevede che la Giunta Regionale riconosca, per ciascuna destinazione turistica, un'unica organizzazione della gestione e definisca criteri e parametri per la costituzione di quest'ultima; • l'OGD – Organizzazione della gestione della destinazione, delineata dal legislatore regionale, analogamente -

S E G U S I N O P. a . T . C O M U N E
REGIONE VENETO P.A.T . PROVINCIA DITREVISO COMUNEDI SEGUSINO NormeTecniche-AllegatoB 2013 Centristorici COMUNEDI Il Sindaco SEGUSINO Guido Lio ILPROGETTISTA dott.urb.MauroDeConz CONSULENZE SPECIALISTICHE agosto 2013 geol. Cristiano Mastella U r b a n i s t i c a e e A l COLLABORAZIONE CO-PIANIFICAZIONE - PROVINCIA DI TREVISO m a i b r dott. urb. Vanessa Da Col Settore Urbanistica e Nuova viabilità i o Plan e t n i t r a r l CO-PIANIFICAZIONE - U.T.C. e COORDINAMENTO n i ng e T Pianificazione ® p.i.MariagraziaViel geom. Sonia Stramare P.A.T. del comune di Segusino ––– Norme Tecniche ---Allegato-Allegato B "Centri Storici" Segusino Primo comune della provincia di Treviso lungo il fiume Piave, Segusino si presenta come una appendice del trevigiano verso il bellunese, ubicato sul primo allargarsi della valle del Piave dopo la stretta di Quero, a 219m s.l.m. Segusino può essere raggiunto solo da nord o da sud, in quanto protetto ad est dal monte Doc e ad Ovest dal fiume Piave. Il paese e le sue frazioni minori sono nascoste dalla conformazione della valle, che non permette di ammirarli da lontano. Il territorio di Segusino è stato storicamente caratterizzato da un certo isolamento; nessuna strada regia attraversava infatti i confini comunali e per raggiungere i centri di Feltre e Montebelluna era necessario tragittare il Piave alla stretta di Fener. Tale condizione mutò solo agli inizi del ‘900 con la costruzione del ponte sul Piave. Il toponimo comunale non ha derivazioni certe; esso viene ricondotto a due teorie principali: la prima fa riferimento a Segusium, antico toponimo dell’attuale Val di Susa in provincia di Treviso; la seconda ipotesi lo avvicina all’aggettivo securum, ovvero sicuro, in riferimento alla posizione geografica di controllo e difesa che manteneva sul territorio circostante. -
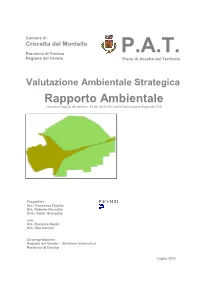
Crocetta Del Montello
Comune di Crocetta del Montello Provincia di Treviso P.A.T. Regione del Veneto Piano di Assetto del Territorio Valutazione Ambientale Strategica Rapporto Ambientale Integrato a seguito del parere n. 53 del 04.06.2013 della Commissione Regionale VAS Progettisti: Urb. Francesco Finotto Urb. Roberto Rossetto Arch. Valter Granzotto con: Urb. Damiano Solati Urb. Rita Corrieri Co-progettazione: Regione del Veneto – Direzione Urbanistica Provincia di Treviso Luglio 2013 INDICE 1. INTRODUZIONE ....................................................................................... 5 1.1. LO SVILUPPO SOSTENIBILE .................................................................... 5 1.2. LA DIRETTIVA 2001/42/CE E LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ...................................................................................................... 8 1.3. METODOLOGIA E PERCORSO DELLA VALUTAZIONE................................. 9 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ................................................. 12 2.1. CONTESTUALIZZAZIONE GEOGRAFICA ................................................. 12 2.2. OBIETTIVI PRINCIPALI E AZIONI DEL PAT ............................................ 12 2.3. METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL PAT .......................................... 14 2.4. SOGGETTI INTERESSATI ALLE CONSULTAZIONI ..................................... 14 3. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI...... 20 3.1. PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA ...................................................... 20 3.1.1. P.T.R.C. .......................................................................................