Storia Del Diritto Medievale E Moderno
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Intl Law Presentation 3P
Ringvorlesung/ Lecture Series Development Policy XXVI International Law and Development INTRODUCTION Murtaza Jaffer Coverage Understanding international law connection to development discussion on challenges the world faces and how states and citizens can engage with international law and policy to create a better world. Extra focus on IHL - genocide, war crimes & crimes against humanity Domestic/National Law Statute Law (may include customary laws) passed by Parliament of Council or Monarch or Dictator jurisdiction - national boundaries Citizen / State relations International Law Treaty Law Agreed between sovereign states. Approval of Parliament. Governs issues agreed in the treaty - (war & peace; trade; development; environment; immigration; etc) Aspects of International Law Public international law - relationship between states and international entities. includes treaty law, law of sea, international criminal law, the laws of war or international humanitarian law, international human rights law, and refugee law Private international law - largely conflict of laws, jurisdictional issues, civil law Law of supranational organizations - primacy of treaty overriding national laws where does international law come from? Agreement between parties to the treaty Customary international law - practice of states • (codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties) International law treaties are as old as people holding territory - fighting and trading. oldest surviving peace treaty, the Ramses-Hattusili Treaty - Temple of Amun in Karnak. Agreed after the Battle of Kadesh 1283 B.C. other interesting examples: Border agreement between the rulers of the city-states of Lagash and Umma 2100 (Lagash and Umma BC of Mesopotamia) in Mesopotamia, inscribed on a stone block, setting a proscribed boundary between their two states. -

Selected Ancestors of the Chicago Rodger's
Selected Ancestors of the Chicago Rodger’s Volume I: Continental Ancestors Before Hastings David Anderson March 2016 Charlemagne’s Europe – 800 AD For additional information, please contact David Anderson at: [email protected] 508 409 8597 Stained glass window depicting Charles Martel at Strasbourg Cathedral. Pepin shown standing Pepin le Bref Baldwin II, Margrave of Flanders 2 Continental Ancestors Before Hastings Saints, nuns, bishops, brewers, dukes and even kings among them David Anderson March 12, 2016 Abstract Early on, our motivation for studying the ancestors of the Chicago Rodger’s was to determine if, according to rumor, they are descendants of any of the Scottish Earls of Bothwell. We relied mostly on two resources on the Internet: Ancestry.com and Scotlandspeople.gov.uk. We have been subscribers of both. Finding the ancestral lines connecting the Chicago Rodger’s to one or more of the Scottish Earls of Bothwell was the most time consuming and difficult undertaking in generating the results shown in a later book of this series of three books. It shouldn’t be very surprising that once we found Earls in Scotland we would also find Kings and Queens, which we did. The ancestral line that connects to the Earls of Bothwell goes through Helen Heath (1831-1902) who was the mother and/or grandmother of the Chicago Rodger’s She was the paternal grandmother of my grandfather, Alfred Heath Rodger. Within this Heath ancestral tree we found four lines of ancestry without any evident errors or ambiguities. Three of those four lines reach just one Earl of Bothwell, the 1st, and the fourth line reaches the 1st, 2nd and 3rd. -

{DOWNLOAD} Venice, a Maritime Republic Pdf Free Download
VENICE, A MARITIME REPUBLIC PDF, EPUB, EBOOK Frederic Chapin Lane | 528 pages | 01 Dec 1973 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS | 9780801814600 | English | Baltimore, MD, United States Republic of Venice | Account Options Sign in. Try the new Google Books. Check out the new look and enjoy easier access to your favorite features. Try it now. No thanks. Get print book. JHU Press Amazon. Shop for Books on Google Play Browse the world's largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader. Venice, A Maritime Republic. Frederic Chapin Lane. JHU Press , - History - pages. The children's version of the 1 New York Times bestselling classic Seriously, Just Go to Sleep is the G-rated, child-friendly version of the book every parent has been talking about. Of course, kids are well aware of how difficult they can be at bedtime. With Mansbach's new child-appropriate narrative, kids will recognize their tactics, giggle at their own mischievousness, and empathize with their parents' struggles--a perspective most children's books don't capture. Most importantly, it provides a common ground for children and their parents to talk about one of their most stressful daily rituals. This is a fixed-format ebook, which preserves the design and layout of the original print book. User Review - Flag as inappropriate Seamen. Selected pages Title Page. Table of Contents. Contents The Beginnings. A Community Center by Canaletto. Venice about woodcut by Vavassore. Victories BeyondtheSea and in Romania. Illuminated Initial from the Maritime Code of Doge Leonardo Loredan by Giovanni Bellini. The Condottiere in front of San Marco. -

Kasnoantička I Ranosrednjovjekovna Tarsatička Liburnija (Liburnia Tarsaticensis) U Svjetlu Geografskih Izvora
Tin Turković, Ivan BASIĆ Kasnoantička i ranosrednjovjekovna Tarsatička Liburnija (Liburnia Tarsaticensis) ... Starohrvatska prosvjeta uDk: 94:528.93(497.5)“1/9“94(398liburnija) iii. serija - svezak 40/2013. izvorni znanstveni rad 33 tin turkoviĆ kasnoantička i odsjek za povijest umjetnosti Filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu ranosrednjovjekovna tarsatička ivana lučića 3, 10 000 zagreb liburnija (Liburnia Tarsaticensis) [email protected] u svjetlu geografskih izvora ivan basiĆ odsjek za povijest t ardoantica e altomedievale liburnia Filozofski fakultet sveučilišta u splitu ivana pl. zajca b.b., 21 000 split tarsaticense (Liburnia Tarsaticensis) [email protected] nel contesto dello studio delle fonti geografiche Rad predstavlja nastojanje da se kasnoantička i ranosrednjovjekov- na povijest Tarsatike sagleda cjelovito iz perspektive dostupnih izvora i iz perspektive geopolitičkog konteksta u kojem je postojala između 2. i 10. stoljeća. Posebna pozornost pridana je razjašnjavanju geografskih okvira upravno-administrativnih tvorevina unutar kojih se Tarsatika za- tekla u navedenome razdoblju. Zato su ponovno razmotrene pretpostavke iznesene u dosadašnjim studijama posvećenima opsegu i značaju Tar- satičke Liburnije u kasnoantičko i ranosrednjovjekovno doba. Pri tome su u obzir uzeti svi dostupni izvori, uključujući i one koji su dosad ostali zanemareni u znanstvenoj raspravi o tarsatičkoj povijesti. Ponajprije su u diskusiju uvedeni izvori kao što je Peutingerova karta, najraniji i jedini kasnoantički i srednjovjekovni kartografski prikaz -
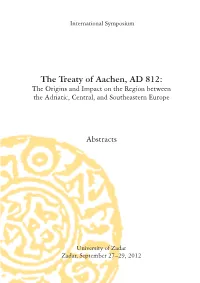
Borna's Polity Attested by Frankish Sources in the Territory of the Former
International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Abstracts University of Zadar Zadar, September 27–29, 2012 Abstracts of the International Symposium The Treaty of Aachen, AD 812: The Origins and Impact on the Region between the Adriatic, Central, and Southeastern Europe Zadar, September 27–29, 2012 University of Zadar Department of History 2012 Frankish ducatus or Slavic Chiefdom? The Character of Borna’s Polity in Early-Ninth-Century Dalmatia Denis Alimov Borna’s polity, attested by Frankish sources on the territory of the former Roman province of Dalmatia in the first quarter of the 9th century, is traditionally considered to be the cradle of early medieval Croatian state. Meanwhile, the exact character of this polity and the way it was linked with the Croats as an early medieval gens remain obscure in many respects. I argue that Borna’s ducatus consisted of two political entities, the Croat polity proper, with its heartland in the region of Knin, and a small chiefdom of the Guduscani in the region of Gacka. Borna was the chief of the Croats, a group of people that gradually developed into an ethnic unit under the leadership of a Christianized military elite.. For all that, the process of the stabilization of the Croats’ group identity originally connected with the social structures of Pax Avarica and its transformation into what can be called gentile identity was very durable, the rate of the process being considerably slower than the formation of supralocal political organization in Dalmatia. -

Introduction
INTRODUCTION « L’empereur Dioclétien aimait beaucoup la Dalmatie. Aussi ame- na-t-il de Rome des gens avec leurs familles (…). Dans l’Antiquité, la Dalmatie commençait aux confins de Dyrrachium, ou d’Antibari, et allait aussi loin que les montagnes d’Istrie, pour s’étendre jusqu’au Danube. Tout ce territoire était sous le contrôle des Romains, et cette province était la plus illustre de toutes les provinces de l’ouest » 1. En écrivant ces lignes au milieu du Xe siècle, l’empereur byzantin Constantin Porphyrogénète insistait sur la longue histoire romaine du thème de Dalmatie 2. Ce passé omniprésent 3 favorisa une nouvelle forme de romanisation 4 encouragée, de l’Antiquité tardive au Moyen Âge central, par les prétentions croissantes de l’Église de Rome et, à la fin du XIe siècle, par la baisse progressive de l’influence de Byzance dans l’Adriatique 5. Cette histoire, qui s’étend sur près de sept siècles, n’est pas un mouvement linéaire. Elle est faite d’ambitions, d’échecs, de revi- 1 De Administrando Imperio [désormais abrégé DAI], 29-30. 2 L’une des plus célèbres histoires de la Dalmatie a été écrite par l’érudit italien Giuseppe Praga et publiée une première fois à Padoue en 1954. Une édition complétée par Mario Dassovich est parue en 1981. G. Praga, originaire de Zadar, insistait sur la continuité culturelle qui caractérisait l’histoire dalmate depuis la romanisation de la région dans l’Antiquité. Cette vision a été critiquée par l’historiographie yougoslave puis croate (voir Petrovi� 2005, p. 349, qui cite Šunji� 1960). -

Byzantine and Islamic Influences on the Art and Architecture of the Basilica Di San Marco in Venice
Lindenwood University Digital Commons@Lindenwood University Student Research Papers Research, Scholarship, and Resources Summer 7-2021 Byzantine and Islamic Influences on the Art and Architecture of the Basilica di San Marco in Venice Suzie Hanny Lindenwood University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lindenwood.edu/student-research-papers Part of the Classical Archaeology and Art History Commons Recommended Citation Hanny, Suzie, "Byzantine and Islamic Influences on the Art and Architecture of the Basilica di San Marco in Venice" (2021). Student Research Papers. 7. https://digitalcommons.lindenwood.edu/student-research-papers/7 This Research Paper is brought to you for free and open access by the Research, Scholarship, and Resources at Digital Commons@Lindenwood University. It has been accepted for inclusion in Student Research Papers by an authorized administrator of Digital Commons@Lindenwood University. For more information, please contact [email protected]. Byzantine and Islamic Influences on the Art and Architecture of the Basilica di San Marco in Venice Suzie Hanny ARTH 55800: Medieval Art Instructor: Dr. James Hutson July 7, 2021 1 More than any other building in Venice, the Basilica di San Marco (figure 1) incorporates many Byzantine and Islamic architectural, artistic, and design elements. These stylistic elements were not only intended to glorify God but to promote the Venetian Republic’s political and religious ideologies. The Venetian Republic held the belief that it was divinely ordained to be the rulers of the Adriatic. It was no coincidence that the founding of Venice is said to have occurred on March 25th, the feast day of the Annunciation of the Virgin Mary. -

Venetian Forest Law and the Conquest of Terraferma (1350-1476)
LAWYERS AND SAWYERS: VENETIAN FOREST LAW AND THE CONQUEST OF TERRAFERMA (1350–1476) Michael S. Beaudoin A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in History Boise State University December 2014 ©2014 Michael S. Beaudoin ALL RIGHTS RESERVED BOISE STATE UNIVERSITY GRADUATE COLLEGE DEFENSE COMMITTEE AND FINAL READING APPROVALS of the thesis submitted by Michael S. Beaudoin Thesis Title: Lawyers and Sawyers: Venetian Forest Law and the Conquest of Terraferma (1350–1476) Date of Final Oral Examination: 30 July 2014 The following individuals read and discussed the thesis submitted by student Michael S. Beaudoin, and they evaluated his presentation and response to questions during the final oral examination. They found that the student passed the final oral examination. Lisa M. Brady, Ph.D. Chair, Supervisory Committee David M. Walker, Ph.D. Member, Supervisory Committee Leslie Alm, Ph.D. Member, Supervisory Committee The final reading approval of the thesis was granted by Lisa M. Brady, Ph.D., Chair of the Supervisory Committee. The thesis was approved for the Graduate College by John R. Pelton, Ph.D., Dean of the Graduate College. DEDICATION Pella mia colomba iv AKNOWLEDGEMENTS An expression of gratitude is in order for the individuals and institutions that made this thesis a reality. First, I cannot express my appreciation enough to the three members of my thesis committee. These faculty members represent more than members of a committee. I had the privilege to study under each committee member. Their guidance and professionalism will serve as a model for my future roles inside and outside of academia. -

Download (2810Kb)
University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/69994 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Dramatic Figures in the Venetian Republic: Performance, Patronage, and Puppets by Melanie Zefferino Submitted in part fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy in the History of Art at the University of Warwick September 2014 This dissertation may be photocopied CONTENTS Acknowledgements i Abstract iii List of Tables iv List of Illustrations v Introduction 1 Definitions and Taxonomy 2 Scope of the Research, and Historical and Critical Approaches 4 Methodology, Literature Review, and Sources 7 Dissertation Structure 16 PART 1 – HIERATIC FIGURES AND EARLY INVENTIONS 19 I Dramatic Figures of the Middle Ages 20 The Influence from French Culture 22 Venice’s Porta da Mar: a Gate for Liturgical and Feast-day Drama 25 ‘Animated’ Sculptures for the Passio, Depositio, and Entombment of Christ 37 Marys, Marione, and Marionettes 49 II Puppets, Automata, and Theatres of the World 61 The Momarie 62 Puppetry and the Commedia dell’Arte 68 Ephemeral Theatres on the Ground and on Water 77 III Theatrical Feasts and Figures: from the Catajo Palace to Villa Contarini 84 Il Solimano, 1634 85 -

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU 1. SKUPLJANJE GRAĐE 1.1. Kupnja
ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU 1. SKUPLJANJE GRA ĐE 1.1. Kupnja − Kupnjom je od D. Mari čića iz Zagreba nabavljena sljede ća muzejska gra đa (gl. inv. 502): za Pretpovijesni odjel otkupljeno je 5 predmeta: bron čanodobni ma č (P-21193), željezna sjekira (P-21192) i žvale (3 kom., P-21189-21191), za Anti čki odjel otkupljeno je 27 predmeta: tesarske sjekire, otika či, tesarski alat, sjekira tzv. dolabra , nož s bron čanim okovom korica, motika (A-18205 do A-18231), za Srednjovjekovni odjel izdvojene su tri ranosrednjovjekovne sjekire, jedan kasnosrednjovjekovni buzdovan i jedna novovjeka sjekira (obrada u tijeku) − Od B. Čečuka otkupljena je zbirka anti čkih nalaza porijeklom iz Jadranskog mora: rimska amfora sjevernoafri čkog podrijetla, tzv. tip Spatheion (Dressel 27), 4.-6. st. (A-18194), bizantska amfora (Dressel 28 ili 30), 6. st. (A-18195), fragmentirani grli ć rimske amfore (A-18196), rimski vr č, tzv. lagoena (A-18197), poklopac posude, tzv. operculum (A-18198), 3 rimska plitka tanjura (A-18199, 18200, 18201), plitka zdjela naglašenog obruba (A-18202), fragmentirana posuda s jednom o čuvanom ru čkom (urceolus ?) (A-18203), fragmentirani kalež za pi će ( calix ) (A-18204) − Od L. Sui ć otkupljen je kameni izljev rimske fontane (KS-935) i jantarna figurica labuda (A-18193) − Iz privatne zbirke M. Stari ća iz Zagreba otkupljena je staklena antropomorfna bo čica s ru čkicom, iz 2.-3. st. proizvedena u sirijskim radionicama (A-18182) − Od M. Švaljuga iz Kloštar Ivani ća otkupljen je zlatnik Sulejmana II Veli čanstvenog iz 1520. godine (E55646) − Od Jasminke Trusk iz Križa otkupljena je lijevana francuska medalja Henrika II. -

Benátky a Byzancia V 5. – 9
BENÁTKY A BYZANCIA V 5. – 9. STOROČÍ (VZÁJOMNÉ SÚVISLOSTI)1 Venice and Byzantium During the 5th – 9th Centuries (Mutual Connections) Martina Lukáčová DOI: 10.17846/CL.2017.10.1.180-189 Abstract: LUKÁČOVÁ, Martina. Venice and Byzantium During the 5th – 9th Centuries (Mutual Connections). The time and place, where an important event in Slavonic history took place, was an impetus to write the referred article. That event was the dispute with the so called trilingualists in Venice in the year 867. Our goal is not to deal with this event in detail, but to use it as one of the factors which influenced and made relations and mutual connections between Venice and Byzantium over a broad time range. Except the mentioned factor we focus on the further factors of interferences between Venice and Constantinople (the Byzantine Empire). The time when Venice was founded was a period which is clearly and logically connected with the Byzantine influence and thus we deal with this phase of development too. Within the framework of the given topic and time we describe only some selected noticeable interwoven factors – e.g. the emergence of the so called Byzantine Venice and its circumstances, the status of Venice as an part of the Exarchate of Ravenna, the position of Venice in the conflict between Byzantines and Franks. Key words: Venice, Venetian Lagoon, Republic of Venice, Byzantine Empire, Exarchate of Ravenna, Frankish Empire Abstrakt: LUKÁČOVÁ, Martina. Benátky a Byzancia v 5. – 9. storočí (Vzájomné súvislosti). Podnetom k napísaniu predkladaného príspevku bolo obdobie a miesto, kde sa konala vý- znamná udalosť v slovanských dejinách.