Implantologia Odontoiatrica
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Imbalance of the Immune System Instead of a Disease Behind Marginal Bone Loss Around Oral Implants: Position Paper
An Imbalance of the Immune System Instead of a Disease Behind Marginal Bone Loss Around Oral Implants: Position Paper Tomas Albrektsson, MD, PhD, RCPSG1/Christer Dahlin, DDS, PhD2/David Reinedahl, DDS, PhD candidate3/ Pentti Tengvall, PhD4/Ricardo Trindade, DDS, PhD3/Ann Wennerberg, DDS, PhD3 Purpose: The purpose of this paper is to present evidence that supports the notion that the primary reason behind marginal bone loss and implant failure is immune-based and that bacterial actions in the great majority of problematic cases are of a secondary nature. Materials and Methods: The paper is written as a narrative review. Results: Evidence is presented that commercially pure titanium is not biologically inert, but instead activates the innate immune system of the body. For its function, the clinical implant is dependent on an immune/inflammatory defense against bacteria. Biologic models such as ligature studies have incorrectly assumed that the primary response causing marginal bone loss is due to bacterial action. In reality, bacterial actions are secondary to an imbalance of the innate immune system caused by the combination of titanium implants and ligatures, ie, nonself. This immunologic imbalance may lead to marginal bone resorption even in the absence of bacteria. Conclusion: Marginal bone loss and imminent oral implant failure cannot be properly analyzed without a clear understanding of immunologically caused tissue responses. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35:495–502. doi: 10.11607/jomi.8218 Keywords: biomaterials, failure analysis, immunologic reactions, peri-implantitis, review (narrative) eri-implant disease is described as a common prob- studies verifying primary bacterial attacks. Lamentably, Plem in dentistry today, and no definitive protocol none of these cornerstones has survived the scrutiny of exists for its treatment. -

Note to Users
NOTE TO USERS This reproduction is the best copy available. ® UMI Oral Health of Patients Suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Its Relationship with the Exacerbation Events Mareya AL-Jawder Faculty of Dentistry McGill University, Montreal October 2003 A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirement of the degree of M.Sc. in Dental Sciences © Mareya AL-Jawder 2003 Library and Bibliothèque et 1+1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 0-612-98586-5 Our file Notre référence ISBN: 0-612-98586-5 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant à la Bibliothèque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans loan, distribute and sell th es es le monde, à des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, électronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protège cette thèse. this thesis. Neither the thesis Ni la thèse ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Journal for Dental Implantologists ISSN 1862-2879 I Vol
European Journal for Dental Implantologists ISSN 1862-2879 I Vol. 12 I Issue 3/2016 Journal 3/16 EDI EDIJOURNAL TOPIC Creating synergy with conventional and small-diameter implants »EDI News: Brexit and its impact · Coming up: 12th BDIZ EDI Expert Symposium · S3 guideline on peri-implantitis · Implantology in Macedonia »European Law: Fixed prices for prescription-only medicinal products? »Clinical Science: Mini- implants to restore the function of removable dentures »Case Studies: Maximizing aesthetics and function with immediate implant placement · Creating synergy with conven- tional and small-diameter implants Very smart, very simple, very iSy. iSy. The intelligent system. iSy is the sensible, lean implant system that ensures cost-efficient implant treatment whilst still offering reliable CAMLOG quality. Whether digital or conventional, whether transgingival or subgingival: thanks to its intelligent design, the implant sets and the three treatment models, iSy is versatile and flexible – adding real added value to your daily practice by its easy handling and efficient workflow. And all this at an unbeatable cost-benefit ratio. Have a look and see for yourself: www.isy-implant.com www.camlog.com ISY-15-012_AZ_Gluehbirne_210x297.indd 1 07.04.2016 14:13:01 3 EDITORIAL Very smart, very simple, Brexit? very iSy. Count us out! Demoscopes had foreseen it for a long time: In Great Britain, For years, Cologne has been the „meeting point“ for all part- signs had been pointing to the British exit from the European ner associations of the BDIZ EDI. During the sessions of the an- Union many months before the referendum. Nevertheless, nual European Committee meeting, we discuss the situation nobody on the Continent believed this might actually hap- of dentists in the particular countries und decide on common pen. -

Implant Surfaces Beyond Micron Roughness
CLINICAL IMPLANT SURFACES BEYOND MICRON ROUGHNESS. EXPERIMENTAL AND CLINICAL KNOWLEDGE OF SURFACE TOPOGRAPHY AND SURFACE CHEMISTRY ANN WENNERBERG1, TOMAS ALBREKTSSON1 urface texture has long been considered important in (Ellingsen et al., 2004). Is the incorporation of OsseoSpeedTM osseointegration of implants, and the finer detail of supported by its modified nanotopography or by the surface Ssurface texture and its effect on bone response can guide being bioactive (Figure 1)? A bioactive surface is capable of implant development and surgery. establishing chemical bonds across the interface, resulting in a Implant surface topography at the micrometer level of rapidly achieved bony anchorage. The aim of this paper is to resolution (“microtopography”) has been regarded as the most summarize in vivo experimental and clinical evidence of surface important factor for successful implant treatment during the modifications with particular reference to the OsseoSpeedTM last decade. Allegedly, shorter healing periods and greater implant. implant success will result from the use of moderately roughened surfaces. However, there is a dearth of clinical documentary evidence for such statements. In addition, it is difficult to control implant surface topography at the micrometer level without altering the surface at the nanometer level (“nanotopographies”). The available clinical documentation mainly refers to topographical changes at the micrometer level of resolution. Furthermore, even with the best of approaches, altering surface topography will most often result in a changed surface chemistry as well, indicating the need to consider different aspects of surface quality rather than topography alone. Hence, attempted surface enlargement at the micrometer level may change nanotopography and surface chemistry as well; the latter surface alterations accidental rather than planned in many cases. -

European Journal Of
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY Official publication of the British Society of Oral Implantology (BSOI), the Italian Society of Oral Surgery and Implantology (SICOI), the Danish Society for Oral Implantology (DSOI), the German Association of Oral Implantology (DGI), the Spanish Society of Implantology (SEI), the British Academy of Implant & Restorative Dentistry (BAIRD), and the Advanced Dental Implant Research & Education Center (AIC) A FOR consensus conference on Diagnosis, avoidance and management of complications of implant-based treatments Catholic University of Leuven, Belgium November 16th and 17th, 2017 EJOI VOLUME 11 / SUPPLEMENT 1 AUTUMN 2018 EDITORIAL n S3 Editorial This supplemental issue of EJOI is dedicated to the reporting’ and you will access a comprehensive list of Foundation for Oral Rehabilitation (FOR) consen- reporting guidelines, organised by study type. More sus conference, ‘Diagnosis, avoidance and manage- specifically, to evaluate systematic reviews please ment of complications of implant-based treatments’, go to the PRISMA transparency guidelines (http:// which was held on the 16th and 17th November www.prisma-statement.org/). 2017 at the Catholic University of Leuven, Belgium. The results of consensus conferences or work- Scientific associations and other organisations using ing groups can be interpreted differently, depending EJOI as their official publication are welcome to on people’s perspectives and circumstances. Please publish the outcome of their consensus conferences consider the conclusions presented carefully. They or working groups in the journal. are the opinions of the review authors, and are not It is the policy of EJOI that these publications will necessarily shared by EJOI editors. not be peer reviewed as they are normally. -

Often Realize Your Ambitions and Achieve Your Goals with the Nobel Biocare Guide to Growth™ Program
Nobel Biocare NEWS Information for the Osseointegration Specialist Issue 1/2016 In this Issue 2 Register now: Seats at the Nobel Biocare Global Symposium in New York, June 23–26, will soon be gone. Whatever you do, don’t miss this event! 4 Managing forces: Take a look at the biomechanics underlying the All-on-4® treatment concept. Hear “Yes!” More Often Realize your ambitions and achieve your goals with the Nobel Biocare Guide to Growth™ program. 8 Tomas Albrektsson says: learned that increasing patient Nobel Biocare’s new Guide to education events provide just a few ”The frequency of Over the years, Nobel awareness of implant-based treat- Growth program. Based on the of the proven pathways toward in- peri-implantitis has been Biocare has not only ment increases the rate of treatment principal insights into what usually creased patient flow. grossly exaggerated in provided its customers with acceptance, the important first step makes an implant-oriented practice Ever wonder why some dentists the literature.” the peace of mind associated on the road to ultimate patient satis- successful, this professional pro- find it easier than others to get their with tried and true products faction. gram-for-purchase provides a road patients to say yes to implant treat- and services, it has also map to help every member of the ment? As it turns out, practices that successfully helped many of Guide to Growth™ treatment team reach his or her can present a complete patient jour- them to revolutionize their In the centerfold of this issue of professional goals. -

Foreign Body Reactions, Marginal Bone Loss and Allergies in Relation to Titanium Implants
REVIEW S37 Tomas Albrektsson, Bruno Chrcanovic, Johan Mölne, Ann Wennerberg Foreign body reactions, marginal bone loss and allergies in relation to titanium implants Tomas Albrektsson Key words foreign body reactions, marginal bone loss, titanium allergy Department of Biomaterials, University of Gothenburg, Sweden; Department of Aim: To describe general observations of immunological reactions to foreign materials and to real- Prosthodontics, Malmö Uni- versity, Sweden ize that CP titanium gives rise to a foreign body reaction with subsequent bone embedment when placed as oral implants. To analyse the possibility of titanium allergy. Bruno Chrcanovic Department of Prostho- Materials and methods: The present paper is of a narrative review type. Hand and Medline searches dontics, Malmö University, were performed to evaluate marginal bone loss of oral implants and the potential of titanium allergy. Sweden Results: Immunological reactions to foreign substances include Type I hypersensitivity reactions such Johan Mölne Department of Pathology as allergy, Type II hypersensitivity reactions characterised by IgM or IgG antibodies that may react and Genetics, Sahlgren- with blood group antigens at transfusion, and Type III hypersensitivity caused by antigen-antibody ska Academy; University of Gothenburg, Sweden immune complexes exemplified by acute serum sickness. There is also Type IV hypersensitivity, or delayed hypersensitivity, which is typically found in drug and foreign body reactions. It proved very Ann Wennerberg Department of Prostho- difficult to find a universally acceptable definition of reasons for marginal bone loss around oral dontics, Malmö University, implants, which lead to most varying figures of so-called peri-implantitis being 1% to 2% in some Sweden; Department of Prosthodontics, University of 10-year follow-up papers to between 28% and 56% of all placed implants in other papers. -
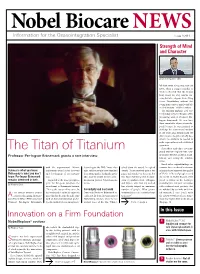
The Titan of Titanium Since Those Early Days, Osseointe- Grated Titanium Implants Have Revo- Professor Per-Ingvar Brånemark Grants a Rare Interview
Nobel Biocare NEWS Information for the Osseointegration Specialist Issue 1/2011 Strength of Mind TheThe Big Big Oxmox Oxmox advised advised When When she she reachedreached the the first first hills hills of theof the Italic Italic and Character Mountains,Mountains, she she had had a last a last view view back back on onthe the skylineskyline of her.of her. By Richard Laube, CEO We have come a long way since the 1950s, when a young researcher in Sweden observed that the human body would not only tolerate tita- nium, but also integrate it into living tissue. Nevertheless, without that young man’s curious mind—and ad- mirable tenacity—we’d be nowhere. The titanium implants used rou- tinely today only exist because of the pioneering work of Professor Per- Ingvar Brånemark. We now have these remarkable objects at our dis- posal because he was prepared to challenge the conventional wisdom of the times, and demonstrated the determination to systematically doc- ument the evidence he needed in order to prevail over well-established opposition. The Titan of Titanium Since those early days, osseointe- grated titanium implants have revo- Professor Per-Ingvar Brånemark grants a rare interview. lutionized the fields of dental, maxil- lofacial and orthopedic rehabili- tation. Based on his original findings, in- with the organization’s lifetime According to the EPO, “more than asked about the award, he replied novative bone-anchored restorative Science is what you know. achievement award for his discovery eight million people have benefited simply, “I have received quite a few solutions have improved the quality Philosophy is what you don’t and development of osseointegra- from Brånemark’s landmark meth- prizes and awards over the years, but of life for millions of people around know. -

Top-Cited Articles in Implant Dentistry Anastasia Fardi, DDS, Phd1/Konstantinos Kodonas, DDS, Phd2/ Theodoros Lillis, DDS, Msc3/Alexander Veis, DDS, Phd†
Top-Cited Articles in Implant Dentistry Anastasia Fardi, DDS, PhD1/Konstantinos Kodonas, DDS, PhD2/ Theodoros Lillis, DDS, MSc3/Alexander Veis, DDS, PhD† Purpose: Citation analysis is the field of bibliometrics that uses citation data to evaluate the scientific recognition and the influential performance of a research article in the scientific community. The aim of this study was to conduct a bibliometric analysis of the top-cited articles pertaining to implant dentistry, to analyze the main characteristics, and to display the most interesting topics and evolutionary trends. Materials and Methods: The 100 top-cited articles published in “Dentistry, Oral Surgery, and Medicine” journals were identified using the Science Citation Index Database. The articles were further reviewed, and basic information was collected, including the number of citations, journals, authors, publication year, study design, level of evidence, and field of study. Results: The highly cited articles in implant dentistry were cited between 199 and 2,229 times. The majority of them were published in four major journals: Clinical Oral Implants Research, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Clinical Periodontology, and Journal of Periodontology. The publication year ranged from 1981 to 2009, with 45% published in a nine-year period (2001 to 2009). Publications from the United States (29%) were the most heavily cited, followed by those from Sweden (23%) and Switzerland (17%). The University of Göteborg from Sweden produced the highest number of publications (n = 19), followed by the University of Bern in Switzerland (n = 13). There was a predominance of clinical papers (n = 42), followed by reviews (n = 25), basic science research (n = 21), and proceedings papers (n = 12). -
Reasons for Marginal Bone Loss Around Oral Implants – Qian
Reasons for Marginal Bone Loss around Oral Implants Jie Qian, LDS, MSc;*† Ann Wennerberg, LDS, PhD;†‡ Tomas Albrektsson, MD, PhD†§ ABSTRACT Background: The reasons for long-term marginal bone loss around oral implants are not well understood. Purpose: The aim of this paper is to analyze presented evidence behind anticipated reasons for long-term marginal bone loss around oral implants. Materials and Methods: A computerized research was conducted on PubMed in April 2011 with the following keywords: oral implants and marginal bone resorption/crestal bone loss/bone loss/bone resorption. This search resulted in a total of one thousand one hundred ninety-four papers of which seven hundred fifty-three were clinical contributions. Further search and filtering finally resulted in 21 experimental studies and one hundred sixteen clinical studies, which were reviewed. Results: No evidence was found that primary infection caused marginal bone resorption. Clinical papers that have reported high levels of peri-implantitis were not supported by data given. Clinical evidence was presented that the so-called combined factors (implant hardware, clinical handling, and patient characteristics) may lead to marginal bone resorption. However, once tissue damage has been caused by combined factors, inflammation and/or infection may develop second- arily and then result in peri-implantitis that may need particular clinical treatment. Conclusions: As marginal bone loss primarily depends on numerous background factors, it seems logical that, for example, the use of poorly constructed implants placed and handled by untrained clinicians may result in high numbers of patients with secondary problems in form of peri-implantitis; having said this, control of combined factors may likewise lead to very good clinical results where peri-implantitis would represent a very rare disease indeed even at follow-up times of 10 years or more. -
Tiunite) Surface: a Meta-Analysis of Prospective Clinical Studies
Clinical Performance of Dental Implants with a Moderately Rough (TiUnite) Surface: A Meta-Analysis of Prospective Clinical Studies Matthias Karl, Prof Dr Med Dent1/Tomas Albrektsson, MD, PhD2 Purpose: A moderately rough anodized titanium implant surface (TiUnite) was introduced in 2000. This review and meta-analysis aimed to assess implant survival and marginal bone level (MBL) changes documented in the literature. Materials and Methods: Repeated literature searches on dental implants were conducted, with the final search on October 7, 2016. The inclusion criteria were: prospective study, minimum of 20 patients, at least 12 months follow-up postloading, and TiUnite implant survival reported. Regression analysis was performed on implant survival and MBL change from implant surgery. Peri-implantitis as defined by the primary authors was reported at the patient level. Results: One hundred six out of 32,519 publications on dental implants met the inclusion criteria. Implant survival rates at 1 year were 99.50% at the implant level and 99.12% at the patient level, and survival rates at 10 years were 95.14% at the implant level and 91.50% at the patient level. Mean MBL change at 1 year was –0.409 mm at the implant level and –0.413 mm at the patient level, and at 5 years, it was –0.886 mm at the implant level and –1.029 mm at the patient level. Nineteen studies (18%) specifically reported peri-implantitis in 64 out of 1,229 patients with a mean follow- up of 47.89 months, indicating a prevalence of 5.20% at the patient level. -
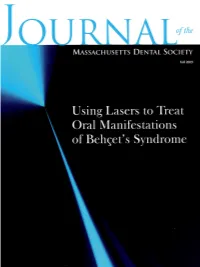
Journal Fall 2009.Indd
EDITORIAL JOURNAL OF THE MASSACHUSETTS DENTAL SIMPLE TRUTHS SOCIETY E WRITE THESE WORDS AS OUR GOVERNMENT AND CITIZENS BATTLE (SOMETIMES LITERALLY) EDITOR Wover health care reform and as our state and nation have lost two Kennedy sib- David B. Becker, DMD lings, one the longtime “Lion of the Senate” and the other the founder of the Special ASSISTANT EDITOR Olympics Program. Arthur I. Schwartz, DMD Since 1968, the Special Olympics has raised the quality of life and self-esteem of EDITOR EMERITUS countless people with special needs. Eunice Kennedy Shriver also understood the ben- Norman Becker, DDS efi ts of good oral health. She paved the way for dentistry to be a part of the Special Olympics competitions, opening doors to dental care to a truly underserved popula- MANAGING EDITOR OF tion, many of whom had never received even rudimentary dental evaluation. One of PUBLICATIONS AND WEB SITE our own members, Dr. Steve Perlman, spearheaded this effort, which has grown to Melissa Carman worldwide dimensions and brought higher respect to all of us as a profession. MANAGER, GRAPHIC DESIGN Senator Edward M. Kennedy was a champion for public health causes. Ironically, Jeanne M. Burdette while it often seemed popular among our peers to oppose anything he said, far more GRAPHIC DESIGNER often than not he fought for many of the same causes we, as a profession, also sought. Shelley Padgett Ted Kennedy and Eunice Kennedy Shriver were people of privilege who used their inherited advantages and natural talents to do what they could to improve the world around them. Whether or not we agree with all that they did, it cannot be argued that Editorial Board they left the world a better place.