Anna Arcella.Pub
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
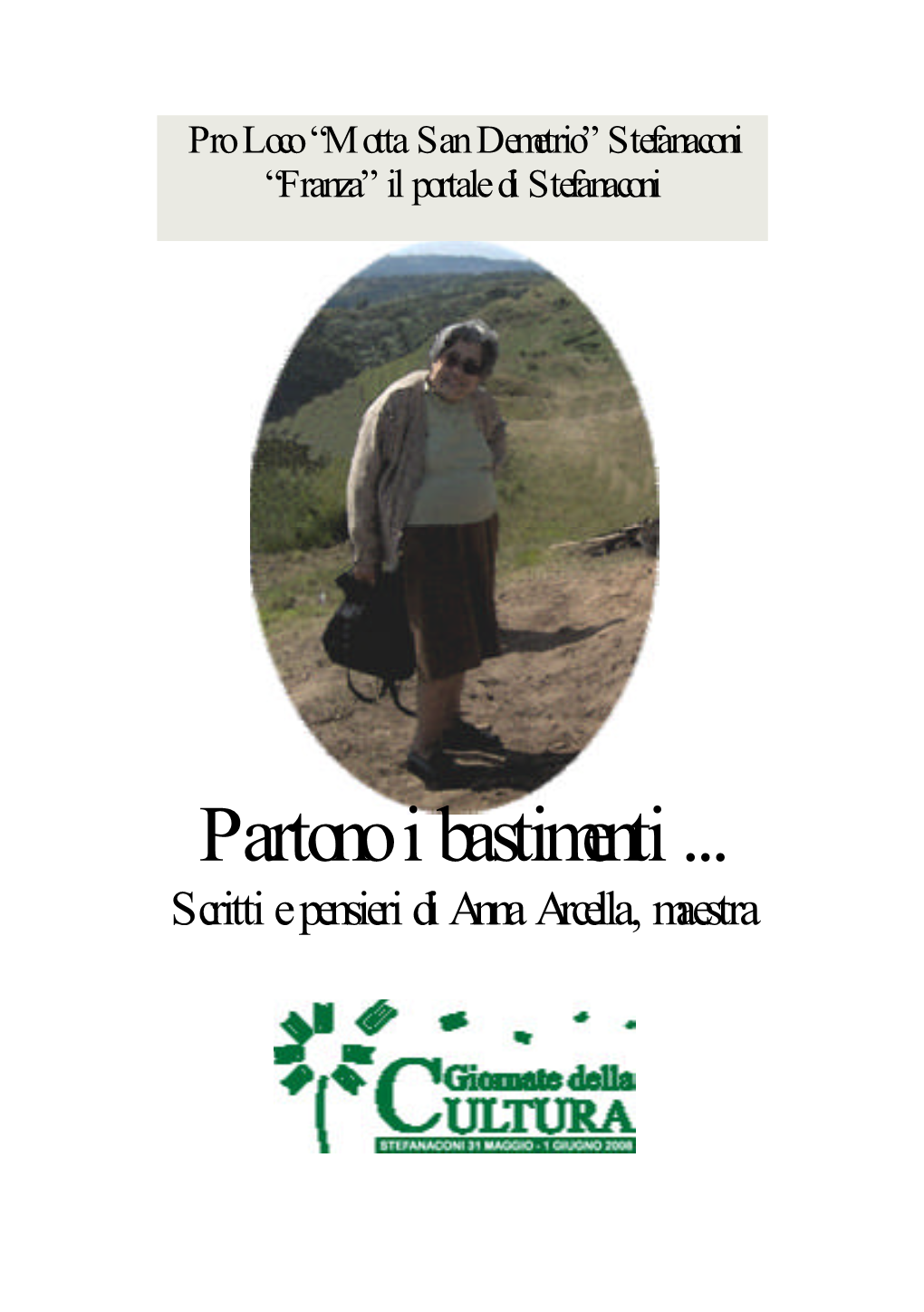
Load more
Recommended publications
-

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2016
Ufficio del territorio di VIBO VALENTIA Data: 20/02/2017 Ora: 10.29.10 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNE DI SERRA SAN BRUNO COLLINE OCCIDENTALI DEL MESIMA Comuni di: ARENA, BROGNATURO, FABRIZIA, MONGIANA, Comuni di: FILANDARI, FILOGASO, FRANCICA, IONADI, LIMBADI, NARDODIPACE, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SPADOLA MAIERATO, MILETO, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D`IPPONA, SANT`ONOFRIO, STEFANACONI, ZUNGRI COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 52415,32 SI SI BOSCO CEDUO 6733,43 5230,76 BOSCO D`ALTO FUSTO 11783,51 CANNETO 13942,70 CASTAGNETO 5984,90 FRUTTETO 10916,03 27096,48 INCOLTO PRODUTTIVO 1284,97 1414,02 NOCCIOLETO 34789,42 ORTO IRRIGUO 22031,81 PASCOLO 2499,23 2301,72 PASCOLO ARBORATO 2959,34 3550,76 PASCOLO CESPUGLIATO 1577,88 2038,00 QUERCETO 4142,20 5918,68 Pagina: 1 di 4 Ufficio del territorio di VIBO VALENTIA Data: 20/02/2017 Ora: 10.29.10 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2016 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNE DI SERRA SAN BRUNO COLLINE OCCIDENTALI DEL MESIMA Comuni di: ARENA, BROGNATURO, FABRIZIA, MONGIANA, Comuni di: FILANDARI, FILOGASO, FRANCICA, IONADI, LIMBADI, NARDODIPACE, SERRA SAN BRUNO, SIMBARIO, SPADOLA MAIERATO, MILETO, ROMBIOLO, SAN CALOGERO, SAN COSTANTINO CALABRO, SAN GREGORIO D`IPPONA, SANT`ONOFRIO, STEFANACONI, ZUNGRI COLTURA Valore Sup. -

Prefettura Di Vibo Valentia
Prefettura di Vibo Valentia ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA STAMPA GENERICA DATA DATA DATA RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE SEDE SECONDARIA CFIS-PIVA SEZIONE STATO RICHIESTA ISCRIZIONE SCADENZA 2C IMPIANTI DI SUPPA COSTANTINO SAN COSTANTINO CALABRO SPPCTN77P10F537W 7 18/10/2018 02/04/2019 01/04/2020 ISCRITTA 2C IMPIANTI DI SUPPA COSTANTINO SAN COSTANTINO CALABRO 02292480791 5,7 02/04/2020 ISTRUTTORIA 3M CARBURANTI S.R.L. SEMPLIFICATA ARENA 03548350796 1,2,3,4,5,7,8 16/04/2019 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA 4R S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE VIBO VALENTIA FRAZ. PORTOSALVO 03318600792 2,5,7 RESPINTA A.G.A.R. S.R.L. VIBO VALENTIA PONTEDERA (PI) 00277080792 8 24/04/2018 27/03/2019 26/03/2020 SCADUTA ABIES ALBA S.R.L.S SERRA SAN BRUNO 03407380793 5 10/07/2015 RESPINTA ADDESI PASQUALE GEROCARNE 02225890793 6 12/12/2019 ISTRUTTORIA ADR EDILIZIA S.R.L. SEMPLIFICATA VIBO VALENTIA 03409320797 1,2,3,4,5,6,7,8 22/09/2016 AGGIORNAMENTO IN CORSO AGMF S.R.L.S. NICOTERA 03668820792 1,9 23/12/2019 ISTRUTTORIA ALFA POZZI DI CALAFATI ALFREDO CESSANITI 02760210795 3, 5, 7 23/06/2016 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA ALGECO EDILIZIA SOC. COOP A R L. SAN CALOGERO 02849660796 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 11/02/2019 ISTRUTTORIA ANELLO FRANCESCO ANTONIO FILADELFIA NLLFNC89E21M208H 7 19/09/2018 RESPINTA RCLNCL66C29F537A - ARCELLA NICOLA STEFANACONI 5,7 26/02/2019 23/12/2019 22/12/2020 ISCRITTA 02176230791 ARCELLA ROSARIO SANT'ONOFRIO RCLRSR68E21F537C 3 26/10/2015 19/02/2016 18/02/2017 SCADUTA (*) Iscrizione per effetto del decreto del Tribunale di Catanzaro che ha disposto ammissione della societa alla misura di controllo giudiziario di cui all art. -

COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 Amending Regulation (EC) No 2138/97 Delimiting the Homogenous Olive Oil Production Zones
L 278/10EN Official Journal of the European Communities 16.10.2002 COMMISSION REGULATION (EC) No 1836/2002 of 15 October 2002 amending Regulation (EC) No 2138/97 delimiting the homogenous olive oil production zones THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, HAS ADOPTED THIS REGULATION: Having regard to the Treaty establishing the European Community, Article 1 Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 The Annex to Regulation (EC) No 2138/97 is amended as September 1966 on the common organisation of the market in follows: oils and fats (1), as last amended by Regulation (EC) No 1513/ 2001 (2), 1. in Point A, the provinces ‘Brescia’, ‘Roma’, ‘Caserta’, ‘Lecce’, ‘Potenza’, ‘Cosenza’, ‘Reggio Calabria’, ‘Vibo Valentia’, ‘Sira- Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261/84 of 17 cusa’ and ‘Sassari’ are replaced in accordance with the Annex July 1984 laying down general rules on the granting of aid for to this Regulation; the production of olive oil and of aid to olive oil producer orga- nisations (3), as last amended by Regulation (EC) No 1639/ 2. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: Anda- 98 (4), and in particular Article 19 thereof, lucía’, ‘Genalguacil’ is added to zone 4 (‘Serranía de Ronda’) in the province ‘Málaga’. Whereas: (1) Article 18 of Regulation (EEC) No 2261/84 stipulates 3. in Point D, under the heading ‘Comunidad autónoma: that olive yields and oil yields are to be fixed by homoge- Aragón’: nous production zones on the basis of the figures — ‘Ruesca’ is added to zone 2 in the province ‘Zaragoza’, supplied by producer Member States. -

Prefettura Di Vibo Valentia
Prefettura di Vibo Valentia ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA STAMPA GENERICA DATA DATA DATA RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE SEDE SECONDARIA CFIS-PIVA SEZIONE STATO RICHIESTA ISCRIZIONE SCADENZA 2C IMPIANTI DI SUPPA COSTANTINO SAN COSTANTINO CALABRO 02292480791 5,7 02/04/2020 ISTRUTTORIA 3M CARBURANTI S.R.L. SEMPLIFICATA ARENA 03548350796 1,2,3,4,5,7,8 16/04/2019 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA 4R S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE VIBO VALENTIA FRAZ. PORTOSALVO 03318600792 2,5,7 RESPINTA A.G.A.R. S.R.L. VIBO VALENTIA PONTEDERA (PI) 00277080792 8 24/04/2018 27/03/2019 26/03/2020 SCADUTA ABIES ALBA S.R.L.S SERRA SAN BRUNO 03407380793 5 10/07/2015 RESPINTA ADDESI PASQUALE GEROCARNE 02225890793 6 12/12/2019 ISTRUTTORIA ADR EDILIZIA S.R.L. SEMPLIFICATA VIBO VALENTIA 03409320797 1,2,3,4,5,6,7,8 22/09/2016 AGGIORNAMENTO IN CORSO AGMF S.R.L.S. NICOTERA 03668820792 1,9 23/12/2019 ISTRUTTORIA ALFA POZZI DI CALAFATI ALFREDO CESSANITI 02760210795 3, 5, 7 23/06/2016 17/12/2019 16/12/2020 ISCRITTA ALGECO EDILIZIA SOC. COOP A R L. SAN CALOGERO 02849660796 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 11/02/2019 ISTRUTTORIA ANELLO FRANCESCO ANTONIO FILADELFIA NLLFNC89E21M208H 7 19/09/2018 RESPINTA RCLNCL66C29F537A - ARCELLA NICOLA STEFANACONI 5,7 26/02/2019 23/12/2019 22/12/2020 ISCRITTA 02176230791 ARCELLA ROSARIO SANT'ONOFRIO RCLRSR68E21F537C 3 26/10/2015 19/02/2016 18/02/2017 SCADUTA RNAMHL65C04H516C - ARENA MICHELE ROMBIOLO 5 09/05/2019 ISTRUTTORIA 02947960791 (*) Iscrizione per effetto del decreto del Tribunale di Catanzaro che ha disposto ammissione della societa alla misura di controllo giudiziario di cui all art. -

H I.C. Limbadi H12,30+12,30Eh Ic Nicotera Eh 16/09/1965 Vv Comune Spilinga Sost
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I I I I I I I I DATI ANAGRAFICI I DATI DI TITOLARITA' I PUNTEGGI I PRECED.ITIPO I SEDE DI ASSEGANZIONE PROVVISORIA I I I (SCUOLA E TIPO POSTO) IRICONG. ALTRI CURE I IPOSTOI I I I I I I I I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. GRECO MARIA GIOVANNA VVAA83500B-ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONG 15,00 9,00 0,00 ** N I.C.I CIRCOLO VIBO VALENTIA 19/04/1970 VV COMUNE MAIERATO 2. CUGLIARI ANGELA VVAA807007-ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIA 6,00 0,00 0,00 ** N I.C. A. VESPUCCI 01/02/1957 VV S.ONOFRIO COMUNE 3. ARRUZZA LIBERATA VVAA83500B-ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONG 12,00 6,00 0,00 ** H,N I.C. TROPEA EH 02/06/1969 VV RICADI COMUNE 4. GRASSO GIUSEPPINA VVAA81800N-IST COMPRENSIVO DI CESSANITI 17,00 11,00 0,00 ** N NO SEDI 29/06/1978 VV PARGHELIA COMUNE 5. RIZZO MARIA FRANCESCA VVAA82600L-I.C. "AMERIGO VESPUCCI" 14,00 8,00 0,00 ** N NO SEDI 12/03/1971 VV TROPEA COMUNE 6. ROSSI MARIA-CONCETTA VVAA823005-ISTITUTO COMPRENSIVO BRIATICO 14,00 8,00 0,00 ** N NO SEDI 11/10/1978 VV VIBO VALENTIA COMUNE 7. PRESTIA LAMBERTI MARIA ANTONELLA VVAA829004-ISTITUTO COMPRENSIVO FILADELFI 14,00 8,00 0,00 ** N NO SEDI 06/06/1983 MI RICADI COMUNE 8. MAZZITELLO ANNA VVAA829004-ISTITUTO COMPRENSIVO FILADELFI 10,00 4,00 0,00 ** N I.C. NICOTERA 01/10/1979 RC NICOTERA COMUNE 9. MURACA FRANCESCA DANIELA VVAA807007-ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIZIA 15,00 9,00 0,00 N I.C. FILADELFIA 09/02/1964 CZ PIZZO COMUNE 10. -

C333 Official Journal
Official Journal C 333 of the European Union Volume 62 English edition Information and Notices 4 October 2019 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2019/C 333/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9528 — Macquarie Infrastructure and Real Assets/ Currenta) (1) . 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2019/C 333/02 Euro exchange rates . 2 2019/C 333/03 Commission notice concerning the application of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin or the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation between the Contracting Parties to this Convention . 3 V Announcements ADMINISTRATIVE PROCEDURES European Commission 2019/C 333/04 CALL FOR PROPOSALS — EACEA/45/2019 Erasmus+ Programme, Key Action 3 — Support for Policy Reform Civil Society Cooperation in the field of Youth . 11 EN (1) Text with EEA relevance. PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2019/C 333/05 Notice concerning the anti-dumping measures in force in respect of imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China: name change of one company subject to the duty for cooperating non-sampled companies . 15 PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2019/C 333/06 Prior notification of a concentration (Case M.9575 — Renault/Mobivia/Exadis) Candidate case for simplified procedure (1) . 16 2019/C 333/07 Prior notification of a concentration (Case M.9358 — Broadcom/Symantec Enterprise Security Business) Candidate case for simplified procedure (1) . -

Acquaro, Dasà, Arena, Dinami E Gerocarne in Ginocchio Dopo Il
SABATO 8 novembre 2008 PAGINA 30 ora Telefono:l’ 0963.547589 - 45605 Fax: 0963.541775di Mail: [email protected] - [email protected] FORZE DELL’ORDINE EMERGENZE FARMACIE CINEMA Capitaneria di Porto 0963.573911 Suem 118 Ariganello 0963.596494 MODERNO via Enrico Gagliardi 0963.41173 Carabinieri 0963.592404 Ospedale 0963.962111 Buccarelli 0963.592402 Corpo forestale dello Stato 0963.311026 Pronto soccorso 0963.962235 Centrale 0963.42042 HIGH SCHOOL MUSICAL 3 (sala grande) Guardia di finanza 0963.572082 Guardia medica 0963.41774 David 0963.263124 ORE 16.00 - 17.50 - 21.30 Polizia municipale 0963.599606 Consultorio familiare 0963.41014-472105 Depino 0963.42183 Polizia provinciale 0963.997111 Croce Rossa Italiana 0963.472352 Iorfida 0963.572581 L’UOMO CHE AMA (sala A) Prefettura-Questura 0963.965111 Mimmo Polistena Onlus 0963.94420 Marcellini 0963.572034 ORE 17.00 - 19.15 - 21.30 Vigili del fuoco 0963.9969100 Guardia costiera 0963.573911 Montoro 0963.41551 GIU’ AL NORD (sala B) Soccorso stradale Aci 0963.262263 ORE 17.00 - 19.50 - 21.30 La nuova alluvione In quattro ore, 145 millimetri d’acqua hanno devastato parte della zona premontana del Vibonese. I danni sono ingenti e i disagi per la popolazione IL DISASTRO evidenti.Acquaro è il centro con maggiori difficoltà nell’entroterra La Provincia Il presidente De Nisi chiede I gravi danni riscontrati nei un intervento del Governo centri di Acquaro, Dasà, Are- affinché dichiari lo «stato di na, Dinami e Gerocarne, in se- calamità naturale» e adotti guito al devastante nubifragio le misure idonee per verificatosi nella serata di riportare nel più breve mercoledì scorso, hanno in- tempo lo stato di normalità dotto il presidente della giun- ta provinciale Francesco De Nisi a sollecitare il governo centrale affinché, dichiarando La Regione lo «stato di calamità», adotti Sollecitata dal presidente del misure straordinarie per assi- consiglio provinciale Barilaro curare il ritorno alla normali- assicura un impegno diretto tà nelle aree disastrate. -

07 Mod. Curriculum Europeo
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome GIUSEPPE GRILLO Indirizzo Studio: Via G. Genovese, 6/8 Fr. Mesiano – 89841 FILANDARI (VV) Res.Anagr.:Via A. Manzoni, 22-24 - Fr. Mesiano – 89851 FILANDARI (VV) Telefono 0963/365544-361000-1940417; 333/4837054;388/9961676 Fax 0963/365544 E-mail [email protected]; [email protected]; [email protected] Sito Web www.centrogrillo.com Nazionalità ITALIANA Data e luogo di nascita 01/05/53 – San Calogero (VV) ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (da – a) 01/10/1976 • Nome e indirizzo del datore di Ministero Pubblica Istruzione - Roma lavoro • Tipo di azienda o settore Scuole Pubbliche • Tipo di impiego Docente di ruolo a tempo indeterminato • Principali mansioni e responsabilità Insegnante Titolare; Docente Informatica Didattica; Docente Corsi Formazione. ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date (da – a) 01/07/72; 01/04/80; 1990-2000; 2008; 2009; 2011; 2012; 2014. • Nome e tipo di istituto di istruzione - Maturità Magistrale; o formazione - Laurea in Materie Letterarie (indirizzo sociologico); - Corsi formazione/perfezionamento in materie economiche, informatiche, aziendali, fiscali e gestionali. - Corsi studi in Giurisprudenza. • Principali materie / abilità Docente materie scientifiche; Operatore Tecnologico (informatica applicata alla didattica); professionali oggetto dello studio Esperto in gestioni aziendali, lavoristiche, amministrative, contabili e fiscali. • Qualifiche conseguite Docente; Tributarista; Consulente del Lavoro abilitato; Mediatore Creditizio; Mediatore Civile. • Livello nella classificazione // nazionale (se pertinente) Pagina 1 - Curriculum vitae di Giuseppe GRILLO CAPACITÀ E COMPETENZE 1. Studente lavoratore all’estero (Svizzera, Germania, Austria) in vari PERSONALI settori industriali e commerciali con Contratti di Formazione a tempo Acquisite nel corso della vita e della determinato; carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 2. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

Avvisobando100disoccupati.Pdf
Parco Naturale Regionale delle Serre Prot. 393 SELEZIONE DI 100 SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PROGETTO "POLITICHE ATTIVE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE" Comunicazione ammissione candidati Si comunica che la Commissione ha verificato l’ammissibilità delle domande presentate ai sensi del bando in oggetto, i cui elenchi si allegano alla presente e saranno pubblicati sull’albo on line e sul profilo istituzionale dell’Ente. I soggetti interessati potranno proporre ricorsi e/o osservazioni entro 15 giorni dalla pubblicazione. Serra San Bruno 22/02/2019 Il Responsabile del Procedimento f.to Francesco Maria Pititto Via Santa Rosellina n. 2– 89822 Serra San Bruno (VV) – Tel/ Fax 0963/772825 SELEZIONE DI 100 SOGGETTI DISOCCUPATI/INOCCUPATI RESIDENTI NEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE DA INSERIRE IN UN PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL PROGETTO "POLITICHE ATTIVE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELL'AREA PROTETTA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE" ELENCO AMMESSI PROFILO 1 N. Data di Comune di Cognome Nome ord. nascita Residenza 1 Procopio Chiara 19/06/1996 Serra San Bruno 2 Pagano Grazia 17/06/1977 Serra San Bruno 3 Gullello Manuela 10/09/1978 Serra San Bruno 4 Tassone Nicoletta 29/09/1979 Serra San Bruno 5 Daniele Brunella 26/06/1999 Fabrizia 6 Pupo Andrea 09/07/1998 Serra San Bruno 7 Pupu Biagio Giuseppe 03/02/1975 Serra San Bruno 8 Tassone Francesco -

Liceo Statale “Vito Capialbi” Vibo Valentia ------SCUOLA CAPOFILA AMBITO CAL0012 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO CAL0012
LICEO STATALE "VITO CAPIALBI" VITO CAPIALBI - C.F. 96012940795 C.M. VVPM01000T - VVPM_01000T - PROTOCOLLO Prot. 0003168/U del 28/03/2020 19:38:08 Liceo Statale “Vito Capialbi” Vibo Valentia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCUOLA CAPOFILA AMBITO CAL0012 SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO CAL0012 A tutte le scuole dell’Ambito CAL0012 e, p.c. All’USR Calabria – Ufficio 2 All’ATP di Vibo Valentia Oggetto: Corso di formazione docenti neoassunti a.s. 2019/20 Ambito CAL0012. Nuove modalità di svolgimento e calendario laboratori. In considerazione della particolare situazione dovuta alla pandemia in atto, il MI ha diffuso la nota n.7304 del 27 marzo u.s. con la quale comunica, tra l’altro, indicazioni per l’organizzazione dei corsi di formazione per i docenti neoassunti, che si dovranno svolgere esclusivamente in modalità e-learning. Seguendo le indicazioni ministeriali abbiamo organizzato i laboratori formativi, uguali per tutti i docenti (compresi coloro che avevano optato per le attività di visiting in scuole innovative), in modalità e-learning su piattaforma Google Meet. Gli incontri si svolgeranno secondo il calendario allegato. I docenti neoassunti troveranno informazioni operative nell’area dedicata del nostro sito https://www.istitutocapialbi.edu.it/ . I dirigenti scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di notificare quanto sopra a tutti i docenti interessati, come da allegato elenco. Allegati: - Calendario laboratori formativi; - Elenco docenti neoassunti Ambito CAL0012. Vibo Valentia, 28/03/2020 Il Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) ________________________________________________________________________________________________________________________________ Via S. Ruba 29 * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T 096393450 Cod. -

CURRICULUM VITAE TITOLI PROFESSIONALI - CAPACITÀ E QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DATI GENERALI
prof. arch. Domenico Santoro DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 del DPR 28/12/200 n° 445) Il sottoscritto arch. Domenico Santoro, nato a Vibo Valentia (Vv) il 22/09/1955 e residente in Vibo Valentia in via Accademie vibonese IV trav. N. 1 con studio professionale in Vibo Valentia in via Fontana Vecchia n. 43, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000 dichiaro che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità.. Dichiara quanto segue CURRICULUM VITAE TITOLI PROFESSIONALI - CAPACITÀ e QUALITÀ TECNICO-PROFESSIONALI DATI GENERALI PROFESSIONISTA (nome e cognome) Prof. Arch. Domenico Santoro ISCRIZIONE ORDINE Ordine Architetti Provincia di Vibo Valentia numero e anno di iscrizione numero: 38 anno:1981 Prof. Arch. Domenico Santoro: C.F SNTDNC55P22F537A P.I. 01258330792 Sintesi: - Vibo Valentia, 22.09.55; - Laurea Architettura 1981 (110/110 lode); - Iscritto all’Albo degli Architetti-Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vibo Valentia al n°38 - Dottore in ricerca in Pianificazione Territoriale presso l'Univ. di Reggio Calabria (1995); - Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Capialbi di Vibo Valentia (autorizzato alla libera Professione); - Professore di Sicurezza Urbana presso l’Istituto di Criminologia (Vv); - Già Docente di Comunicazione Pubblicitaria; - Coach per la Tecnologia della didattica scolastica; - Frequenza Master in Economics presso la Northeastern di Boston (U.S.A.1993-94).