Filiera Eco-Alimentare
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
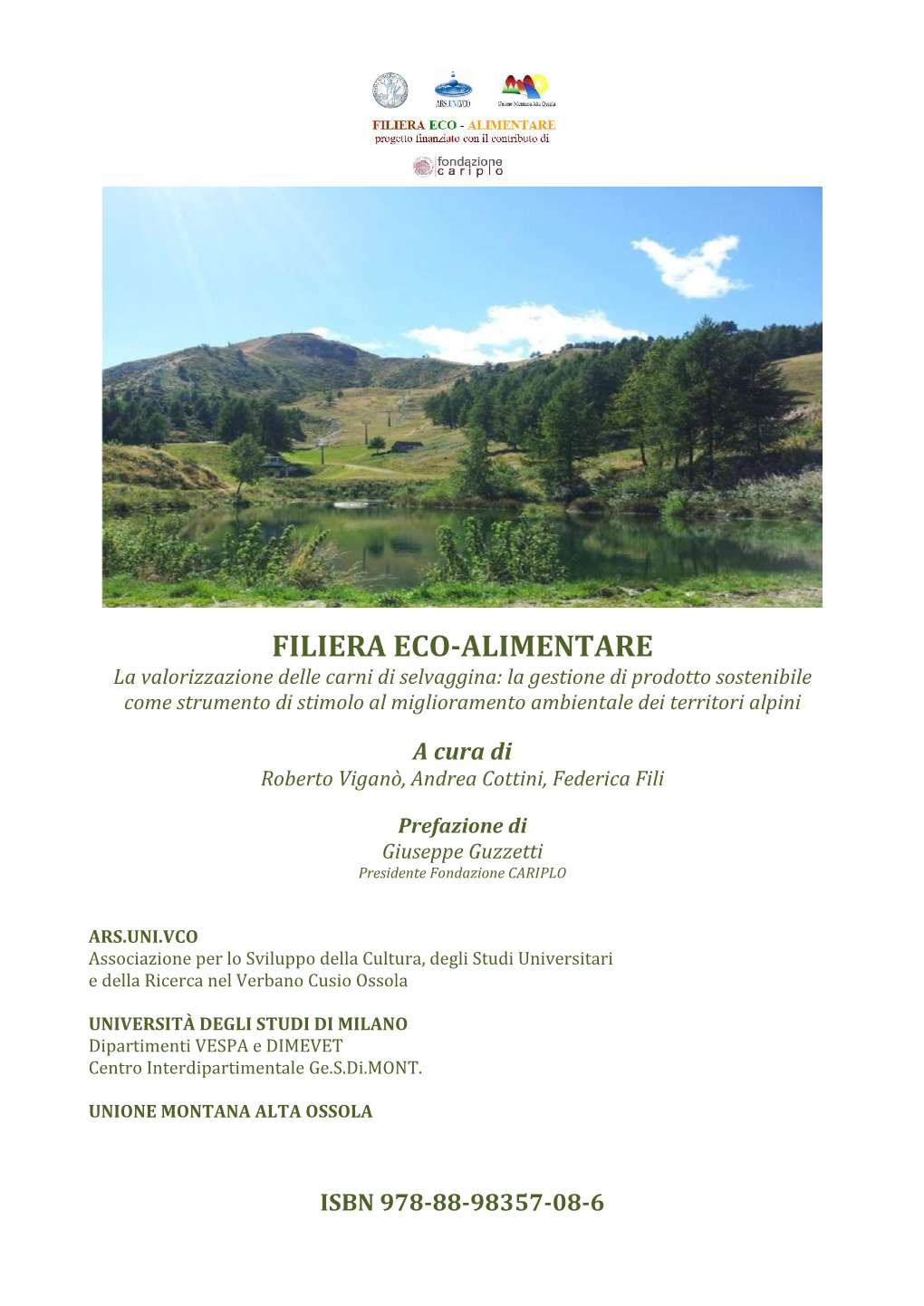
Load more
Recommended publications
-
Riale Formazza: FINISH; Refreshment Drinks and Food; First Aid
10th july 2021 OFFICIAL GUIDE INSTITUTIONS Comune di Formazza Comune di premia UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA SPONSOR PARTNERSHIP Timing Service A land to live The area where BUT will take place, Valle Formazza, it offers beautiful landscapes and mountains, rich of tracks from the 1.000 m to the lakes and the majestic mountains of High Valle Formazza. Also the relax and wellness is part of the territory thanks to the thermal water of Premia Terme, in the near Valle Antigorio. A RECORD WATERFALL The major attraction is surely the stunning Cascata del Toce, a waterfall with a jump of 143 m, the highest in Europe. The same region of Antigorio and Formazza, with it´s cros- sing places to Switzerland has represented for years really important commercial ways. During the past years was the principal access to Europe and is rich of history and cultu- re; this area tells the adventure of people, the Walser, who were able to conquer the Alps.The land also offers high qua- lity products as the Bettelmatt Cheese, which is made only here. ALL THE SPORT YOU WANT The sport is a big player in these territory: during the summer you can go cycling, mtb and downhill, trail and trekking as well as Nordic walking and canyoning; while during the winter everything is snow oriented: alpine and cross country ski, ski mountaineering. Cascata del Toce Terme di Premia - reopening soon 56kbettelmatt trail An adrenaline-pumping experience, in a territorial context that has few rivals: Bettelmatt Trail has an extremely spectacular route, built entirely within the Val Formazza. -

Popolazione Comuni Della Provincia Del Verbano Cusio Ossola Popolazione Residente Nella Provincia Del Verbano Cusio Ossola
POPOLAZIONE COMUNI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA n. Comune Residenti Den. Kmq n° Famiglie n. Comune Residenti Den. Kmq n° Famiglie 1 ANTRONA SCHIERANCO 482 4,8 231 41 MALESCO 1.478 34,2 694 2 ANZOLA D'OSSOLA 458 33,1 209 42 MASERA 1.521 75,7 651 3 ARIZZANO 2.080 1.276,10 899 43 MASSIOLA 143 17,8 74 4 AROLA 269 41,3 110 44 MERGOZZO 2.167 79,2 981 5 AURANO 112 5,3 72 45 MIAZZINA 418 19,5 214 6 BACENO 928 13,5 431 46 MONTECRESTESE 1.241 14,3 540 7 BANNIO ANZINO 524 13,4 238 47 MONTESCHENO 437 19,4 213 8 BAVENO 4.966 287,9 2.455 48 NONIO 898 88,5 334 9 BEE 722 220,1 364 49 OGGEBBIO 889 44 448 10 BELGIRATE 554 66 294 50 OMEGNA 15.991 519,2 7.036 11 BEURA-CARDEZZA 1.425 49,3 590 51 ORNAVASSO 3.419 132,2 1.508 12 BOGNANCO 245 4,2 151 52 PALLANZENO 1.177 266,3 513 13 BROVELLO-CARPUGNINO 689 82,6 345 53 PIEDIMULERA 1.606 210,8 733 14 CALASCA-CASTIGLIONE 699 12,1 338 54 PIEVE VERGONTE 2.682 64,3 1.157 15 CAMBIASCA 1.636 415,2 704 55 PREMENO 773 104 407 16 CANNERO RIVIERA 1.017 70,3 499 56 PREMIA 582 6,5 279 17 CANNOBIO 5.181 101,2 2.406 57 PREMOSELLO-CHIOVENDA 2.052 60,2 914 18 CAPREZZO 171 23,6 88 58 QUARNA SOPRA 283 29,8 144 19 CASALE CORTE CERRO 3.473 287,5 1.418 59 QUARNA SOTTO 430 26,8 208 20 CAVAGLIO-SPOCCIA 271 14,9 132 60 RE 765 28,1 333 21 CEPPO MORELLI 347 8,7 180 61 SAN BERNARDINO VERBANO 1.380 53,1 581 22 CESARA 595 52,8 274 62 SANTA MARIA MAGGIORE 1.271 23,9 614 23 COSSOGNO 595 14,9 294 63 SEPPIANA 159 27,8 86 24 CRAVEGGIA 754 20,7 362 64 STRESA 5.226 157,3 2.617 -

Valle Antigorio – Òrridi Di Uriezzo (2 Tage)
Valle Antigorio – Òrridi di Uriezzo (2 Tage) Entdecke das wilde Valle Antigorio mit seinen riesigen Gletschertöpfen, den rauschenden Wasserfällen, den romantischen Saumpfaden, seinen eindrücklichen Trockenmauern, Steindächern, Steinbrüchen... Wir wandern in freier Natur, geniessen köstliche lokale Speisen in auserlesenen Ristoranti und übernachten im komfortablen Albergo Edelweiss mit Spa-Bereich! Unsere Leistungen: • Busfahrt vom Bahnhof Domodossola nach Crevoladossola • kurzer Spaziergang von der Bushaltestelle zum Antico Torchio • Besuch des Antico Torchio (antike Weinpresse) – anschliessend italienisches Aperitivo • geführte Wanderung auf dem Saumweg der historischen Sbrinz-Route von Crevoladossola nach Oira • Mittagessen im Restaurant «C'era una Volta…» mit Primo, Secondo (Fleisch/Fisch), Dolce – inkl. Wein, Mineralwasser, Kaffee • Besuch der antiken Mühle, der Käserei und der «Cantina ossolana», wo die Weine des Ossola gekeltert werden • geführte Wanderung entlang des Flusses «Toce» von Oira nach Pontemaglio mit der Möglichkeit, sich im klaren Wasser zu erfrischen! • Busfahrt von Pontemaglio nach Viceno • Einchecken im ***Albergo Edelweiss – ausreichend Zeit, die Hotel eigene Wellness- Anlage zu benutzen oder die Ausstellung «Leben im 19. Jh.» zu besuchen • Abendessen: 4-Gang-Menu im Saal des Ristorante Edelweiss • Übernachtung im ***Albergo Edelweiss, im Doppelzimmer • reichhaltiges Frühstück im ***Albergo Edelweiss • Busfahrt von Viceno nach Baceno, wo wir die reich geschmückte «Chiesa di San Gaudenzio» hauptsächlich aus dem 12./13. Jahrhundert besuchen • geführte Wanderung von Baceno durch die «Orridi di Uriezzo» (mächtige eiszeitliche Gletschertöpfe) – unterwegs ein italienisches Aperitivo Armin Borner, Wanderleiter mit eidg. Fachausweis (© Geniesserwandern mit Armin, Angebot 2018) Bobma 19, 3903 Mund VS 027 923 38 49 076 525 38 49 [email protected] • geführte Wanderung über den «Toce» und hinauf nach Crego (220 Höhenmeter Aufstieg – ca. -

Gli Orridi Insieme Alle Cascate, Gli Orridi, Sono Sicuramente La Forma
Gli Orridi Insieme alle cascate, gli orridi, sono sicuramente la forma più spettacolare di paesaggio che si è creata nel tempo ad opera dell'acqua. Si tratta di un fenomeno che risale all'epoca dell'ultima grande glaciazione che ha avuto termine circa 8300 anni fa, quando l'intera valle percorsa ora dal fiume Toce, era totalmente ricoperta da un ghiacciaio che arrivava ad uno spessore di oltre 1000 metri. Nell'ultimo milione di anni le Alpi sono state interessate da 4 glaciazioni, cioè periodi di forte espansione dei ghiacci. L'ultima di esse, chiamata “ glaciazione Wurmiana”, è durata da 75.000 a 8.300 anni fa. In valle Antigorio sono numerose le traccie dell'azione glaciale, in particolare nella zona che circonda le forre di Baceno e Premia, che sono caratterizzate da formazioni naturali come le marmitte e gli orridi. La forra è una incisione molto profonda frutto della esarazione glaciale, cioè dall'azione erosiva e abrasiva esercitata sulle rocce dalla massa di ghiaccio in movimento. Le marmitte, chiamate anche “marmitte dei giganti” sono delle grandi cavità prodotte nella roccia dal moto vorticoso delle acque di un torrente o dai sassi trasportati da un ghiacciaio; l'orrido è un precipizio o canalone dalle pareti aspre ed irte anch'esso originato dalla azione erosiva di un torrente o di un ghiacciaio. In genere le marmitte sono luoghi più aperti, più larghi e meno incassati. Marmitte di Maiesso SMS Ranzoni 1 In questa zona la presenza glaciale era sicuramente fra le più importanti di tutta la regione ossolana. Attualmente nella parte più alta del territorio, che prende il nome di Valle Formazza, rimangono, anche se in continuo e preoccupante regresso, i ghiacciai dell'Arbola, dell'Hosand e del Gries, gli ultimi superstiti di un'era di enormi mutamenti geologici. -

Tectonics of the Lepontine Alps: Ductile Thrusting and Folding in the Deepest Tectonic Levels of the Central Alps
Swiss J Geosci (2013) 106:427–450 DOI 10.1007/s00015-013-0135-7 Tectonics of the Lepontine Alps: ductile thrusting and folding in the deepest tectonic levels of the Central Alps Albrecht Steck • Franco Della Torre • Franz Keller • Hans-Rudolf Pfeifer • Johannes Hunziker • Henri Masson Received: 9 October 2012 / Accepted: 29 May 2013 / Published online: 17 July 2013 Ó Swiss Geological Society 2013 Abstract The Lepontine dome represents a unique region Adriatic indenter. The transverse folding F4 was followed in the arc of the Central and Western Alps, where complex since 30 Ma by the pull-apart exhumation and erosion of the fold structures of upper amphibolite facies grade of the Lepontine dome. This occurred coevally with the formation deepest stage of the orogenic belt are exposed in a tectonic of the dextral ductile Simplon shear zone, the S-verging half-window. The NW-verging Mont Blanc, Aar und Gott- backfolding F5 and the formation of the southern steep belt. hard basement folds and the Lower Penninic gneiss nappes of Exhumation continued after 18 Ma with movement on the the Central Alps were formed by ductile detachment of the brittle Rhone-Simplon detachment, accompanied by the N-, upper European crust during its Late Eocene–Early Oligo- NW- and W-directed Helvetic and Dauphine´ thrusts. The cene SE-directed underthrust below the upper Penninic and dextral shear is dated by the 29–25 Ma crustal-derived aplite Austroalpine thrusts and the Adriatic plate. Four underthrust and pegmatite intrusions in the southern steep belt. The zones are distinguished in the NW-verging stack of Alpine cooling by uplift and erosion of the Tertiary migmatites of the fold nappes and thrusts: the Canavese, Piemont, Valais and Bellinzona region occurred between 22 and 18 Ma followed Adula zones. -

14-Sandrone Et Al
Per. Mineral. (2004), 73, 211-226 http://go.to/permin SPECIAL ISSUE 3: A showcase of the Italian research in applied petrology An International Journal of MINERALOGY, CRYSTALLOGRAPHY, GEOCHEMISTRY, ORE DEPOSITS, PETROLOGY, VOLCANOLOGY and applied topics on Environment, Archaeometry and Cultural Heritage Contemporary natural stones from the Italian western Alps (Piedmont and Aosta Valley Regions) RICCARDO SANDRONE1*, ANNITA COLOMBO2, LAURA FIORA3, MAURO FORNARO4, ENRICO LOVERA1, ANNALISA TUNESI2 and ALESSANDRO CAVALLO5 1 Dip. Georisorse e Territorio, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy 2 Dip. Scienze Geologiche e Geotecnologie, Università di Milano-Bicocca, Piazza della Scienza 4, 20126 Milano, Italy 3 Dip. Scienze Mineralogiche e Petrologiche, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy 4 Dip. Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso 35, 10125 Torino, Italy 5 Dip. Scienze della Terra “Ardito Desio”, Università degli Studi di Milano, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italy ABSTRACT. — At present about 60 different INTRODUCTION kinds of stones are quarried in the Italian Western Alps, most of which are metamorphic In the Italian Western Alps a great deal of rocks (gneiss, ophicalcite, marble and quartzite) and, to a lesser extent, magmatic (granite, syenite different varieties of stones were quarried in . and diorite), with an overall production of 380 000 the past and can be considered historical stones m3 in the year 2002. This work synthetically because of their diffusion or use in monumental illustrates their geologic and petrographic works (see, for example, Barelli, 1835; Jervis, characteristics, gives essential historical information 1889; Salmoiraghi, 1892; Blangino, 1895; and examines the technical, environmental and economic aspects of their extraction and Sacco, 1907; Peretti, 1938). -

Val Formazza
Val Formazza Accesso con autostrada a pagamento fino ad Arona, poi superstrada fino a Gravellona Toce e poi via per Crodo in valle Antigorio, che diventa Val Formazza dopo il gradino di Premia. Qui una serie di tornanti, che richiedono attenzione – ma, tranquilli, ci passano i bus (affiancati da un tunnel pronto da anni ma mai inaugurato, sembra a causa di un grave errore di progettazione dovuto al fatto che il suo ingresso alto si trova a livello del torrente che lo affianca e quindi pericoloso in caso di esondazione!) - ci portano sulla piana di Pomatt, nome walser di questo cuneo d’Italia che si insinua nella Svizzera. Qui sosta e visita del paesino di Antillone e spesa di latticini, compreso latte appena munto, alla locale latteria. Si continua attraversando varie frazioni e si arriva alla famosa cascata del fiume Toce alta ben 143 metri. Cascata del Toce Dopo le foto di rito e, perché no, una passeggiata sul sentierino che costeggia la cascata e che vi rinfrescherà con i suoi spruzzi, si continua fino a Riale, splendido paesino isolato a 1800 metri slm, dove in inverno si praticano sci di fondo, sci alpinismo o escursionismo con ciaspole. www.camperonline.it Riale Voltando a sinistra verso la diga di Morasco, si arriva al pianoro dove è consentita la sosta camper. Morasco Da qui, per gli escursionisti esistono varie possibilità. Ne cito alcune: salita ai rifugi Città di Busto, Somma Lombardo e 3 A (quest’ultimo gestito dai ragazzi dell’organizzazione Mato Grosso), visita al ghiacciaio della Punta d’Arbola, salita al passo del Gries con l’omonimo ghiacciaio che mette in comunicazione con la Svizzera e con la valle che dà origine al fiume Ticino, Rifugio Maria Luisa. -

And Surrounding Mountains Sales Guide 2016
Lake Ma GGiore and SurroundinG MountainS Sales Guide 2016 . 2017 Sales Guide Highlights Quick Guide 2016 / 2017 Contents BORROMEO ISLANDS Central Lago incontrovertibly the heart of Lago Maggiore and a place of art “par excellence”: isola Bella, isola Madre and isola dei Pescatori. Situated in the Gulf of Borromeo, all three of them have fascinated people throughout history: with the art and culture of a great ruling dynasty: the General information 4 Borromeo family. there are so many attractions for the visitor to wonder at: grandiose ter- Map raced gardens with palazzo, an authentic fishing village with picturesque houses, one of the most spectacular botanic gardens anywhere in the world with many exotic plants – and so Travel information Isola dei Pescatori much more. Taxiboats, Shipyards and Boat Rental Services Coach Rental Services VILLA TARANTO Verbania-Pallanza Golf Courses a villa built in the 1830s by a Scot, Captain neil Mceacharn, and in the meantime one of the richest botanical gardens in the world. With thousands of plant species – eucalyptus, azalea, Events rhododendron, magnolia, maple, camellia and dahlia, it stretches over an area measuring 16 hectares. upper Lago 9 PARcO NAzIONALE VAL GRANDE Ossola Valleys Central Lago 13 this national park situated between the Val d’ossola, the Val Vigezzo and Lago Maggiore the Gardens of Villa Taranto measures 15,000 hectars and is noted as the largest integrated natural wild reserve in italy; Lower Lago 19 here nature has been preserved in all its primal wildness. east Shore and Varese 22 ISOLA DI S. GIuLIO Lake Orta Legend has it that S. -

Le Acque Sorgive Della Valle Antigorio. Passato E Futuro Dello Sfruttamento Termale
GIGLIOLA ONORATO LE ACQUE SORGIVE DELLA VALLE ANTIGORIO. PASSATO E FUTURO DELLO SFRUTTAMENTO TERMALE La Valle Antigorio. Contesto geografico La Valle Antigorio è una delle valli dell’Ossola, e precisamente quella che da Domodossola risale verso nord, seguendo il corso del fiume Toce fino alle sue sorgenti, ubicate nei pressi del Passo di San Giacomo (2313 m), al confine con la Svizzera. Il complesso idrografico, con le valli con- fluenti, rappresenta la porzione più settentrionale del Piemonte, che appa- re simile ad un cuneo inserito tra i Cantoni elvetici del Vallese e del Ticino. In genere si parla unitamente della Valle Antigorio-Formazza in quanto, dal punto di vista fisico, non esiste una netta demarcazione tra le due en- tità geografiche, essendo l’una conseguente all’altra; tuttavia, è consuetudi- ne individuare presso l’abitato di Foppiano, in prossimità di un gradino roccioso denominato Le Casse, la linea di separazione tra le due valli, che pure si differenziano in relazione a diversi influssi culturali, in quanto la parte più a nord è stata area di colonizzazione dei Walser 1, mentre la bassa valle, proiettata verso la pianura lombarda, ha sempre avuto nel Milanese il proprio fulcro di gravitazione. Gli aspetti fisici che maggiormente si evidenziano sono l’imponente basamento gneissico 2, dal quale si stagliano le vette, e l’impronta glacio- 1 Fin dal XIII secolo si stanziarono in Val Formazza popolazioni Walser, originarie del Vallese, che mantennero, nei secoli, oltre ad una particolare autonomia amministrativa, la loro identità culturale. Anche ai nostri giorni, l’idioma (titsch), l’architettura degli edifici così come le tradizioni locali sono caratterizzate in modo inconfondibile, tanto da non la- sciare dubbi sulla loro origine. -

L'architettura Civile in Età Moderna in Valle Antigorio
L’architettura civile in età moderna in Valle Antigorio: elementi datanti Oggetto di uno studio cronotipologico pubblicato nel 1980 1, l’architettura tradizionale della valle Antigorio ha subito negli ultimi anni una preoccupante diminuzione di testimonianze a causa di pesanti interventi sugli edifici eseguiti in assenza di qualunque forma di tutela. Ne consegue l’impossibilità di definire con certezza i caratteri peculiari dell’architettura tipica precedente alla seconda metà del XVII secolo, momento in cui l’antropizzazione della valle sembra aver subito un deciso incremento, di cui si conservano ancora numerose testimonianze.In valle Antigorio non risultano conservati resti di architettura civile Figura 1 Portale di ingresso precedenti il XVI secolo 2 ad eccezione dell’antico castello meridionale al Castello di Crevoladossola (1419) della famiglia Della Silva di Crevoladossola, di cui gli edifici moderni hanno inglobato alcuni resti. Si tenga conto, tuttavia, che trattandosi di una dimora signorile potrebbe non essere esemplificativa delle tendenze architettoniche in atto nella valle nel corso del basso medioevo. Oggi sopravvivono una porta ad arco acuto (figura 1), che costituiva l’accesso meridionale al maniero, recante incisa la data 1419, ed una delle quattro torri quadrate del castello. Tracce superstiti dell’antico edificio sono anche alcune finestre archiacute, che testimoniano l’uso dell’arco acuto all’inizio del XIV secolo anche in ambito civile, dal momento che le poche testimonianze ossolane di questa formula architettonica si trovano nelle chiese. 1 Si veda MANNONI – MANNONI 1980. 2 Un caso tuttora problematico è costituito dalla torre di Cristo, Frazione di Premia, che come tutte le altre opere fortificatorie della Valle Antigorio attribuita alla committenza della famiglia De Rodis, feudataria della valle dal 1210 (cfr. -

Rapporto Sull'attività Di Monitoraggio Del Lupo Nella Provincia Del
RAPPORTO SULL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DEL LUPO NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA. INVERNO 2019-2020. Febbraio 2021 1 Foto di copertina: Il branco di lupi in valle Anzasca, ritratto da una fototrappola poche ore prima che venisse osservato dal sig. Vittone Maurizio predare un capriolo ad Isella di Macugnaga. Guida il gruppo l’esemplare con una evidente menomazione all’orecchio sinistro, più volte fotografato a partire dal 3 ottobre 2019. 2 Autori della relazione tecnica: Bionda R.1, Baldi A.2, Lux E.3, Maccagno R.4, Manoni F.4, Marini R.5, Movalli C.6, Avanzinelli E.7, Marucco F.7 1 Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola 2 Reparto Carabinieri Parco Nazionale Val Grande 3 Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore Tutela Faunistica 4 Corpo di Polizia Provinciale del Verbano Cusio Ossola 5 CAI Gruppo Grandi Carnivori 6 Parco Nazionale Val Grande 7 Centro di referenza regionale Grandi Carnivori Istituzioni che partecipano all’attuazione e valutazione del Monitoraggio del Lupo in VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola Reparto Carabinieri Parco Nazionale Val Grande Gruppo Carabinieri Forestale del Verbano Cusio Ossola Parco Nazionale Val Grande Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola Guardia di Finanza – Stazione S.A.G.F. di Domodossola CAI – Gruppo Grandi Carnivori Azienda faunistico venatoria Val Formazza Centro di referenza regionale Grandi Carnivori Istituzioni che partecipano all’attività divulgativa e informativa in VCO Provincia del Verbano Cusio Ossola Reparto Carabinieri Parco Nazionale Val Grande Gruppo Carabinieri Forestale del Verbano Cusio Ossola Parco Nazionale Val Grande Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola CAI – Gruppo Grandi Carnivori Centro di referenza regionale Grandi Carnivori 3 Ringraziamenti L’attività di monitoraggio della presenza del lupo è resa possibile grazie allo sforzo dei numerosi operatori. -

Studio Tecnico Belloni Geometra Massimo
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 Studio tecnico Belloni Geometra Massimo - Villadossola (Verbano Cusio Ossola) Comune di Baceno (Verbano Cusio Ossola) Determina responsabile ufficio tecnico n.87 del 08.5.2019- Regolarizzazione mediante acquisizione delle aree utilizzate per la realizzazione dell'edificio adibito a scuola media - Decreto espropriativo ex Art. 42-bis del D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.. Il giorno otto del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Nominato con Decreto del Sindaco n. 4 del 01/12/2017 Dato atto che con Deliberazione di Consiglio comunale n° 65 del 21/12/2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; Premesso: Che il Prefetto di Novara con decreto in data 01.10.1960 prot.n.36558/37757 Div.II ha approvato il progetto per la costruzione della Scuola Media Unica di Baceno; che tale progetto equivale, ai sensi di legge, a dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste; che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Baceno n.22 del 06.05.1971 si approvava la devoluzione di una somma a favore del Consorzio Scuola Media di Valle Antigorio e Formazza per provvedere all'acquisto dei terreni occupati per la realizzazione dell'edificio delle scuole medie del detto Consorzio; che in data 08.11.1971 il Comune di Baceno in qualità di capo consorzio della scuola media unica della Valle Antigorio e Formazza ha informato i proprietari dei terreni interessati dalle opere di cui all’oggetto; che con Verbale del Consorzio Scuola Media di Valle Antigorio e Formazza tra i Comuni di Baceno, Crodo, Premia e Formazza n.2 del 18.04.1972 si deliberava di liquidare le ditte interessate dai lavori di cui sopra.