Chiese Ed Oratori Di Genova
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol
ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. XLVI (CXX) Fasc. I DINO PUNCUH All’ombra della Lanterna Cinquant’anni tra archivi e biblioteche: 1956-2006 a cura di Antonella Rovere Marta Calleri - Sandra Macchiavello ** GENOVA MMVI NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese: prime indagini Credo di dovermi scusare, preliminarmente, se il titolo di questa co- municazione contiene due equivoci: il primo riguarda lo stesso termine di cancelleria arcivescovile, difficilmente accertabile in ambito genovese, per cui dovrò più correttamente limitarmi ad indagare le eventuali influenze del documento pontificio su quello vescovile; il secondo deriva dall’accenno alle prime indagini che purtroppo potrebbero essere anche le ultime, almeno stando all’esiguità e alla frammentarietà della documentazione rintracciata 1 e ai risultati conseguiti. ——————— * Pubbl. in Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert , a cura di P. H ERDE e H. J AKOBS (« Archiv für Diplomatik », Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde, 7), Köln-Weimar-Wien 1999, pp. 39-60. 1 Sono stati consultati i seguenti fondi ecclesiastici ed edizioni: Archivio di Stato di Ge- nova, Monastero di Santo Stefano ; G. F ALCO , Le carte del monastero di San Venerio del Tino, I (1050-1200) , II (1200-1300) , Torino 1920-1933 (Biblioteca della Società Storica subalpina, XCI/1 e 2); Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1328) , a cura di M. C ALLERI - S. M ACCHIAVELLO - M. T RAINO , Genova 1997-1998 (Fonti per la storia della Liguria, V-VIII); Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. -

'In the Footsteps of the Ancients'
‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’: THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI Ronald G. Witt BRILL ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ STUDIES IN MEDIEVAL AND REFORMATION THOUGHT EDITED BY HEIKO A. OBERMAN, Tucson, Arizona IN COOPERATION WITH THOMAS A. BRADY, Jr., Berkeley, California ANDREW C. GOW, Edmonton, Alberta SUSAN C. KARANT-NUNN, Tucson, Arizona JÜRGEN MIETHKE, Heidelberg M. E. H. NICOLETTE MOUT, Leiden ANDREW PETTEGREE, St. Andrews MANFRED SCHULZE, Wuppertal VOLUME LXXIV RONALD G. WITT ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ ‘IN THE FOOTSTEPS OF THE ANCIENTS’ THE ORIGINS OF HUMANISM FROM LOVATO TO BRUNI BY RONALD G. WITT BRILL LEIDEN • BOSTON • KÖLN 2001 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Witt, Ronald G. ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. Witt. p. cm. — (Studies in medieval and Reformation thought, ISSN 0585-6914 ; v. 74) Includes bibliographical references and indexes. ISBN 9004113975 (alk. paper) 1. Lovati, Lovato de, d. 1309. 2. Bruni, Leonardo, 1369-1444. 3. Latin literature, Medieval and modern—Italy—History and criticism. 4. Latin literature, Medieval and modern—France—History and criticism. 5. Latin literature, Medieval and modern—Classical influences. 6. Rhetoric, Ancient— Study and teaching—History—To 1500. 7. Humanism in literature. 8. Humanists—France. 9. Humanists—Italy. 10. Italy—Intellectual life 1268-1559. 11. France—Intellectual life—To 1500. PA8045.I6 W58 2000 808’.0945’09023—dc21 00–023546 CIP Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Witt, Ronald G.: ‘In the footsteps of the ancients’ : the origins of humanism from Lovato to Bruni / by Ronald G. -
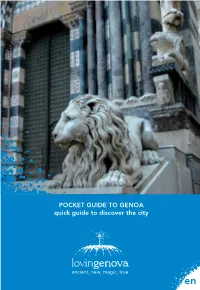
POCKET GUIDE to GENOA Quick Guide to Discover the City
POCKET GUIDE TO GENOA quick guide to discover the city en 2-3 hours A FLEETING VISIT TO GENOA Four 100% Genoese settings, if you only have a couple of hours to spare Via Garibaldi, the power and Via del Campo, the singer- wealth of the “Siglo des los songwriters and the unique Genoveses” (the Century of the atmosphere of the alleyways Genoese) in the centro storico This is one of the finest “Via del Campo” is the title of one Renaissance streets in the of the moving ballads written and world. Its palazzi. known as the sung by Fabrizio De Andrè. “Rolli”, were splendid patrician Access to the street is from the Translation: homes which the owners were ancient Porta dei Vacca gate, then English Language Consultancy required to make available for have a look at the shop windows Justin Michael Rosenberg royalty and dignitaries visiting in Via San Luca until you reach Photographs: the Republic of Genoa. Piazza Banchi and Caricamento. Sagep Photographic Archives “Castelletto”, a window over “Passeggiata al Porto Antico”, Edited by the Municipality of Genoa, the old town waterfront promenade Tourism Development and Promotion dept. From the renowned “spianata di As you stroll along the old docks This edition was published Castelletto”, which is accessible and wharfs, the lighthouse and in December 2011 by Grafiche G7 by lift from Piazza Portello, you big cruise ships loom into view. for Sagep Editori S.r.l. - Genoa have spectacular views of the A ride on the “Bigo” panoramic centro storico extending all the lift gives you a new perspective © 2012 Sagep Editori, Genoa way to the sea. -

MARAGLIANO 1664-1739 Lo Spettacolo Della Scultura in Legno a Genova
TESTI SEZIONI MARAGLIANO 1664-1739 Lo spettacolo della scultura in legno a Genova Genova, Palazzo Reale – Teatro del Falcone dal 10 novembre 2018 al 10 marzo 2019 a cura di Daniele Sanguineti con la direzione di Luca Leoncini IL SACRO CHE SI FA VERO Ragioni della mostra Il nome di Anton Maria Maragliano è da tempo identificato con l’intera produzione di scultura lignea in Liguria, prima e dopo di lui. Un fenomeno di fortuna critica e di affezione popolare unico nel panorama della plastica su legno italiana, che tuttavia ha pesato più sul catalogo delle sue opere, in passato ingiustificatamente amplificato, che sui modi e sui tempi dell’esposizione dei capolavori usciti dalla sua officina nella quale si formarono almeno due generazioni di artefici del legno. È infatti questa la prima mostra monografica dedicata a un artista che attendeva ormai da decenni una rassegna che ne celebrasse lo straordinario talento. Titolare dalla fine del Seicento di una delle botteghe più importanti di Genova, per più di cinquant’anni realizzò, insieme ai suoi allievi, schiere di Madonne, crocifissi, santi, macchine da processione (casse) per i culti delle confraternite (casacce), degli ordini religiosi e delle chiese parrocchiali, con esiti tecnici e formali mai visti prima. Figure mosse da grazia, libere nello spazio, avvolte in panneggi leggeri e raffinatissimi, dorati e coloratissimi grazie all’intervento di maestranze specializzate. Dal cuore della città, quella produzione si irradiò in ogni angolo dell’antico territorio della Repubblica di Genova, da Ponente a Levante, dalla costa alle valli, dall’Oltregiogo alla Corsica, raggiungendo, via mare, anche la penisola iberica. -

Exhibition Checklist: a Superb Baroque: Art in Genoa, 1600-1750 Sep 26, 2021–Jan 9, 2022
UPDATED: 8/11/2020 10:45:10 AM Exhibition Checklist: A Superb Baroque: Art in Genoa, 1600-1750 Sep 26, 2021–Jan 9, 2022 The exhibition is curated by Jonathan Bober, Andrew W. Mellon Senior Curator of Prints and Drawings National Gallery of Art; Piero Boccardo, superintendent of collections for the City of Genoa; and Franco Boggero, director of historic and artistic heritage at the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Genoa. The exhibition is organized by the National Gallery of Art, Washington, and the Scuderie del Quirinale, Rome, with special cooperation from the City and Museums of Genoa. The exhibition is made possible by the Robert Lehman Foundation. Additional funding is provided by The Exhibition Circle of the National Gallery of Art. The exhibition is supported by an indemnity from the Federal Council on the Arts and the Humanities. Press Release: https://www.nga.gov/press/exh/5051.html Order Press Images: https://www.nga.gov/press/exh/5051/images.html Press Contact: Laurie Tylec, (202) 842-6355 or [email protected] Object ID: 5051-345 Valerio Castello David Offering the Head of Goliath to King Saul, 1640/1645 red chalk on laid paper overall: 28.6 x 25.8 cm (11 1/4 x 10 3/16 in.) National Gallery of Art, Washington, Rosenwald Collection Object ID: 5051-315 Giovanni Benedetto Castiglione The Genius of Castiglione, before 1648 etching plate: 37 x 24.6 cm (14 9/16 x 9 11/16 in.) sheet: 37.3 x 25 cm (14 11/16 x 9 13/16 in.) National Gallery of Art, Washington, Gift of Ruth B. -

Genova and Its Surroundings
Genova and its surroundings Day 1 – GENOVA Upon arrival, meeting with the bus and transfer to the hotel. In the afternoon visit of the historical centre: The historic centre of Genoa is the largest and most monumental in Europe. Today it has rediscovered its splendour. The maze of the caruggi (alleys) charms and fascinates through its history and marvellous architecture. At every single corner there is a hidden treasure: from the Commenda di Prè to the Sarzano hill, from the Banco di San Giorgio to San Matteo square, everywhere you are surrounded by squares and alleys, loggias and medieval buildings, shrines and tower- houses, mansions and churches with façades in black and white stripes and rich Baroque interiors. A constant crowd fills up the alleys, colourful with shops and stores by day, enlivened by night by young people, who flood the old town like a living sea wave Dinner and overnight Day 2- GENOVA The Old Harbour and the aquarium After breakfast, visit the Old Harbour is the heart of Genoa. It started to beat again for the Genoese and tourists alike in 1992 when the 500th anniversary of the discovery of America was celebrated. In that occasion, in fact, the Porto Antico (Old Harbour) underwent a radical renovation lead by the world famous Genoese architect Renzo Piano. Here, your guide will point out the Bigo which supports today a panoramic lift reaching up 40m. You will also see the Biosfera, a glass and steel structure containing tropical plants and animals and visit Galata – Museo del Mare, a museum set in the Old Arsenal of the Superb. -

Studi E Documenti Di Storia Ligure
ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. XXXVI (CX) Fasc. II Studi e Documenti di Storia Ligure IN ONORE DI DON LUIGI ALFONSO PER IL SUO 85° GENETLIACO GENOVA MCMXCVI NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Per la riproduzione di p. 185 autorizzazione dell’Archivio di Stato di Genova N. 16/97, Prot. n. 1832.5/9, del 27/5/1997 DANIELE SANGUINETI NOVITÀ SULL’OPERA DI ANTON MARIA MARAGLIANO DOCUMENTI PER LE CAPPELLE SQUARCIAFICO ALLE VIGNE E DELL’ANGELO CUSTODE IN N. S. DELLA ROSA Esprimo tutta la mia gratitudine a Piero Boccardo, Benedetto Tino Delfino, Francesca Fabbri, Fausta Franchini Guelfi, Letizia Lodi, Angela Mambelli, Nerio Marchi, Gianluca Zanelli: sen- za il loro vario e prezioso ausilio questo contributo non sarebbe stato scritto. Referenze fotografiche Figg. 1, 2, 3, 6, 7: Archivio Fotografico del Servizio Beni Culturali del Comune di Genova; figg. 4, 8: Daniele Sanguineti; fig. 5: Archivio Fotografico “Marchi restauri”. Fra le problematiche relative allo studio della produzione scultorea di Anton Maria Maragliano, discusse da chi scrive nel corso di singoli contri- buti a cui si rimanda 1, la distribuzione cronologica delle opere che com- pongono il catalogo dell’artista rimane a tutt’oggi di pervicace dipanamento: l’eccezionale copiosità produttiva, notevolissima anche in seguito ad una radicale depurazione inoltrata da Graziella Colmuto e proseguita da Fausta Franchini Guelfi e dallo scrivente 2, e la presenza di un supporto documen- taristico utile solo per una parte esigua del catalogo (se confrontata con la già evidenziata quantità), hanno infatti reso ardua una serrata successione temporale delle opere, spesso radunate, in virtù di confronti stilistici, attor- no ai testi figurativi datati con certezza. -

Nuova Serie Liii (Cxxvii) Fasc. Ii
Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA NUOVA SERIE LIII (CXXVII) FASC. II GENOVA MMXIII NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell’elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all’indirizzo: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente. All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer. « Atti della Società Ligure di Storia Patria » è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp « Atti della Società Ligure di Storia Patria » is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2016 Rileggendo il Liber iurium II. Il Monferrato e i suoi marchesi Francesca Mambrini È ormai ben conosciuto quel corposo complesso documentario, il Li- ber iurium I, che rappresenta una fonte di primaria importanza per la storia del comune di Genova dal X al XIV secolo 1. Come è noto, il corpus si com- pone in una lunga serie di registri collegati l’un l’altro da stretti rapporti re- dazionali 2, che, nella loro organicità, testimoniano un’attenzione secolare da parte del comune per la cura del proprio patrimonio documentario, in particolare per quello di persistente attualità. -

Genoa and Its Treasures
Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Tourist Information Centres (T.I.C.) IAT Via Garibaldi Useful info: Via Garibaldi 12r Ph. +39 010 55 72 903/ 751 Genoa Aquarium Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) C. Colombo Airport [email protected] Ph. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari City sightseeing open top bus Largo Pertini 13 Genova in Tour Pesci Viaggi Ph. +39 010 86 06 122 Ph. +39 010 53 05 237 - Mobile +39 328 98 55 419 Fax +39 010 86 06 476 www.pesciviaggi.it (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) [email protected] Hop-on hop-off city tour CITYSIGHTSEEING GENOVA IAT C. Colombo Airport (arrivals area) Ph. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Ph./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Genoa Museums [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Walking guided tour to the historical centre Ph. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it and the Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage Visit of the city with little train Every weekend you can visit the historical city Trenino Pippo centre and discover the fascination of some of Ph. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it the famous Palazzi dei Rolli. Trains More information about costs and languages Ph. -

Actas II Congreso Internacional De La Vera Cruz, Eds
Confraternities Collection 1 The Confraternities Collection at the Centre for Reformation and Renaissance Studies A special collection compiled from publications received through the Society for Confraternity Studies from 1990 to 2006 and listed in the “Publications Received” rubric of the journal Confraternitas (vols. 1-17, 1990-2006) (This listing was updated on 15 January 2007) Items on this list are available for consultation in the library of The Centre for Reformation and Renaissance Studies Victoria College, University of Toronto Actas II congreso internacional de la Vera Cruz, eds. Mariano García-Esteller Guerrero and Diego Marín Ruiz de Assín. Murcia: Ediciones Myrtia, S.L., 2001. 432 pp., b/w illustrations ISBN 84-95549-12-3 [Contains: José Sánchez Herrero "La devoción a la Cruz de Cristo. Siglos IV al XV" pp. 19-53; Giovanna Casagrande "Confraternite della S. Croce e del SS. Crocifisso in Italia centrale (secc. XIII-XVI)" pp. 55-117; María Fernanda Enes "O culto da Cruz e do sangue na afirmação da humanidade de Cristo no Portugal de seiscentos e setecentos" pp. 119-138; Joaquín Rodríguez Mateos "La devoción a la Cruz en la América colonial" pp. 139-150; Diego Ruiz Marín de Assín "La cofradía de la Vera Cruz de Caravaca. Siglos XV-XX" pp. 151-162; Cristóbal Belda Navarro "El obispo Sancho Dávila y el valor de las reliquias" pp. 163-191; Elías Hernández Albaladejo "La Vera Cruz de Caravaca y la arquitectura para las reliquias" pp. 193-228; Jesús Juárez "Sentido benéfico-asistencial de la Cofradía de la Vera Cruz" pp. 229-235; Liana Bertoldi Lenoci "El culto del crucifijo y las cofradías. -

Cities of God: the Religion of the Italian Communes 1125-1325
cities of god Cities of God the religion of the italian communes 1125–1325 augustine thompson, o.p. The Pennsylvania State University Press University Park, Pennsylvania Disclaimer: Some images in the original version of this book are not available for inclusion in the eBook. Unless otherwise noted, all photographs are by David Sundt. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Thompson, Augustine. Cities of God : the religion of the Italian communes, 1125–1325 / Augustine Thompson, O.P. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-271-02477-1 (alk. paper) 1. Italy—Church history. I. Title. BX1210 .T48 2005 282Ј.45Ј09022—dc22 2004015965 Copyright ᭧ 2005 The Pennsylvania State University All rights reserved Printed in the United States of America Published by The Pennsylvania State University Press, University Park, PA 16802-1003 The Pennsylvania State University Press is a member of the Association of American University Presses. It is the policy of The Pennsylvania State University Press to use acid-free paper. Publications on uncoated stock satisfy the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences— Permanence of Paper for Printed Library Materials, ansi z39.48–1992. Contents Abbreviations vii Note on Style xi Acknowledgments xiii Introduction 1 PART I. LA CITADE SANCTA:SACRED GEOGRAPHY 1 The Mother Church 15 2 From Conversion to Community 69 3 The Holy City 103 4 Ordering Families, Neighborhoods, and Cities 141 5 Holy Persons and Holy Places 179 PART II. BUONI CATTOLICI:RELIGIOUS OBSERVANCE 6 The City Worships 235 7 Feasting, Fasting, and Doing Penance 273 8 Resurrection and Renewal 309 9 Good Catholics at Prayer 343 10 World Without End. -

Download Document
General Council Term of Office 2016-2019 End-of-Tenure and 2019 Report Text approved by the General Council on 20/04/2020 Contents Preface: Letter from the General Council 3 Institutional activity 2016-2019 37 Research and public health International affairs programme Historical and legal profile of FCSP 6 Art, cultural heritage and cultural activities Cultural innovation Social policy Housing programme 2016-2019: data on institutional activity ZeroSei programme Philanthropy and Local Communities undertaken in the four-year period, and 2019 “Social Report” 11 Major system-building projects 63 Inclusion in practice: MOI – a response to the migration emergency FCSP 2016-2019: Public health as a value-generator: progress towards the Turin Health Park reorganisation and processes 26 Injecting dynamism into cultural heritage: the Residences of the House of Savoy Becoming a HUB: operational effects “Riconnessioni”: the digital education model Evolution of the multiplier vectors: At the service of a cohesive, enterprising ecosystem of territorial innovation the High-Impact Innovation Department The metropolitan environment and ecosystem The Planning, Studies and Assessment Department for the growth of social enterprise FCSP: a stand-alone entity and a Group Boosting competitiveness in Turin’s higher education system More than just method: a sustainable new angle on traditional goals Communicating strategically The Administration function: The contribution of the Council’s subject-specific committees 71 evolution of the organisational set-up Applicants