Relazione Ambientale Integrazio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona
Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio invernale 2019/20 [email protected] 115 Verona - Romagnano - Cerro - Roverè - Velo ................................... 52 Linee da/per Verona 117 S.Francesco - Velo - Roverè - S.Rocco - Verona .............................. 53 101 S. Lucia - Pescantina - Verona ........................................................14 117 Verona - S.Rocco - Roverè - Velo - S.Francesco .............................. 53 101 Verona - Pescantina - S. Lucia ........................................................15 119 Magrano - Moruri - Castagnè - Verona .............................................54 102 Pescantina - Bussolengo - Verona .................................................. 16 119 Verona - Castagnè - Moruri - Magrano .............................................54 102 Verona - Bussolengo - Pescantina .................................................. 16 120 Pian di Castagnè/San Briccio - Ferrazze - Verona ............................ 55 90 Pescantina - Basson - Croce Bianca - Stazione P.N. - p.zza Bra - P. 120 Verona - Ferrazze - San Briccio/Pian di Castagnè ............................ 55 Vescovo ............................................................................................... 17 121 Giazza - Badia Calavena - Tregnago - Strà - Verona ......................... 56 90 P.Vescovo - p.zza Bra - Stazione P.N. - Croce Bianca - Basson - 121 Verona - Strà - Tregnago - Badia Calavena - Giazza ......................... 58 Pescantina ............................................................................................17 -

Scarica Il Documento
CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Affi Brentino Belluno Brenzone Caprino Veronese Cavaion Veronese VR 1 Comunità Montana 18 Caprino V.se del Baldo del Baldo Costermano Ferrara di Monte Baldo Malcesine Rivoli Veronese S. Zeno di Montagna Torri del Benaco 11 Dolcè Fumane Sant’Ambrogio Marano di Valpolicella 15 VP VR 2 Negrar della Sant'Ambrogio S. Ambrogio di Valpolicella Lessinia Valpolicella S. Anna d’Alfaedo Occidentale Bussolengo Pastrengo 17 Pescantina Pescantina S. Pietro in Cariano 10 Bosco Chiesanuova Cerro Veronese Erbezzo Bosco 2 Chiesanuova Grezzana Rovere Veronese S. Mauro di Saline Velo Veronese VR 3 Badia Calavena della Comunità Montana Lessinia della Lessinia Cazzano di Tramigna Orientale Illasi Mezzane di sotto Montecchia di Crosara 3 Illasi Roncà S. Giovanni Ilarione Selva di Progno Tregnago Vestenanova 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Belfiore Monteforte D’Alpone 4 San Bonifacio S. Bonifacio Soave Albaredo d’Adige Arcole Bevilacqua Bonavigo Boschi S.Anna VR 4 Cologna Veneta del Cologna Veneta 7 Cologna V.ta Colognese Minerbe Pressana Roveredo di Guà Terrazzo Veronella Zimella Caldiero Colognola ai Colli 8 San Martino BA Lavagno S. Martino Buon Albergo 20 San Giovanni Lupatoto 5 Zevio Zevio Angari Bovolone Isola Rizza Oppiano 6 Bovolone Palù Ronco all’Adige VR 5 Legnago delle Valli Roverchiara S. Pietro di Morubio Casaleone Cerea 9 Cerea Concamarise Sanguinetto Castagnaro 11 Legnago Legnago Villa Bartolomea 17 CAPOFILA N. DISTRETTO COM CAPOFILA COM COMUNI DISTRETTO COMUNI Buttapietra Gazzo Veronese Isola della Scala 10 Isola D/S Nogara Salizzole VR 6 Sorgà Isola della Scala Isolano Castel d’Azzano Erbè Mozzecane 12 Mozzecane Nogarole Rocca Trevenzuolo Vigasio 12 Povegliano veronese Sommacampagna 13 Villafranca Valeggio sul Mincio Villafranca Veronese VR 7 Villafranca Castelnuovo del Garda Zona Mincio Veronese 14 Peschiera D/G Peschiera del Garda Sona Bardolino 16 Bardolino Garda Lazise. -

Prov VR Determinazione N.3485-19 Del 08-11-2019.Pdf
PROVINCIA DI VERONA Area funzionale Servizi in Campo Ambientale Servizio Valutazione Impatto Ambientale Oggetto Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Istanza pervenuta dalla ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l. avente ad oggetto: "INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA", nei comuni di Veronella e Zimella (VR). determinazione n. 3485/19 del 08/11/2019 Decisione Il dirigente1 dell'Area funzionale Servizi in Campo Ambientale della Provincia di Verona: – esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'istanza avente ad oggetto: "INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA", nei comuni di Veronella e Zimella (VR), dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale. Fatto A nome del legale rappresentante della KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l.2 in data 11 aprile 20193 è pervenuta la documentazione relativa all'istanza avente ad oggetto "INCREMENTO DELLA CAPACITA' DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI DA COMPAGNIA", nei comuni di Veronella e Zimella (VR). Nella seduta del 13 settembre 2019 (verbale n. 92) il Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale, ad unanimità, ha ritenuto di escludere l'intervento in argomento dalla procedura di VIA, dando atto della non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale. In data 06 novembre 2019 la conferenza decisoria in materia di VIA, convocata ai sensi dell'art. -

Determina 186 - Via Vergaglia.Pdf
COMUNE DI ZIMELLA Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144 C.A.P. 37040 PROVINCIA DI VERONA C.F. 00631830239 COPIA N.186 del 05-07-2018 REG. GENERALE N.81 del 05-07-2018 REG. di AREA D E T E R M I N A Z I O N E AREA EDILIZIA PUBBLICA Oggetto: LAVORI DI ASFALTATURA VIA VERGAGLIA IN SANTO STEFANO DI ZIMELLA. Aggiudicazione ditta GIVANI s.r.l. - CIG Z6C2158BD1 IL RESPONSABILE DELL’AREA PREMESSO che l’Amministrazione del Comune di Zimella ha manifestato la volontà di eseguire i lavori di asfaltatura via Vergaglia in Santo Stefano di Zimella; CHE con delibera Giunta Comunale n. 99 del 12/10/2017, esecutiva, veniva nominato, ai sensi del comma 1, articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il geom. Tiziano Cavaggioni, responsabile unico del procedimento dei lavori asfaltatura via Vergaglia in Santo Stefano di Zimella e nel contempo veniva affidato al medesimo tecnico l'incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva nonché di direzione dei lavori; CHE con delibera Giunta Comunale n. 126 del 29/11/2017 veniva approvato il progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 39.000,00 così suddiviso: a lavori a base d'asta 30.060,00 € b oneri per la sicurezza 440,00 € TOTALE LAVORI (a+b) 30.500,00 € c somme a disposizione (1+2+3) 8.500,00 € 1 22% IVA su totale lavori 6.710,00 € 2 spese tecniche 610,00 € 3 imprevisti ed arrotondamenti 1.180,00 € TOTALE LOTTO 1 (a+b+c) 39.000,00 € DATO ATTO che la spesa cmplessiva di € 39.000,00 trova idonea copertura finanziaria mediante imputazione delle seguenti somme: · € 19.332,46 al CAPITOLO 1370.01 CODICE DI BILANCIO 2.02.01.09.012 "UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016: manutenzione straordinaria strade comunali"; · € 19.667,54 al CAPITOLO 1520.01 CODICE DI BILANCIO 10.05-2.02.01.09.012 "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE"; del bilancio di previsione e.f. -

Linee E Orari Bus Extraurbani - Provincia Di Verona
Linee e orari bus extraurbani - Provincia di Verona Servizio Estivo 2016 [email protected] 141 Legnago - Roverchiara - Oppeano - Verona .....................................47 Linee da/per Verona 141 Verona - Oppeano - Roverchiara - Legnago .....................................47 102 Ceraino - Domegliara - S.Lucia - Pescantina - Bussolengo - Verona 143 Legnago - S.Pietro di Morubio - Bovolone - Verona ..........................48 ............................................................................................................. 12 144 Legnago - Cerea - Bovolone - Verona ..............................................49 102 Verona - Bussolengo - Pescantina - S.Lucia - Domegliara - Ceraino 144 Verona - Bovolone - Cerea - Legnago ..............................................50 ............................................................................................................. 12 146 Nogara - Isola d. Scala - Verona ......................................................51 Domegliara/Negrar - Verona ................................................................13 146 Verona - Isola d. Scala - Nogara ......................................................51 Verona - Negrar/Domegliara ................................................................15 148 Mantova - Castelbelforte - Trevenzuolo - Vigasio - Verona ................52 104 Fosse - S.Anna di Alfaedo - Negrar - Verona ....................................17 148 Verona - Vigasio - Trevenzuolo - Castelbelforte - Mantova ................52 104 Verona - Negrar - S.Anna -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015
Ufficio del territorio di VERONA Data: 13/04/2016 Ora: 10.46.12 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.- del 16/01/2016 n.- del - REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 MONTAGNA DEL BENACO ORIENTALE MONTI LESSINI Comuni di: BRENTINO BELLUNO, BRENZONE, CAPRINO VERONESE, Comuni di: BADIA CALAVENA, BOSCO CHIESANUOVA, DOLCE`, FERRARA DI MONTE BALDO, MALCESINE, SAN ZENO DI ERBEZZO, ROVERE` VERONESE, SAN MAURO DI SALINE, MONTAGNA SANT`ANNA D`ALFAEDO, SELVA DI PROGNO, VELO VERONESE, VESTENANOVA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 7570,00 SI 7570,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO 13780,00 13780,00 SI CASTAGNETO 18590,00 18590,00 FRUTTETO IRRIGUO 74380,00 2-IN PRESENZA DI IMPIANTO 74380,00 2-IN PRESENZA DI IMPIANTO DI ACTINIDIA INTENSIVO, SI DI ACTINIDIA INTENSIVO, SI APPLICA LA APPLICA LA MAGGIORAZIONE DEL 30%) MAGGIORAZIONE DEL 30%) INCOLTO IMPRODUTTIVO 7570,00 SI 3-TERRENO STERILE O DI 7570,00 SI 3-TERRENO STERILE O DI FERTILITA TANTO LIMITATA FERTILITA TANTO LIMITATA DA NON ESSERE DA NON ESSERE SUSCETTIBILE DI SUSCETTIBILE DI CONVENIENTE CONVENIENTE COLTIVAZIONE) COLTIVAZIONE) INCOLTO PRODUTTIVO 14470,00 SI 14470,00 SI OLIVETO 65420,00 SI SI ORTO A PIENO CAMPO 46140,00 1-COLTIVAZ. DI ORTO, 46140,00 1-COLTIVAZ. DI ORTO, FRAGOLE, FIORI, ETC, NON FRAGOLE, FIORI, ETC, NON PROTETTI. PER COLT. DI PROTETTI. PER COLT. DI ASPARAGO, -

Scuole San Bonifacio
ATV - Azienda Trasporti Verona - Orario servizi speciali scuole 2021/2022 SCUOLE SAN BONIFACIO LINEE EXTRAURBANE LINEA 130 LINEA 133 LINEA 226 LINEA 233 LINEA 236 LINEA 237 stazione FS marc C1 stazione FS marc C1 Campofontana Roveredo di Guà Montagnana Legnago Aut. Porta Vescovo Porta Vescovo S.Bortolo Cologna Veneta Roveredo di Guà S.Vito S.Michele Extra S.Michele Extra Vestenanovo Albaredo d'Adige Sabbion Bevilacqua S.Martino B.Albergo S.Martino B.Albergo S. Giov.Ilarione Veronella Cologna Veneta S. Zenone Vago Vago Montecchia di Cros. S. Gregorio Zimella Miega Strà Strà Roncà Bonaldo Lonigo Michelorie Caldiero Belfiore Terrossa S. stefano di Zimella Locara Albaredo d'Adige Soave Casteletto Costalunga Gazzolo Lobbia Miracolo Vilabella Vilabella Monteforte Arcole Prova Arcole S.Bonifacio Aut. S.Bonifacio Aut. S.Bonifacio Aut. S.Bonifacio Aut. S.Bonifacio Aut. S.Bonifacio Aut. LINEA 121 LINEA 229 Giazza Tregnago Selva di Progno Capovilla Badia Calavena Costa Cogollo Cazzano di Tramigna Tregnago Costeggiola Illasi Soave S.Zeno di Colognola S. Vittore Decima Colognola ai Colli Strà Strà prosegue con linea 130 prosegue con linea 130 CONSULTA GLI ORARI DELLE LINEE SU WWW.ATV.VERONA.IT O SCARICA L'APP INFOBUS VERONA ATV - Azienda Trasporti Verona - Orario servizi speciali scuole 2021/2022 SCUOLE SAN BONIFACIO SPECIALI SCUOLE SAN BONIFACIO entrata ORE 08:00 SC210 SAN BONIFACIO SC210 SAN BONIFACIO SC210 SAN BONIFACIO SC210 SAN BONIFACIO Albaredo d'Adige 06.51 Cadellara 06:50 Arcole 07:25 S.Bonifacio Aut. 07:35 San Gregorio 07.01 Strà 06:55 S.Bonifacio Aut. 07:32 S.Bonifacio Centro 07:40 Bonaldo 07.05 S. -

Parere PATI Veronella E Zimella
COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PARERE n. 29 del 15 luglio 2010 (o.d.g. 5 del 15 luglio 2010) OGGETTO: Comuni di Veronella (capofila) e Zimella (VR). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. PREMESSO CHE – ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull’ambiente al fine di “promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente”; – La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 15 luglio 2010, come da nota n. 369452 del 06.07.10 del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, segretario della commissione; – Il Comune di Zimella (VR), quale capofila del PATI tra i Comuni di Zimella e Veronella (VR), con note n. 4199 del 28.05.09, n.1409 del 23.02.10 n. 4542 del 23.06.2010, ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS. – ITER PROCEDURALE PER LA VAS Il Comune di Zimella con DGC n. 50 del 10.03.2005 e il Comune di Veronella con DGC n. 30 del 11.03.2005 hanno approvato il “Documento Preliminare alla redazione del piano di assetto del territorio – PATI” e lo “Schema di Accordo di copianificazione” ai sensi dell’art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio intercomunale, al fine di attivare la procedura concertata tra Comune e Regione per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale così come definito dalle stesse delibere di giunta; Con nota prot. -

Capitolo 6: I Fiumi Fratta E Gua'
CAPITOLO 6: I FIUMI FRATTA E GUA’ PREMESSA Nel presente capitolo vengono illustrati i principali risultati dell’attività di monitoraggio effettuata sui due principali fiumi presenti nella porzione orientale del territorio veronese: il fiume Togna ed il fiume Guà. La particolare attenzione rivolta verso questi due corsi d’acqua è dovuta al fatto che in passato il fiume Guà, e tuttora il fiume Fratta, hanno subito un forte degrado a causa degli scarichi dei reflui fognari del comparto della concia presenti nel territorio vicentino. In passato i principali impianti di depurazione del polo conciario erano costituiti dagli impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo che recapitavano in corsi d’acqua di modesta portata, con scarsa diluizione e con infiltrazioni e accumulo delle sostanze inquinanti nel sottosuolo a causa dell’elevatissima permeabilità del suolo. Gli scarichi di tali impianti recapitavano in un’importante zona di ricarica delle falde, in particolare della falda di Almisano, da cui oggi si attingono circa 600 l/s di acqua potabile per gli acquedotti di buona parte della bassa pianura veronese e del vicentino e tale zona rischiava di essere gravemente compromessa dai reflui degli impianti di depurazione. Pertanto la scelta della Regione Veneto è stata quella di convogliare gli scarichi dei depuratori presenti nell’area (Arzignano, Trissino, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore e Lonigo) in un unico collettore e di trasferire i reflui depurati a valle della fascia di ricarica degli acquiferi. Sostanzialmente le ragioni per cui venne concepito il collettore sono: - la necessità di proteggere le falde acquifere di Almisano; - la necessità di assicurare nel punto di scarico dei reflui depurati condizioni di miscelazione, ossigenazione e diluizione tali da permettere lo sviluppo di quei fenomeni cosiddetti di “autodepurazione residua” che trasforma i reflui in acque rigenerabili. -

15 13.2. Collaudi Tecnologici Di Opere Pubbliche 14. Antincendio
2013 lavori £.800.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo sistemazione Villa Poggi. Importo lavori £.240.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo sistemazione strade comunali. Importo lavori £.460.000.000. 1999 Comune di Arcole - Collaudo ampliamento cimiteri. Importo lavori £.200.000.000. 1999 Comune di Verona - Collaudo opere di urbanizzazione lottizzazione “LA CORTE” - Palazzina di Verona. Importo lavori £.200.000.000. 1999 Comune di Malcesine - Collaudo parcheggio comunale. Importo lavori £.2.800.000.000. 2000 Comune di Verona - Collaudo servizi e sottopassi Piazza Brà. Importo lavori £.990.000.000; 2001/2004 A.T.E.R. – Verona – Manutenzioni al patrimonio 1996/2000 – Importo lavori £.6.000.000.000; 2001 A.T.E.R. – Verona – Complesso ex area Gavazzi – Importo lavori £. 9.500.000.000; 2002 Comune di Verona – Collaudo opere stradali S. Lucia – Importo £.1.600.000.000; 2002 Comune di Pastrengo – Piano di Recupero Edilix; 2003 Comune di Verona – P.d.L. B.go Milano – Via Zorzi – Importo lavori € 940.000,00; 2003 A.T.E.R. Verona – Complesso residenziale a S. Ambrogio di Valpolicella; 2004 Comune di Pastrengo – Piano di Lottizzazione Zeni; 2005 Comune di Torre di Mosto (Ve) – Arredo urbano del centro storico; 2004 Comune di Bussolengo – Strada del “Cossano”; 2006/08 A.G.E.C. - Ampliamento cimitero monumentale 1° Stralcio – 2° Stralcio – 3° Stalcio € 1.500.000,00 2006/ Comune di Verona – collaudo opere urbanizzazione ca’ degli Olivi –Quinzano. € 290.000,00 2007/ 2010 Comune di Pastrengo - collaudi opere di urbanizzazione PEEP e privati in Capoluogo e Piovezzano. € 870.000,00 2008/ 2011 UNIVERSITA’ DI VERONA – Collaudo edificio 32.Verona. -

Continuità Assistenziale
AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori: - dott. Giuseppe Cenci Direttore Amministrativo - dott. Denise Signorelli Direttore Sanitario - dott. Raffaele Grottola Direttore dei Servizi Socio-Sanitari ha adottato in data odierna la presente deliberazione: OGGETTO MEDICINA GENERALE - INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2021 DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si individuano gli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria e gli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale per l'anno 2021 Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale Sentito il Direttore Funzione Territoriale e il Responsabile UOS Medicina Convenzionata, Privati Accreditati e Controlli; Premesso che il vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – intesa del 23.3.2005, come modificato dall’art. 5 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale – intesa del 21.6.2018, prevede, rispettivamente agli articoli 34 e 63: - la pubblicazione entro la fine del mese di marzo di ogni anno (art. 34) sul Bollettino Ufficiale della Regione degli ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri indicati all’art. 33 dello stesso ACN; - la pubblicazione entro la fine del mese di marzo di ogni anno (art. -
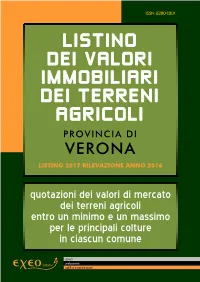
Listino Dei Valori Immobiliari Dei Terreni Agricoli
ISSN: 2280-191X LISTINO DEI VALORI IMMOBILIARI DEI TERRENI AGRICOLI PROVINCIA DI VERONA LISTINO 2017 RILEVAZIONE ANNO 2016 quotazioni dei valori di mercato dei terreni agricoli entro un minimo e un massimo per le prin cipali colture in ciascun comune privati professionisti edizioni pubblica amministrazione O SSERVATORIO DEI VALORI AGRICOLI – PROVINCIA DI VERONA – RILEVAZIONE 201 6 Hanno collaborato alla formazione del listino MASSIMO CURATOLO, ingegnere, membro di numerose commissioni di congruità presso enti pubblici. È stato capo area presso la struttura centrale della Agenzia del Territorio che si occupava di Osservatorio del mercato immobiliare. Ha diretto l’ufficio tecnico erariale di Isernia e di Viterbo. È stato capo del Servizio Tecnico 1° della Direzione Centrale dei SS.TT.EE. Autore/coautore di numerose pubblicazioni sia in campo estimale che catastale. Ha svolto numerosi incarichi di docenza. ANTONIO IOVINE, ingegnere consulente in materia di catasto ed estimo, attualmente direttore scientifico rivista informatica www.catastonline.it. È stato dirigente dell’Agenzia del territorio, responsabile dell’Area per i servizi catastali della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, membro della Commissione Censuaria Centrale. Autore/coautore di vari testi in materia di catasto, topografia ed estimo, ha svolto numerosi incarichi di docenza per conto della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e di altre strutture pubbliche o private tra cui, Scuola delle Autonomie locali, Consiel, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Verona, Synergia formazione. La redazione gradisce indicazioni costruttive o suggerimenti migliorativi ([email protected]). Disclaimer L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per errori o inesattezze.