L'isola Gallinara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Discover the Italian Riviera... Yachting, Colours, Emotions, History And
DISCOVER THE ITALIAN RIVIERA... YACHTING, COLOURS, EMOTIONS, HISTORY AND PLEASURE OVER 2400 BERTHS HIGH STANDARD OF TECHNICAL, LOGISTIC SERVICES AND HOSPITALITY Liguria for Yachting STARTING POINT FOR SUMMER CRUISING is the new network of marinas, bringing the IN THE MED most important ports of our region: Marina di Loano, HOME PORTS FOR ITALY Marina Genova, Marina Porto AND NORTHERN EUROPE Antico, Marina Molo Vecchio and Porto Lotti together. Our goal is to promote the Ligurian territory which offers extraordinary nautical and touristic experiences all year round. The Marinas of Liguria for Yachting consist of over 2400 berths guaranteeing the highest standard of services for yachts and superyachts. The Ligurian territory, due to its consistently mild climate, the surrounding natural beauty, the exceptional cultural opportunities and its strategic position is not only an ideal starting point for summer cruising in the Med, but also an ideal base in every season. The wide and professional range of nautical and technical services on offer, such as world famous shipyards, guarantees THE NETWORK THAT BRINGS the best care for yachts of all sizes. TOGETHER THE MOST WATER SUPPLY PARKING WI-FI WASTE IMPORTANT MARINAS FUEL STATION DISPOSAL SECURITY BARS WEATHER YACHT ON THE ITALIAN RIVIERA RESTAURANTS FORECAST CHANDLERY CONCIERGE LIGURIA - ITALY STRATEGIC POSITION IN THE MED LONDON BERLIN AMSTERDAM LOCATED IN THE HEART OF EUROPE DÜSSELDORF LONG TRADITION OF SEAFARING PEOPLE FRANKFURT PARIS HIDDEN HINTERLAND TO BE DISCOVERED MUNICH ZÜRICH VIENNA -

Capraia (?) S.Pietro Giglio
Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Trentino Alto-Adige Veneto Friuli Venezia-Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Basilicata Puglia Calabria Sicilia Sardegna Elba Ponziane Eolie Egadi Tremiti Pantelleria Corsica Vallese (CH) Grigioni (CH) Ticino (CH) Malta Istria Slovenia Croazia Alpi Marittime francesi isole minori Sialis fuliginosa Pictet Sialis lutaria (Linnaeus) ? Sialis morio Klingstedt Sialis nigripes Pictet Phaeostigma galloitalicum (A. & A.) ? Phaeostigma italogallicum (A. & A.) Phaeostigma notatum (F.) ? ? ? ? Phaeostigma grandii (Principi) Phaeostigma major (Burmeister) ? Dichrostigma flavipes (Stein) Tjederiraphidia santuzza A., A. & R. Subilla confinis (Stephens) ? ? Subilla principiae Pantaleoni, A., Cao & A. Ornatoraphidia flavilabris (Albarda) ? Turcoraphidia amara (A. & A.) Xanthostigma xanthostigma Schum.? ? ? Xanthostigma corsicum (Hagen) ? Giglio Xanthostigma aloysianum (Costa)? Raphidia oph. ophiopsis Linnaeus ? ? Raphidia mediterranea A., A. & R. ? ? Raphidia ulrikae Aspöck Raphidia ligurica Albarda ? Atlantoraphidia maculicollis Steph. ? Italoraphidia solariana (Navás) Puncha ratzeburgi (Brauer) Calabroraphidia renate R., A. H. & A. U. Venustoraphidia nigricollis Albarda? ? ? Fibla maclachlani (Albarda) ? S.Pietro (?) Parainocellia braueri (Albarda) Parainocellia bicolor (Costa) Inocellia crassicornis (Schummel) Aleuropteryx loewii Klapalek Aleuropteryx juniperi Ohm Aleuropteryx umbrata Zeleny Helicoconis lutea (Wallengren) ? ? Helicoconis hirtinervis Tjeder ? Helicoconis -

Commission Implementing Decision of 16 November 2012 Adopting A
26.1.2013 EN Official Journal of the European Union L 24/647 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 16 November 2012 adopting a sixth updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2012) 8233) (2013/29/EU) THE EUROPEAN COMMISSION, (4) In the context of a dynamic adaptation of the Natura 2000 network, the lists of sites of Community importance are reviewed. An update of the list of sites Having regard to the Treaty on the Functioning of the European of Community importance for the Mediterranean biogeo Union, graphical region is therefore necessary. Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and (5) On the one hand, the update of the list of sites of flora ( 1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) Community importance for the Mediterranean biogeo thereof, graphical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since 2010 by Whereas: Member States as sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region within the meaning of Article 1 of Directive 92/43/EEC. For these (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in additional sites, the obligations resulting from Articles Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the 4(4) and 6(1) of Directive 92/43/EEC should apply as Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with soon as possible and within six years at most from the Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Acces adoption of this Decision. -

Review of the Artisanal Fisheries in the Mediterranean
Inventory of Artisanal Fishery Communities in the Western-Central Mediterranean Salvatore R. Coppola Fishery Resources Officer Marine Resources Service Fishery Resources Division FAO, Rome September 2001 FAO-COPEMED Project ii COPYRIGHT AND OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2001 The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. All copyright and intellectual property rights reserved. No part of the procedures or programs used for the access to, or the display of, data contained in this database or software may be reproduced, altered, stored on a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), except in the cases of copies intended for security back-ups or for FAO internal use (i.e., not for distribution, with or without a fee, to third parties). Applications for such permission, explaining the purpose and extent of reproduction, should be addressed to: The Director, Publications Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy. Software or other components in this database may, however, be used freely provided that the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is cited as the source. -
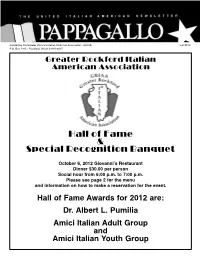
40569 Fall 2012 29056GRIAA Papfall07 9/4/12 8:05 AM Page 1
40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 1 Funded by the Greater Rockford Italian American Association - GRIAA Fall 2012 P.O. Box 1915 • Rockford, Illinois 61110-0415 Greater Rockford Italian American Association Hall of Fame & Special Recognition Banquet October 6, 2012 Giovanniʼs Restaurant Dinner $30.00 per person Social hour from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Please see page 2 for the menu and information on how to make a reservation for the event. Hall of Fame Awards for 2012 are: Dr. Albert L. Pumilia Amici Italian Adult Group and Amici Italian Youth Group 40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 2 Pappagallo ’12 Pappagallo ’12 2 continued on next page 40569 fall 2012_29056GRIAA_PapFall07 9/4/12 8:05 AM Page 3 Pappagallo ’12 Pappagallo ’12 Italian Hall of Fame Awardees for 2012 Dr. Albert L. Pumilia father into dentistry. Dr. Pumilia continues to teach at the Dental Careers Foundations where he has trained more than 300 dental assistants. He recently published an e-book “Your Travel Companion: A Chapbook of Short Stories”, where he depicts several historical incidences in the Rockford Italian Community. Dr. Albert L. Pumilia, a retired Rockford dentist, will also be inducted into the Hall of Fame. Over the years he has and continues to significantly impact the Italian-American community. Dr. Pumilia is a longtime Festa Italiana volunteer, and active in parish activities at St. Anthony of Padua Church. He has positively impacted the community by play- ing integral roles in the formation of the local Head Start Program and in the establishment of Crusader Dental Clinic. -
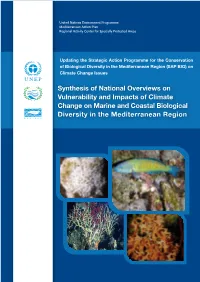
Synthesis of National Overviews on Vulnerability and Impacts of Climate
Updating the Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region (SAP BIO) on Climate Change Issues Synthesis of National Overviews on Vulnerability and Impacts of Climate Change on Marine and Coastal Biological Diversity in the Mediterranean Region Note : The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNEP concerning the legal status of any State, Territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of their frontiers or boundaries. ©2009 United Nations Environment Programme (UNEP) Mediterranean Action Plan Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA) Boulevard du Leader Yasser Arafat BP 337 –1080 Tunis Cedex –TUNISIA E-mail : [email protected] This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non- profit purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. UNEP-MAP-RAC/SPA would appreciate receiving a copy of any publication that uses this publication as a source. No use of this publication maybe made for resale of for another commercial purpose what over without permission in writing from UNEP-MAP-RAC/SPA. This report should be quoted as: UNEP-MAP RAC/SPA 2009. Synthesis of National Overviews on Vulnerability and Impacts of Climate Change on Marine and Coastal Biological Diversity in the Mediterranean Region. By Pavasovic, A., Cebrian, D., Limam, A., Ben Haj, S., Garcia Charton, J.A., Ed. RAC/SPA, Tunis; 76 pages. 1 2 CONTENTS LIST OF MAPS II LIST OF BOXES II LIST OF FIGURES II EXECUTIVE SUMMARY III 1. -
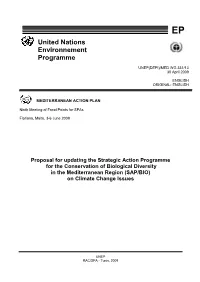
Proposal for Updating the Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region (SAP/BIO) on Climate Change Issues
EP United Nations Environnement Programme UNEP(DEPI)/MED WG.331/13 30 April 2009 ENGLISH ORIGINAL: ENGLISH MEDITERRANEAN ACTION PLAN Ninth Meeting of Focal Points for SPAs Floriana, Malta, 3-6 June 2009 Proposal for updating the Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region (SAP/BIO) on Climate Change Issues UNEP RAC/SPA - Tunis, 2009 Note: The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNEP concerning the legal status of any State, Territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of their frontiers or boundaries. The opinions expressed in this document do not necessarily represent the views of UNEP. © 2009 United Nations Environment Programme Mediterranean Action Plan Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA) Boulevard du Leader Yasser Arafat B.P. 337 - 1080 Tunis CEDEX E-mail : [email protected] The original version (English) of this document has been prepared by the Secretariat : With the international consultants Atef LIMAM (overall co-ordination and review) Sami BEN HADJ. RAC-SPA International consultant (Arabic Mediterranean cluster documentation) Jose Antonio GARCIA CHARTON, RAC-SPA International consultant (North Mediterranean non-Adriatic and Israel cluster documentation) Arsen PAVASOVIC, RAC-SPA International consultant (regional synthesis document, Adriatic cluster documentation) Francesco PITITTO* (organization of the document and review) Giovanni TORCHIA* (organization of the document and review) * NAUTILUS Cooperative UNEP(DEPI)/MED WG.331/13 Page 1 TABLE OF CONTENTS LIST OF ACRONYMS ................................................................................................................ 2 1. INTRODUCTION ................................................................................................................ 3 2. -

Seaside Emotions Art Settings
Camogli - Genoa Isola Gallinara - Savona Isola Gallinara Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria” [email protected] www.turismoinliguria.it Seaside emotions www.turismoinliguria.it Art Settings History Trail Scents and flavours Sports itineraries A sea of gardens Sailing, windsurf, diving, whale watching, or simply sunbathing: there are hundreds of sea adventures in a holiday on the Riviera. Publishing Info Publishing Project and All Rights reserved to Agenzia Regionale per la Promozione Turistica “in Liguria”. Images: Archive Agenzia “in Liguria”. Graphic Project by: Adam Integrated Communications - Turin - Printed in 2008 - Liability Notice: notwithstanding the careful control checks Agenzia “in Liguria” is not liable for the Riomaggiore reported content and information. www.turismoinliguria.it Golfo dei Poeti. The place where your soul belongs. A warm embrace of jagged coastline to the East, and quiet beaches towards Lerici - little creeks, islands, and purple-veined white rocks in Punta Bianca: Golfo dei Poeti, the land that inspired Shelley and Petrarca, is the very eastern end of Liguria, at the border with Tuscany. Bocca di Magra www.turismoinliguria.it Isola del Tino 3 Lerici. Tellaro. Luxurious resorts with wide beaches, and The ancient strongholds built to defend wonderful hotels, framed by the Genoese the city core from sea invaders, serve today Castle dating back to the 12th century, are to keep the noise away, and offer all be good reasons why this little town in a relaxing hideout on the water. Tellaro is the Riviera di Levante is considered a pearl the typical Ligurian village where the of the gulf. Chosen by D.H. -

Sub-Regional Report on Vulnerability and Impacts of Climate Change on Marine and Coastal Biological Diversity
EP Uni t e d Nations Environnement Programme UNEP(DEPI)/MED WG 331/Inf.16 25 April 2009 ENGLISH ORIGINAL: ENGLISH MEDITERRANEAN ACTION PLAN Ninth Meeting of Focal Points for SPAs Floriana, Malta, 3-6 June 2009 Sub-regional report on vulnerability and impacts of climate change on marine and coastal biological diversity in the North Mediterranean non- Adriatic countries and Israel UNEP RAC/SPA- Tunis, 2009 Note : The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNEP concerning the legal status of any State, Territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of their frontiers or boundaries. © 2009 United Nations Environment Programme Mediterranean Action Plan Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA) Boulevard du leader Yasser Arafat B.P.337 –1080 Tunis CEDEX E-mail : [email protected] The document has been prepared for the Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA), by: Compiled by: José Antonio GARCIA CHARTON With the support of: - Argyrou. ZENETOS, Greece - Bella GALIL National, Israel - Fabio BADALAMENTI, Italy (non-Adriatic coast) - Miraine. RIZZO, Duncan BORG and Stephen SALIBA, Malta - Nuria MARBA BORDALBA, Spain - Bayram OZTURK, Turkey - Myroula HAJICHRISTOFOROU, Cyprus Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... 3 LIST OF ACRONYMS ......................................................................................... -

Commission Implementing Decision
15.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Union L 51/187 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/159 of 21 January 2021 adopting the fourteenth update of the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region (notified under document C(2021) 19) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (1), and in particular the third subparagraph of Article 4(2) thereof, Whereas: (1) The Mediterranean biogeographical region referred to in Article 1(c)(iii) of Directive 92/43/EEC comprises the Union territories of Greece, Cyprus, in accordance with Article 1 of Protocol No 10 of the 2003 Act of Accession, and Malta, parts of the Union territories of Spain, France, Italy, Portugal and Croatia, and, in accordance with Article 355(3) of the Treaty, the territory of Gibraltar, for which the United Kingdom is responsible for external relations, as specified in the biogeographical map approved on 20 April 2005 by the committee set up by Article 20 of that Directive (the ‘Habitats Committee’). (2) The initial list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region, within the meaning of Directive 92/43/EEC, was adopted by Commission Decision 2006/613/EC (2). That list was last updated by Commission Implementing Decision (EU) 2020/96 (3). (3) The sites included in the lists of Community importance for the Mediterranean biogeographical region form part of the Natura 2000 network which is an essential element of the protection of biodiversity in the Union. -

Isole Italiane IIA
Isole italiane IIA La lista IIA è venuta formandosi nel corso degli anni per, potremmo dire, "stratificazioni successive". La particolare struttura dell'IIA punta al quadro complessivo, e assegna i Numeri di Riferimento anche a isole non ancora attivate e delle quali si sono avute notizie indirette provenienti da fonti diverse (carte geografiche e nautiche, portolani, pubblicazioni varie). La non omogeneità di tali fonti può inoltre creare qualche confusione o essere motivo di dubbio allorchè si tenti di identificare con certezza la posizione, delle molte isole minori, siano esse già state attivate o no: basti pensare alle omonimie, ai casi di doppia o addirittura tripla denominazione, alla difficoltà di individuazione degli eponimi di riferimento cui si è dovuto far inevitabilmente ricorso e di interpretare nomi e attribuzioni incerte e fuorvianti. A questi problemi, come si è detto riconducibili alla natura stessa dell'IIA, se ne affiancano altri, il più delle volte derivanti dal non avere a disposizione strumenti sufficientemente idonei ad accertare la conformità di alcune isole al vigente Regolamento IIA. Di conseguenza questo studio, benchè condotto con il massimo scrupolo, non pretende di essere risolutivo, nè i giudizi ivi espressi, elaborati sulla base della documentazione in nostro possesso, sono definitivi. Pertanto chi ritenesse siano stati commessi degli errori, tanto nell'attribuire quanto nel negare la validità a un'isola, è pregato di segnalare le proprie osservazioni, ovviamente producendo le prove a sostegno di tali argomentazioni. Tutti i numeri di riferimento provvisori [/p] o ancora da assegnare [???] sono considerati ex ufficio DELETED, in mancanza di una documentazione esauriente a sostegno della validità delle rispettive isole. -

Directory World Wide Flora Fauna - Updated 30 Junel 2013
Directory World Wide Flora Fauna - Updated 30 Junel 2013 Directory World Wide Flora & Fauna - Updated 30 June 2013 Release 2013.06 - by IK1GPG Massimo Balsamo & I5FLN Luciano Fusari Reference Name DXCC Continent Country Category Last Modified Note 1SFF-001 Spratly 1S AS Spratly Archipelago 3AFF-001 Réserve du Larvotto 3A EU Monaco 3AFF-002 Tombant à corail des Spélugues 3A EU Monaco 3BFF-001 Black River Gorges 3B8 AF Mauritius I. 3BFF-002 Agalega is. 3B6 AF Agalega Is. & St.Brandon I. 3BFF-003 Saint Brandon Isls. (aka Cargados Carajos Isls.) 3B7 AF Agalega Is. & St.Brandon I. 3BFF-004 Rodrigues is. 3B9 AF Rodriguez I. 3CFF-001 Monte-Rayses 3C AF Equatorial Guinea 3CFF-002 Pico-Santa-Isabel 3C AF Equatorial Guinea 3D2FF-001 Conway Reef 3D2 OC Conway Reef 3D2FF-002 Rotuma I. 3D2 OC Conway Reef 3DAFF-001 Mlilvane 3DA0 AF Swaziland 3DAFF-002 Mlavula 3DA0 AF Swaziland 3DAFF-003 Malolotja 3DA0 AF Swaziland 3VFF-001 Ain Baccouch Wildlife Reserve 3V AF Tunisia Wildlife Reserve ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-002 Ain Chirichira Natural Reserve 3V AF Tunisia Natural Reserve ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-003 Aina Zana Natural Reserve 3V AF Tunisia Natural Reserve ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-004 Bou-Hedma National Park 3V AF Tunisia National Park ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-005 Boukornine National Park 3V AF Tunisia National Park ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-006 Cap-Bon Peninsula Nature Reserve 3V AF Tunisia Nature Reserve ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-007 Iles Kouriates Nature Reserve 3V AF Tunisia Nature Reserve ASTRA-UT6UA Replaced by 3VFF-008 Iles