Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Anatomia Dell'apparato Genitale Femminile
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Foggia “Ginecologia ed Ostetricia” Prof. Felice Pietropaolo Prof. Pantaleo Greco D.ssa M. Matteo 1 Programma di Ginecologia ed Ostetricia Anatomia e Fisiologia dell’Apparato Genitale Femminile ─ Anatomia apparato genitale femminile. ─ Embriologia dell’apparato genitale femminile e malformazioni genitali. ─ Fisiologia dell’apparato genitale femminile: gli ormoni steroidei, l’asse ipotalamo- ipofisi-ovaio, il ciclo ovarico e il ciclo mestruale. ─ Fisiologia della funzione riproduttiva femminile. Ginecologia Benigna: ─ Alterazioni del ciclo mestruale: oligo-amenorrea, ipermenorrea, polimenorrea, menorragia, metrorragia, spotting intermestruale. Dismenorrea. ─ Climaterio e Menopausa: definizione, sintomatologia, indicazioni ed effetti collaterali della terapia ormonale sostitutiva. ─ Contraccezione: metodi naturali, metodi di barriera, dispositivi intra-uterini, metodi ormonali e intercezione post-coitale. ─ Sterilità ed infertilità: eziopatogenesi, classificazione e diagnosi. Cenni sulle tecniche di riproduzione assistita. ─ Infezioni dell’apparato genitale: infezioni della vulva, vaginiti, endometriti, malattia infiammatoria pelvica. ─ Endometriosi: epidemiologia, eziopatogenesi, anatomia patologica, sintomatologia, diagnosi e terapia. ─ Alterazioni della statica pelvica: anomalie di posizione dell’utero, il prolasso genitale. ─ Incontinenza urinaria femminile: classificazione, eziopatogenesi, diagnosi e cenni di terapia medica e chirurgica. Oncologia Ginecologica: - Procedure diagnostiche -

Fetus in Fetu – a Mystery in Medicine
Case Study TheScientificWorldJOURNAL, (2007) 7, 252–257 ISSN 1537-744X; DOI 10.1100/tsw.2007.56 Fetus In Fetu – A Mystery in Medicine A.K. Majhi*, K. Saha, M. Karmarkar, K. Sinha Karmarkar, A. Sen, S. Das Department of Obstetrics and Gynecology,NRS Medical College, Kolkata 700014, West Bengal, India E-mail: [email protected] Received November 10, 2006; Revised December 21, 2006; Accepted January 23, 2006; Published February 19, 2007 Fetus in Fetu (FIF) is a rare condition where a monozygotic diamnionic parasitic twin is incorporated into the body of its fellow twin and grows inside it. FIF is differentiated from teratoma by the presence of vertebral column. An eight year old girl presented with an abdominal swelling which by X-ray, ultrasonography and CT scan revealed a fetiform mass containing long bones and vertebral bodies surrounded by soft tissue situated on right lumber region. On laparotomy, a retroperitoneal mass resembling a fetus of 585 gm was removed. It had a trunk and four limbs with fingers and toes, umbilical stump, intestinal loops and abundant scalp hairs but was devoid of brain and heart. Histology showed various well-differentiated tissues in respective sites. FIF is a mystery in reproduction and it is scarce in literature in such well-developed stage. KEY WORDS: fetus-in-fetu, monozygotic diamnionic twinning, parasitic twin, teratoma INTRODUCTION Fetus in fetu (FIF) is a rare condition where a monozygotic diamnionic, parasitic twin is incorporated into the body of its fellow twin early in embryonic development and grows inside it through a vascular communication with the host circulation. -

Fetus in Fetu: a Case Report and Review of Literature
CASE REPORT Fetus in Fetu: A Case Report and Review of Literature Authors: Wobenjo A1, MBChB., Osawa F2, MBChB, MMed (Surgery), Kenyatta National Hospital. Affliation: 1. Resident Dept of Surgery, University of Nairobi, 2. Senior Registrar, Dept. Of Pediatric surgery Correspondence: Adili Wobenjo. Po. Box 286-00202 KNH, Nairobi. E-mail: [email protected] Summary Fetus-in-fetu is a rare congenital malformation in which a vertebra fetus is enclosed within the abdomen of a normally developing fetus. The preop- erative diagnosis is challenging. Less than 200 cases are reported in English literature, five in Africa. Multiple fetuses-in-fetu are less documented. We report a three month old infant who presented with an abdominal mass and constipation and taken to theatre with a preoperative diagnosis of a teratoma. At operation, the mass was a case of twin fetuses in fetu with blood supply from the aorta and the left renal artery. Total excision of the mass with special attention to its blood supply was therapeutic. We emphasize the necessity for suspicion of fetus in fetu when a well-defined encapsulated cystic mass with calcified solid components is detected by an abdominal CT scan in a child less than 2 years of age. Introduction pregnancy was uneventful and the patient was born A large solid abdominal tumor in a pediatric patient can at full term by an uncomplicated vaginal delivery. The be a big challenge for clinician because of many differ- mother started attending antenatal clinic at 6 months ential diagnoses, some of these rare (1). Fetus in fetu is and no obstetric ultrasound was done. -

APSA Fetal Handbook 2Nd Ed.Indd
Fetal Diagnosis TM and Therapy A Reference Handbook for Pediatric Surgeons 2nd Edition from the Fetal Diagnosis and Treatment Committee of the American Pediatric Surgical Association April 2019 Edited under the leadership of editor Erin Perrone, MD, and the 2016-2018 APSA Fetal Diagnosis and Treatment Committee ©2019, American Pediatric Surgical Association 1 FOREWORD This handbook is the culmination of the vision and work of those who have served on the Fetal Diagnosis and Treatment Committee of the American Pediatric Surgical Association over the past ten years. The first edition, published in 2013, was the vision of the prior chairs, Francois Luks and Hanmin Lee, and brought to fruition by the original editors Brad Feltis and Chris Muratore. This second edition, under the leadership of editor Erin Perrone and the 2016-2018 APSA Fetal Diagnosis and Treatment Committee, provides updates as the field has continued to evolve to reflect current practice. Additionally, new chapters on the “Fetal Airway” and “Anomalies of the Genitourinary Tract” have been added. Fetal diagnosis and counseling has evolved from its original niche practice to a field in which most pediatric surgeons are involved, as newborn surgical conditions are increasingly identified in the prenatal period. While very few pediatric surgeons will actually participate in prenatal treatment, most will care for patients with anomalies and malformations detected before birth. This handbook is a ready reference that provides concise information about many common fetal anomalies relevant to the pediatric surgeon. As the field is rapidly evolving, the contents of this handbook have been updated to reflect current knowledge and practice. -
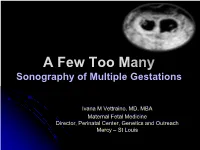
Multiple Gestations
A Few Too Many Sonography of Multiple Gestations Ivana M Vettraino, MD, MBA Maternal Fetal Medicine Director, Perinatal Center, Genetics and Outreach Mercy – St Louis Disclosures Speakers bureau March of Dimes Hologic, Inc Trainer Nexplanon I will not be discussing any of these organizations or products in this presentation 2 Objectives Define and describe the categories of multiple gestations Describe the keys to ultrasound assessment of multiple gestation Describe sonographic complications of twin gestation and other higher order multiples Introduce management of twin gestation in the prenatal period Introduction Account for 3 % of all pregnancies Incidence human pregnancies Approximately 1 in 90 births Rate varies from country to country Highest numbers - Nigeria (45 twins per 1000 live births) Lowest in Japan (4 twins per 1000 live births) United States (2016) – 33.4 twins per 1000 live births Vary by ethnic group Hispanic women 19.5 per 1000 births Non-Hispanic black women 30.0 per 1000 births Non-Hispanic white women 28.8 per 1000 births Multiple Gestation Overall rise in multiple gestations Older age at childbearing 1/3 Increasing use of infertility therapies 2/3 Triplet Data Twinning Monozygotic twins (“identical”) Develop from a single fertilized ovum Have same genetic material Rate is constant worldwide 3.5 to 4 per 1000 births 30 percent of twins Dizygotic twins (“fraternal”) Develop from more than one fertilized ovum Genetically similar as any full siblings Rate varies by ethnic background, -

L'ecografia in Ostetricia
L’ecografia in ostetricia 76 V. Parlato M. Molis L. Sorrentino Brevi cenni storici zionale, comunque utilizzato in epoca tardiva 1343 allo scopo di evitare danni fetali da energia ioniz- Per lungo tempo il feto è stato considerato zante; d’altro canto, solo l’avvento dell’ecografia oggetto inaccessibile alle tradizionali metodiche ostetrica ha consentito di indagare il feto in diagnostiche: circondato dal liquido amniotico, epoca gestazionale precoce, innescando una sorta protetto dall’amnion, dalle pareti uterine e dalla di esaltante effetto domino degli orizzonti dia- parete addominale materne, risultava inaccessibi- gnostici nonché terapeutici nel management del le per l’intera durata del periodo gestazionale; ciò feto normale e patologico: le apparecchiature di ha reso per millenni il prodotto del concepimen- ultima generazione ed il costante miglioramento to una sorta di “oggetto oscuro” dotato di poteri della professionalità degli operatori offrono oggi magici, ovvero esso stesso frutto di forze miste- l’opportunità di effettuare esami sempre più pre- riose. Nelle antiche civiltà, infatti, le anomalie cisi e di descrivere patologie embrio-fetali spesso congenite osservate alla nascita venivano inter- in epoche gestazionali precocissime; inevitabil- pretate come volontà divina e si attribuiva loro mente ciò comporta la possibilità di approntare e significato simbolico e magico, tanto da subli- perfezionare metodiche di espletamento di tera- marle, non di rado, in storie mitologiche o leg- pie intrauterine un tempo futuribili, poi pionieri- gende; la sirenomelia, ad esempio, è stata certa- stiche, oggi attuali: il feto, in tal modo è stato mente all’origine del mito delle sirene, mentre finalmente elevato a ruolo di vero e proprio dalla ciclopia scaturiva il mito dei ciclopi. -

Oropharyngeal Fetus-In Fetu in Ilero Nigeria: a Case Report
Case Report Oropharyngeal fetus-in fetu in Ilero Nigeria: A case report Adebiyi AO, Shorunmu TO1, Owoeye T2, Amoran OE, Ojeleke AA3 Department of Community Medicine, University College Hospital, Ibadan, 1Department of Obstetrics and Gynaecology, Olabisi Onabanjo University Teaching Hospital, Sagamu, 2Department of Anatomy, College of Medicine, University of Ibadan, 3Department of Primary Health Care, Kajola Local Government, Okeho, Nigeria ABSTRACT Fetus-in-fetu is a rare congenital condition in which a malformed parasitic twin is found within the body of its partner. Although a few had been documented worldwide, none has been reported in Nigeria. In this report, we document the history of a concoction of drugs of an indeterminate nature taken in pregnancy, the wrong diagnosis by the rural based sonographer and the presence of polyhydraminos. Our finding of a previously misdiagnosed oropharyngeal fetus‑in fetu with dichorionic and cardiac features calls for a revision of the current definition of fetus‑in fetu. It also raises an important hypothesis of the likely associations between drugs, infections, pregnancy induced hypertension and fetus-in-fetu. Key words: Fetal abnormality; oropharyngeal fetus-in fetu; pregnancy. Introduction (about 150 km from a specialist center). The chief complaint was persistent headache. There was associated hotness of Fetus-in-fetu is a rare congenital condition in which a the body, sore throat that has cleared, swelling of the legs, malformed parasitic twin is found within the body of its severe insomnia, and difficulty with breathing. partner.[1] It is said to represent a malformed monozygotic, monochorionic-diamniotic parasitic twin included in a Her menarche was at 20 years and her last confinement was host (or autosite) twin of which the presence of a rudimentary in year 2003. -

Multiple Pregnancies
Learning Objectives Using Ultrasound to Manage Twins After this presentation, the learner will be able to discuss: • Diagnosis and dating in twin pregnancies • Sonographic characteristics that distinguish dichorionic from monochorionic twins • Prenatal ultrasound screening in twins • Complications unique to monochorionic twins Lynn L. Simpson, MD Chief, Division of Maternal Fetal Medicine • Ultrasound surveillance recommendations for twins Columbia University Medical Center, New York Diagnosis and Dating of Twins Importance of Pregnancy Dating • Diagnosis best in the first trimester and dating optimal using crown-rump length • Timing for screening − 20% of first trimester twin pregnancies result in singleton live births and diagnostic testing − “Vanishing twin” is associated with favorable prognosis of surviving twin if dichorionic • Accurate interpretation of twin growth • If discrepancy in dates between the twins, date using the larger twin • Scheduling of twin deliveries − Avoids missing diagnosis of IUGR Types of Twins Determination of Chorionicity • All dizygotic twins are dichorionic • All monochorionic twins are monozygotic • Not all monozygotic twins are monochorionic • Optimal in first trimester − close to 100% accuracy • Incorrect assignment in up to 10% of cases when chorionicity determined in second trimester 2-3 days 3-8 days 8-13 days (28%) (70%) (1%) Lee et al, 2006 Blumenfeld et al, 2014 1 Determination of Chorionicity Intertwin Membrane • Gestational sacs • Amniotic sacs • Placenta number • Intertwin membrane • Gender -

Fetus-In-Fetu in the Pelvis: Report of a Case and Literature Review
646 Fetus-in-Fetu in the Pelvis—JHY Chua et al Case Report Fetus-in-fetu in the Pelvis: Report of a Case and Literature Review 1 2 1 JHY Chua, MRCS (Edin), M Med (Surg), CH Chui, FRCS (Glas), FAMS (Paediatr Surg), TR Sai Prasad, MRCS, MCh (Paediatr Surg), 1 2 2 AS Jacobsen, FRCS (Edin), M Med (Surg), FAMS (Paediatr Surg), A Meenakshi, MBBS , WS Hwang, MBBS, FRCP (Path) Abstract Introduction: Fetus-in-fetu is an extremely rare condition in which a malformed fetus is found in the body of its twin. To our knowledge, fewer than 100 cases have been reported. Wide variations of presentation have been described, although its embryo-pathogenesis and differentiation from a teratoma have not been well established. Clinical Picture: We describe a male neonate with a fetoid-like mass in his pelvis associated with bilateral undescended testes. The mass was detected on prenatal ultrasound scans. The diagnosis of fetus-in-fetu was considered prenatally and confirmed on a computed tomography scan after birth. Outcome: The mass was successfully excised. Histological examination, accompanied by a review of the literature, confirmed that the mass had features consistent with a fetus-in-fetu. Conclusions: Although an extremely rare clinical entity, fetus-in-fetu can be diagnosed prior to surgery with current imaging modalities. When it arises in the retroperitoneum of a male infant, it can hinder the descent of the testes. Complete excision is curative. Ann Acad Med Singapore 2005;34:646-9 Key words: Antenatal diagnosis, Teratoma, Undescended testes Case Report Postnatal ultrasonography confirmed the presence of a Baby A was delivered at 37-week and 4-day gestation via lower abdominal mass, measuring 30.8 mm x 38.2 mm in elective caesarean section. -
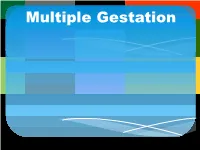
Multiple Gestation DEFINITION
Multiple Gestation DEFINITION Any pregnancy which two or more embryos or fetuses present in the uterus at same time. It is consider as a complication of pregnancy due to : ∗ The mean gestational age of delivery of twins is approximately 36w. ∗ The perinatal mortality &morbidity increase. TERMINOLOGY ∗ Singletons - one fetus ∗ Twins - tow fetuses. ∗ Triplets - three fetuses. ∗ Quadruplets - four fetuses. ∗ Quintuplets - five fetuses. ∗ Sextuplets - six fetuses. ∗ Septuplets - seven fetuses. INCIDIENCE AND EPIDEMIOLOGY ∗ The incidence of multiple pregnancy is approximately 3% (increase annually due to ART ). ∗ Monozygotic twins ( approx. 4 in 1000 births ). ∗ Triplet pregnancies ( approx. 1 in 8000 births ). ∗ Conjoined twins ( approx. 1 in 60,000 births ). ∗ Multiple gestation increase morbidity & mortality for both the mother & the fetuses. ∗ The perinatal mortality in the developed countries Twins = 5 – 10 % births. Triplets = 10 – 20 % births ∗ Hellin’s Law Twin = 1:80 Triplets = 1:80² Quadruplets = 1:80³ RISK FACTORS (only for dizygotic pregnancy) ∗ Ethnicity (afroamerican race > caucasian race > asian race) ∗ Maternal age > 35 years (due to increase gonadotrophins production) ∗ Increases with parity ∗ Heredity usually on maternal side ∗ Induction of ovulation, 10% with clomide and 30% with gonadotrophins IMPORTANT NOTES ! ∗ Monozygotic twins having same sex & blood group ∗ Process of formation of chorion is earlier than formation of amnion ∗ Dizygotic twins must be dichorionic/diamniotic. ∗ There is no dichorionic/ monoamniotic. DIZYGOTIC PREGNANCY Dizygotic twins (fraternal) : ∗ Most common represents 2/3 of cases. ∗ Fertilization of more than one egg by more than one sperm. ∗ Non identical ,may be of different sex. ∗ Two chorion and two amnion. ∗ Placenta may be separate or fused. ∗ “each fetus is contained within a complete amniotic- chorionic membrane “ DIZYGOTIC PREGNANCY MONOZYGOTIC PREGNANCY ∗ Constitutes 1/3 of twins ∗ These twins are multiple gestations resulting from cleavage of a single, fertilized ovum. -

ACR Appropriateness Criteria® Multiple Gestations
Revised 2017 American College of Radiology ACR Appropriateness Criteria® Multiple Gestations Variant 1: Known or suspected multiple gestations. Monochorionic or dichorionic. First trimester US. Procedure Appropriateness Category Relative Radiation Level US pregnant uterus transvaginal Usually Appropriate O US pregnant uterus transabdominal Usually Appropriate O US cervix transvaginal Usually Not Appropriate O US duplex Doppler pelvis Usually Not Appropriate O US assessment for TTTS Usually Not Appropriate O US pregnant uterus biophysical profile Usually Not Appropriate O US echocardiography fetal Usually Not Appropriate O Variant 2: Multiple gestations. Dichorionic. Second trimester US. Anatomy scan. Procedure Appropriateness Category Relative Radiation Level US pregnant uterus transabdominal Usually Appropriate O US cervix transvaginal Usually Appropriate O US echocardiography fetal May Be Appropriate O US duplex Doppler pelvis Usually Not Appropriate O US pregnant uterus transvaginal Usually Not Appropriate O US pregnant uterus biophysical profile Usually Not Appropriate O US assessment for TTTS Usually Not Appropriate O Variant 3: Multiple gestations. Monochorionic. Second trimester US. Anatomy scan. Procedure Appropriateness Category Relative Radiation Level US pregnant uterus transabdominal Usually Appropriate O US assessment for TTTS Usually Appropriate O US echocardiography fetal Usually Appropriate O US cervix transvaginal Usually Appropriate O US duplex Doppler pelvis Usually Appropriate O US pregnant uterus biophysical profile -

Prenatal Diagnosis of a Neonate with Fetus in Fetu
Journal of Perinatology (2006) 26, 366–367 r 2006 Nature Publishing Group All rights reserved. 0743-8346/06 $30 www.nature.com/jp IMAGING CASEBOOK Prenatal diagnosis of a neonate with fetus in fetu R Tiwari1, K Hicks2, M Naqvi1, E Biskinis1, J Nirgiotis1, J Van Hook3 and R Suffield3 1Department of Pediatrics, Texas Tech University Health Sciences Center at Amarillo, Amarillo, TX, USA; 2Texas Tech University Health Sciences Center at Amarillo, School of Medicine, Amarillo, TX, USA and 3Department of Obstetrics and Gynecology, Texas Tech University Health Sciences Center at Amarillo, Amarillo, TX, USA mass within the mid abdomen with displacement of the central Fetus in fetu is a rare condition not usually considered in the differential of bowel. A computed tomography scan of the abdomen and pelvis a neonatal abdominal mass. This article illustrates the importance of revealed a large cystic mass of size 6.4 Â 3.4 Â 4.2 cm3 prenatal ultrasound in the treatment of this condition as it facilitated the compressing the adjacent bowel. The mass also contained bony assembily of a multispecialty healthcare team that intervened within days of fragments, which appeared to be remnants of a second fetus. The birth. liver, kidney, and spleen appeared normal. Journal of Perinatology (2006) 26, 366–367. doi:10.1038/sj.jp.7211514 The patient was operated on DOL 2. The mass was in the retropancreatic area and attached to the small bowel. The gross specimen showed a fetal remnant (Supplementary Figure 2). Introduction Pathological analysis of the resected mass grossly described a Prenatal ultrasound allows for the identification of abnormalities 5.5 Â 3.0 Â 2.5 cm3 malformed second fetus encased within a that could potentially complicate the neonatal period of life.