Matese Settentrionale, Comprende I Comuni Di
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'acqua Potabile Nella Provincia Di Isernia
Provincia di Isernia assessorato all’ambiente l’acqua potabile nella Provincia di Isernia Provincia di Isernia assessorato all’ambiente l’acqua potabile nella Provincia di Isernia Pasqualino de Benedictis Provincia di Isernia assessorato all’ambiente Ideazione e realizzazione del Progetto: Ing. Pasqualino de Benedicts Dirigente Settore Ambiente ed Energia della Provincia di Isernia Si ringrazia la Dott.ssa Maria Letizia Ciallella del Dipartimento ASREM l’acquazona di Isernia potabile per la gentile concessione dei dati scientifici nellaSi ringrazia Provincia la Dott.ssa Bernardina Carrese del Dipartimento ASREM zonadi di Agnone Isernia per la gentile concessione dei dati scientifici Si ringrazia la Dott.ssa Annamaria Manuppella Dipartimento Provinciale di Isernia dell’ARPA Molise Si ringrazia la Dott.ssa Carla Amendola dell’ARPA Molise per la consulenza scientifica Si ringrazia il personale di laboratorio dell’ARPA Molise per le analisi eseguite © 2012 Evoluzionegrafica Indice Presentazione 7 Introduzione 8 1. Controlli relativi alle acque destinate al consumo umano 11 2. Caratteristiche delle acque minerali 13 3. Caratteristiche minerali delle acque della Provincia di Isernia 17 Isernia (1) 18 Isernia (2) 22 Isernia (3) 24 Isernia (4) 26 Acquaviva d’Isernia 30 Agnone (1) 32 Agnone (2) 34 Bagnoli del Trigno 36 Belmonte del Sannio 38 Cantalupo nel Sannio 40 Capracotta 42 Carovilli 44 Carpinone 46 Castel del Giudice 48 Castelpetroso 50 Castelpizzuto 52 Castel San Vincenzo 54 Castelverrino 56 Cerro al Volturno 58 Chiauci 60 Civitanova del -

Determinazione
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (PROVINCIA DI CAMPOBASSO) ORIGINALE AREA TERZA - GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO URBANISTICA. DETERMINAZIONE Prog.Gen. 108 Data 09-04-2020 Prog. Area 42 OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA SINCRONA AVENTE AD OGGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PASSIVA A BANDA ULTRA LARGA (RETE DI TELECOMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA) NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ACQUAVIVA COLLECROCE, COLLETORTO, CONCA CASALE, FILIGNANO, FORNELLI, LONGANO, MACCHIA D'ISERNIA, MACCHIA VALFORTORE, MONTECILFONE, MORRONE DEL SANNIO, SANTA CROCE DI MAGLIANO, SESSANO DEL MOLISE, TUFARA. D.LGS. N. 259 DEL 01/08/2003 (CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE), D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO), L. N. 241 DEL 07/08/1990. IL RESPONSABILE DELL’AREA RESPONSABILE DI AREA III Premesso che: - La Regione Molise, nel fare seguito alle difficoltà riscontrate sul territorio regionale dal soggetto realizzatore del Progetto Banda Ultra Larga, Open Fiber, ed al fine di assicurare un’accelerazione dell’iter amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazione, ha inteso promuovere, anche sulla base di esperienze similari di altre ragioni, l’organizzazione di Conferenze di servizi decisorie, nella forma simultanea sincrona, da convocarsi per raggruppamenti di comuni individuati da Open Fiber sulla base dell’avanzamento progettuali; - a seguito di convocazione della Regione Molise, con nota acquisita agli atti in data 18.07.2019 Prot. n° 6225, si è tenuto in data 22.07.2019, un primo incontro tra i Comuni di Acquaviva Collecroce, Colletorto, Conca Casale, Filignano, Fornelli, Longano, Macchia d’Isernia, Macchia Valfortore, Montecilfone, Morrone del Sannio, Santa Croce di Magliano, Sessano del Molise, Tufara, durante il quale è stata condivisa, unitamente ai rappresentanti presenti, la scelta di ricorrere alla Conferenza di servizi decisoria simultanea DETERMINAZIONE N. -

MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria E Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare
REGIONE MOLISE - DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare Ufficio Sicurezza Alimentare ELENCO DEGLI ALLEVATORI CHE COMPRANO IL MANGIME DA SOMMINISTRARE AGLI ANIMALI E CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DEPOSITO E STOCCAGGIO (art. 5, comma 1 Reg. (CE) n. 183/2005) ASREM - SEDE OPERATIVA DI AGNONE N. Cod_Aziendale Nome e Cognome o Ragione Sociale SEDE CODIFICA 1 002IS012 DE SIMONE VANDALINA AGNONE 4 2 002IS022 DI SABATO ROCCO AGNONE 4 3 002IS030 MARCOVECCHIO GELSUMINA AGNONE 4 4 002IS043 CELLILLI FILOMENA AGNONE 4 5 002IS044 CELLILLI FLORINDO AGNONE 4-6 6 002IS053 DI PIETRO GIANLUCA AGNONE 4 7 002IS059 GUALDIERI GIUSEPPINA AGNONE 4 8 002IS061 DI MARIO CARMINE AGNONE 4 9 002IS063 D'AGNILLO LUCIA AGNONE 4 10 002IS066 LONGHI GIOVINA AGNONE 4 11 002IS068 DI PINTO ANNAMARIA AGNONE 4 12 002IS070 LONGO IDA AGNONE 4 13 002IS079 PANNUNZIO GINO AGNONE 4-6 14 002IS081 PANNUNZIO NICOLA AGNONE 4-6 15 002IS082 PANNUNZIO TONINO AGNONE 4-6 16 002IS084 PANNUNZIO GENUINO AGNONE 4-6 17 002IS086 MARCOVECCHIO RACHELINA AGNONE 4 18 002IS087 PANNUNZIO ANGIOLINA AGNONE 4-6 19 002IS090 PALLOTTO DILIA AGNONE 4 20 002IS091 BUOSCIO GIUSEPPE AGNONE 4-6 21 002IS092 DI MENNA BINA AGNONE 4 22 002IS095 DIANA ERCOLINO AGNONE 4 23 002IS096 DIANA MICHELE AGNONE 4-6 24 002IS098 DIANA SANDRA AGNONE 4 25 002IS099 LAURIENTE BRUNO AGNONE 4 26 002IS100 ORLANDO ROCCO AGNONE 4 27 002IS101 ORLANDO ANGELO AGNONE 4-6 28 002IS103 ORLANDO CESARE AGNONE 4 29 002IS105 ORLANDO GIUSEPPE AGNONE 4 30 002IS106 ORLANDO MERCEDE AGNONE 4 31 002IS107 ORLANDO -

N. Autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA 120221/Is Prot. N
n. COMUNE OGGETTO DITTA autorizzazione REALIZZAZIONE DI UN 120221/is prot. IMPIANTO FOTOVOLTAICO BELMONTE DEL Di Rienzo e n. 15892/12 del PARZIALMENTE INTEGRATO SANNIO Masciotra N. 06/06/2012 A SERVIZIO FABBRICATO RURALE 120222/is prot. BELMONTE DEL realizzazione di un n. 15888/12 del Di Primio Michele SANNIO impianto fotovoltaico 06/06/2012 120223/is prot. costruzione linea BT in BELMONTE DEL n. 15885/12 del cavo aereo per allaccio ENEL SANNIO 06/06/2012 Sig.ra Di Luca Maria D. 120224/is prot. realizzazione di una BELMONTE DEL VODAFONE n. 15880/12 del stazione radio base per SANNIO OMNITEL N.V. 06/06/2012 telefonia cellulare 120225/is prot. costruzione di una casa Parrocchia S. Maria n. 15890/12 del PIETRABBONDANTE canonica e dei locali di Assunta 06/06/2012 Ministero Pastorale installazione di un impianto 120226/is prot. fotovoltaico della potenza n. 15282/12 del LONGANO Gatta Pasquale di 6 kw sulla copertura di 31/05/2012 un fabbricato misura 3.2.3. "Tutela e 120227/is prot. valorizzazione patrimonio n. 15352/12 del AGNONE rurale" manutenzione e COMUNE 01/06/2012 risanamento conservativo vecchia fonderia del rame inserimento parabola di 120228/is prot. una stazione radio base VODAFONE n. 15278/12 del CERRO A VOLTURNO VODAFONE con OMNITEL N.V. 31/05/2012 tecnologia UMTS 900 su infrastrutture preesistenti 120229/is prot. variante alla C.E. n. 27 del n. 15353/12 del CERRO A VOLTURNO 7.08.1989 di un fabbricato Mancini Antonio 01/06/2012 nella frazione Case 120230/is prot. sistemazione esterna area Giovannelli n. -

COMUNE Di MONTERODUNI
COMUNE di MONTERODUNI (Provincia di ISERNIA) telefono 0865/491586 Piazza Municipio telefax 0865/491391 Prot. n. 2990 Monteroduni, lì 05/06/2012 DECRETO N. 5 Oggetto : Nomina segretario comunale della sede di segreteria convenzionata di classe III tra i Comuni di Monteroduni, Sesto Campano e Longano. IL SINDACO PREMESSO che il Comune di Monteroduni con atto consiliare n. 2 del 2.4.2012, il Comune di Sesto Campano con atto consiliare n. 9 del 11.4.2012 ed il Comune di Longano con atto consiliare n. 6 del 27.3.2012, esecutivi, hanno deliberato di gestire in forma associata le funzioni di segreteria comunale approvando contestualmente lo schema di convenzione; VISTA la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra il Comune di Monteroduni, il Comune di Sesto Campano ed il Comune di Longano sottoscritta in data 30.5.2012 con decorrenza 6.6.2012 dai rappresentanti legali degli enti coinvolti, dalla quale risulta che questo ufficio, capo convenzione, è titolato nelle procedure di nomina del segretario; RICHIAMATO il proprio decreto n. 4 del 4.6.2012 con la quale questo ufficio ha proceduto alla individuazione del segretario titolare dell'ufficio di segreteria convenzionata dei Comuni Monteroduni, Sesto Campano e Longano nella persona della dottoressa Lucia Guglielmi, nata a Cassino (FR) il 7.3.1972, iscritta all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale del Molise in fascia B con idoneità alla nomina in comuni fino a 65.000 abitanti; VISTO il provvedimento della Prefettura UTG di Campobbasso ex AGES Sezione Regionale del Molise n. -

Comune Di Santa Croce Di Magliano
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (Provincia di CAMPOBASSO) Piazza Nicola Crapsi s.n.c 86047 Santa Croce di Magliano (CB) Cod.Fisc/P.Iva : 00077420701 Tel. : 0874/725218 PEC: [email protected] email : [email protected] Acquaviva Collecroce Piazza Nicola Neri Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente Protocollo Arrivo N. 326/2020 del 02-01-2020 REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE 86030 Acquaviva Collecroce [email protected] Colletorto Largo Verdi, 9 86044 Colletorto [email protected] Conca Casale Piazza Chiesa,1 86070 Conca Casale [email protected] Filignano Piazza Municipio, 7 CAP 86074 Filignano [email protected] Fornelli Via dei Martiri 86070 Fornelli [email protected] Longano Piazza G. Veneziale, 10 86090 Longano [email protected] Macchia d’Isernia Piazza Elena, 1 86070 Macchia D'Isernia [email protected] Macchia Valfortore Via Fratelli Bandiera, snc 86040 Macchia Valfortore [email protected] Montecilfone Via Roma, 109 AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO (Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata) Pagina 1 di 5 86032 Montecilfone [email protected] Morrone del Sannio Via San Roberto, sn 86040 Morrone del Sannio [email protected] Santa Croce di Magliano Piazza Nicola Crapsi 86047 Santa Croce di Magliano [email protected] Sessano del Molise Via della Chiesa, 5 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente -

N. Autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA 170215/Is Prot. N
n. autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA condono edilizio - 170215/is prot. n. immobile sito in Pozzilli, VISONE ALDO E 80231/2017 del POZZILLI strada di Bonifica, VALERIO LUIGINA 10/07/2017 Località Triverno, fg. 40 p.lle nn. 97 e 98. condono edilizio Legge 170216/is prot. n. 724/1994 - relativo a un 78760/2017 del ISERNIA fabbricato per civile PATETE MARIA 06/07/2017 abitazione in loc. Colle Vavuso. 170217/is parere negativo prot. n. MACCHIA ristrutturazione edilizia. IDRA SRL 78815/2017 del D'ISERNIA 06/07/2017 ampliamento e AGRI INSIEME 170218/is prot. n. sistemazione esterna al SOCIETÀ 78824/2017 del CASTELPETROSO fabbricato sito in c/da COOPERATIVA 06/07/2017 Valle dell'Ascia. AGRICOLA PAI “Valorizzazione delle risorse naturali e culturali del lago di Castel San Vincenzo e dei comuni limitrofi – APQ “Sistema CASTEL SAN idrico e fognario 170219/is prot. n. VINCENZO, CERRO depurativo” FSC COMUNE DI CASTEL 78836/2017 del AL VOLTURNO E 2007/2013. Attività azioni SAN VINCENZO 06/07/2017 SCAPOLI e interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno e Scapoli. costruzione linea di bassa tensione in cavo interrato 170220/is prot. n. per energizzazione ENEL DISTRIBUZIONE 78830/2017 del ISERNIA cabina ditta: EDIFICA S.P.A. 06/07/2017 DESIGNO SRL in loc. Nunziatella. SCIA n. 52/2017. Diversa distribuzione degli spazi interni, ampliamento per 170221/is prot. n. locale caldaia e 78840/2017 del ISERNIA DI TORE RAFFAELE sistemazione area esterna 06/07/2017 alla porzione di fabbricato per civile abitazione loc. -

Adp «Venafro-Campochiaro-Bojano E Aree Dell'indotto
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA AdP «Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell’indotto» Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) aprile 2017 Incentivi e Innovazione Indice Area di crisi V Contesto normativo V Comuni V Principali collegamenti V Demografia V Sistema imprenditoriale • Export • Distretti tecnologici • Focus settori di crisi V Mercato del Lavoro PRRI V Indirizzi strategici del GdCC V Progettualità del territorio V Ambiti prioritari V Bacino dei lavoratori da ricollocare 2 PRRI V Linee di intervento V Offerta localizzativa • Aree industriali disponibili • Incentivi • Politiche attive del lavoro • Infrastrutture • Semplificazione delle procedure • Sistema della conoscenza • Sistema del credito V Azioni di promozione V Azioni di monitoraggio V I soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma V Planning ALLEGATI • Allegato 1 - La progettualità del territorio • Allegato 2 - Bacino dei lavoratori (Aziende) • Allegato 3 - Aree Industriali disponibili • Allegato 4 - Strumentazione agevolativa • Allegato 5 - Sistema regionale della Ricerca ed Innovazione • Allegato 6 - Sistema del Credito 3 Area di crisi – Contesto normativo V DM 7 agosto 2015 – Riconoscimento del territorio compreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB) quale area di crisi industriale complessa , ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 27 (D.L. n. 83/2012) V DM 28 ottobre 2015 – Istituzione del Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC) composto da: MiSE DGPICPMI, MiSE DGIAI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Molise V DGR n. 125 del 23.3.2016, DGR n. -

The Extra Virgin Olive Oil Must Be Marketed in Bottles Or Containers of Five Litres Or Less
29.10.2002EN Official Journal of the European Communities C 262/9 4.8. Labelling: The extra virgin olive oil must be marketed in bottles or containers of five litres or less. The name ‘Alto Crotonese PDO’ must appear in clear and indelible characters on the label, together with the information specified in the rules governing labelling. The graphic symbol relating to the special distinctive logo to be used in conjunction with the PDO must also appear on the label. The graphic symbol consists of an ellipse enclosing, on a hill in the foreground, the bishop's palace of Acherentia, with the sky as a background. The colours used are brown 464 C for the bishop's palace, green Pantone 340 C for the hill on which it stands and blue Pantone 2985 C for the sky (see Annex). 4.9. National requirements: — EC No: G/IT/00200/2001.06.14. Date of receipt of the full application: 8 July 2002. Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2002/C 262/05) This publication confers the right to object to the application pursuant to Article 7 of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in the Member State concerned within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under point 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. -

Guardia Medica Is
SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA) Provincia di ISERNIA ACQUAVIVA D’ISERNIA SEDE RIONERO SANNITICO V. ROMA 0865 848528 AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 BAGNOLI DEL TRIGNO SEDE CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 BELMONTE DEL SANNIO SEDE AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 CAPRACOTTA V. S. FALCONI, 3 0865 949121 CAROVILLI V. FONTE RITANA,1 0865 838266 CARPINONE SEDE SESSANO DEL MOLISE V. RIMEMBRANZA 0865 930320 CASTEL DEL GIUDICE SEDE CAPRACOTTA V. S. FALCONI, 3 0865 949121 CASTEL SAN VINCENZO SEDE ROCCHETTA AL VOLTURNO P. S.DOMENICO 0865 955385 CASTELPETROSO SEDE CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 CASTELPIZZUTO SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 CASTELVERRINO SEDE AGNONE V. MARCONI,22 0865 7221 CERRO AL VOLTURNO SEDE ROCCHETTA AL VOLTURNO P. SAN DOMENICO 0865 955385 CHIAUCI SEDE SESSANO DEL MOLISE V. RIMEMBRANZA 0865 930320 CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 COLLI AL VOLTURNO V. G. MATTEOTTI 0865 957228 CONCA CASALE SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 FILIGNANO SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 FORNELLI SEDE COLLI AL VOLTURNO V. G. MATTEOTTI 0865 957228 FROSOLONE SEDE CIVITANOVA DEL SANNIO V. PIAVESE 0865 830482 ISERNIA V. S.IPPOLITO, 1 0865 442429 LONGANO SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 MACCHIAGODENA SEDE CANTALUPO NEL SANNIO V. TAVERNA 0865 814357 MIRANDA SEDE ISERNIA V. S.IPPOLITO, 1 0865 442429 MONTAQUILA SEDE VENAFRO C/O OSPEDALE 0865 907743 MONTENERO VAL COCCHIARA SEDE RIONERO SANNITICO V. ROMA 0865 848528 MONTERODUNI SEDE MACCHIA D’ISERNIA PIAZZA MUNICIPIO 0865 55273 PESCHE SEDE ISERNIA V. -

N. Autorizzazione COMUNE OGGETTO DITTA 190259/Is Prot. N. 153433/2019 Dell'11/12/2019 LONGANO RIF AUT 2011616
n. COMUNE OGGETTO DITTA autorizzazione RIF_AUT_2011616 - Costruzione linea di bassa 190259/is prot. tensione in cavo aereo per n. 153433/2019 LONGANO allaccio Granata ENEL DISTRIBUZIONE dell'11/12/2019 Gioacchino in c/da Vigne L'Abate nel comune di Longano. progetto di ristrutturazione del fabbricato per civile 190260/is prot. SENERCHIA ENRICA - abitazione sito in località n. 153437/2019 FORNELLI PETRARCA ROBERTO Annunziata e realizzazione di dell'11/12/2019 - PETRARCA SIMONA opere di sistemazione esterna. condono edilizio Legge n. 190261/is prot. 47/85 relativo al fabbricato n. 153866/2019 VENAFRO in via Salvator Rosa (ex Via GAUDIO ANTONIO del 12/12/2019 Maria Pia) - Foglio n. 18, part.lla n. 974 Sub 6. 190262/is prot. "completamento di un n. 154333/2019 MACCHIAGODENA fabbricato per civile CUCCOVIA COSIMO del 13/12/2019 abitazione". 190263/is prot. riqualificazione sostenibile n. 156091/2019 ISERNIA dell'edificio scolastico "San COMUNE del 17/12/2019 Pietro Celestino". cambio di destinazione d'uso al piano terra con lievi modifiche interne ed esterne 190264/is prot. e realizzazione di due unità n. 156850/2019 VENAFRO abitative al fabbricato sito MATTEO ELIO del 17/12/2019 nella frazione Vallecupa - località "Saurone" in catasto al foglio n. 51 part. 477 (piano casa L.R. 30/2009) progetto per la 190265/is prot. pavimentazione di una n. 156862/2019 MIRANDA COMUNE strada comunale sita in via del 17/12/2019 Antonio Evangelista. progetto di ristrutturazione edilizia mediante modifica di una parte della facciata 190266/is prot. laterale e demolizione e n. 159712/2019 POGGIO SANNITA STAFFOLI SERGIO ricostruzione di una porzione del 20/12/2019 di fabbricato sito in Via Castellano - Foglio n. -
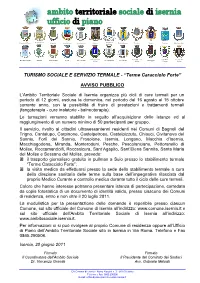
A V V I S O P U B B L I
ambito territoriale sociale di isernia ufficio di piano Cantalupo nel Civitanova Bagnoli del Trigno Carpinone Castelpetroso Castelpizzuto Chiauci Forlì del Sannio Frosolone Isernia Longano Macchiagodena Sannio del Sanio Pettoranello di Santa Maria del Sant’Elena Sessano del Macchia d’Isernia Miranda Monteroduni Pesche Pescolanciano Roccamandolfi Roccasicura Sant’Agapito Molise Molise Sannita Molise TURISMO SOCIALE E SERVIZIO TERMALE - “Terme Caracciolo Forte” AVVISO PUBBLICO L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia organizza più cicli di cure termali per un periodo di 12 giorni, esclusa la domenica, nel periodo dal 16 agosto al 15 ottobre corrente anno, con la possibilità di fruire di prestazioni e trattamenti termali (fangoterapia - cure inalatorie - balneoterapia). Le turnazioni verranno stabilite in seguito all’acquisizione delle istanze ed al raggiungimento di un numero minimo di 50 partecipanti per gruppo. Il servizio, rivolto ai cittadini ultrasessantenni residenti nei Comuni di Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise, prevede: il trasporto giornaliero gratuito in pullman a Suio presso lo stabilimento termale “Terme Caracciolo Forte”; la visita medica da effettuarsi presso la sede dello stabilimento termale a cura della direzione sanitaria delle terme sulla base dell’impegnativa rilasciata dal proprio Medico Curante e controllo medico durante tutto il ciclo delle cure termali. Coloro che hanno interesse potranno presentare istanza di partecipazione, corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido, presso ciascuno dei Comuni di residenza, entro e non oltre il 20 luglio 2011.