Scarica Il Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hidden Canals in Bologna
ro” comes from an old iron and copper beating works. In the Lock of Casalecchio di Reno - Photo Paolo Cortesi surrounding area there are many industrial archaeological fi nds: on the right bank of the canal: the remains of a rice husker and a brick kiln. And on the other the fi rst hydroelectric power station in Bologna, built in 1901. Finally, the Fornace Galotti brickworks, - novemre 2015 now restored and used as a museum. 10. Industrial Heritage Museum - Via della Beverara, 123 Built in 1887 by Celeste Ga- lotti, the brickworks with its a metropolitana bolognatipografi Hoff mann furnace was used until 1966. Th e Museum illustrates the economic history of the city and return to the river the gravel and sand that would reduce the and its surrounding area, riverbed if deposited. from the Modern to the During harsh winters, the surface spillway of Paraporto Scaletta, Contemporary Age. better known as “the ice house”, stopped sheets of fl oating ice An interesting section shows from being carried towards the city, where they could damage the how between the XV and wheels of the water mills and thus harm local industries. the XVIII centuries Bologna For further information: was a centre of silk produc- Museo del Patrimonio Industriale Consorzi dei Canali di Reno e Savena in Bologna tel. +39 051.6493527 tion, thanks to technological www.consorzireno-savena.it innovations and a system of production that used water power. Th e focal point of the section is a working model of a silk mill, scale 1:2, rebuilt to evoke the memory of this astonishing machine lost Stazione viale P. -
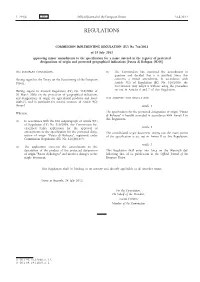
Commission Implementing Regulation (EU)
L 229/6 EN Official Journal of the European Union 24.8.2012 REGULATIONS COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 766/2012 of 24 July 2012 approving minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Patata di Bologna (PDO)] THE EUROPEAN COMMISSION, (3) The Commission has examined the amendment in question and decided that it is justified. Since this Having regard to the Treaty on the Functioning of the European concerns a minor amendment, in accordance with Union, Article 9(2) of Regulation (EC) No 510/2006, the Commission may adopt it without using the procedure Having regard to Council Regulation (EC) No 510/2006 of set out in Articles 6 and 7 of that Regulation, 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and food HAS ADOPTED THIS REGULATION: stuffs ( 1), and in particular the second sentence of Article 9(2) thereof, Article 1 Whereas: The specification for the protected designation of origin "Patata di Bologna" is hereby amended in accordance with Annex I to this Regulation. (1) In accordance with the first subparagraph of Article 9(1) of Regulation (EC) No 510/2006, the Commission has examined Italy’s application for the approval of Article 2 amendments to the specification for the protected desig The consolidated single document setting out the main points nation of origin "Patata di Bologna", registered under of the specification is set out in Annex II to this Regulation. Commission Regulation (EC) No 228/2010 ( 2). -

Mappa Opportunità Valli Del Savena Idice
A cura di: 7 Presentazione Stefano Agusto, Bruno Alampi, Caterina Benni, Paola Fornasari, Giulia Luisotti, Premessa Shaban Musaj, Barbara Pisani, Giulia Rezzadore, Eugenio Soldati, Giovanna Trombetti, Michele Zanoni coordinatore della ricerca (Area Sviluppo Economico - Città Prima parte metropolitana di Bologna) 9 Quadro conoscitivo del tessuto demografico e produttivo Grazietta Demaria dell’Unione dei Comuni Savena-Idice (Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi Strumentali - Città • Carta d’identità metropolitana di Bologna) • Il contesto demografico Fabio Boccafogli, Monica Mazzoni, Licia Nardi, Paola Varini • La struttura produttiva e il profilo delle aziende (Servizio Studi e Statistica per la Programmazione Strategica - Città metropolitana di • Movimento turistico e capacità ricettiva Bologna) • Punti salienti dell’analisi statistica Si ringraziano: UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE Viviana Boracci – Direttore Generale Indice Grazia Borghi – Area Risorse Economiche Giulia Naldi – Area Risorse Economiche Germana Pozzi – Responsabile sportello integrato Suap - Progetti d’Impresa Seconda parte ASL - DISTRETTO SAN LAZZARO DI SAVENA 34 Opportunità imprenditoriali: Paride Lorenzini – Responsabile Ufficio di Piano per la Salute ed il Benessere Sociale • Servizi alla persona ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL PATTO PER L’OCCUPAZIONE E LE • Manifattura, trasporti e servizi alle imprese OPPORTUNITÀ ECONOMICHE DELL’UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE • Agroalimentare e commercio alimentare Cia, Cna, Coldiretti, Confartigianato, -
Ferrara Di Ferrara
PROVINCIA COMUNE DI FERRARA DI FERRARA Visit Ferraraand its province United Nations Ferrara, City of Educational, Scientific and the Renaissance Cultural Organization and its Po Delta Parco Urbano G. Bassani Via R. Bacchelli A short history 2 Viale Orlando Furioso Living the city 3 A year of events CIMITERO The bicycle, queen of the roads DELLA CERTOSA Shopping and markets Cuisine Via Arianuova Viale Po Corso Ercole I d’Este ITINERARIES IN TOWN 6 CIMITERO EBRAICO THE MEDIAEVAL Parco Corso Porta Po CENTRE Via Ariosto Massari Piazzale C.so B. Rossetti Via Borso Stazione Via d.Corso Vigne Porta Mare ITINERARIES IN TOWN 20 Viale Cavour THE RENAISSANCE ADDITION Corso Ercole I d’Este Via Garibaldi ITINERARIES IN TOWN 32 RENAISSANCE Corso Giovecca RESIDENCES Piazza AND CHURCHES Trento e Trieste V. Mazzini ITINERARIES IN TOWN 40 Parco Darsena di San Paolo Pareschi WHERE THE RIVER Piazza Travaglio ONCE FLOWED Punta della ITINERARIES IN TOWN 46 Giovecca THE WALLS Via Cammello Po di Volano Via XX Settembre Via Bologna Porta VISIT THE PROVINCE 50 San Pietro Useful information 69 Chiesa di San Giorgio READER’S GUIDE Route indications Along with the Pedestrian Roadsigns sited in the Historic Centre, this booklet will guide the visitor through the most important areas of the The “MUSEO DI QUALITÀ“ city. is recognised by the Regional Emilia-Romagna The five themed routes are identified with different colour schemes. “Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali” Please, check the opening hours and temporary closings on the The starting point for all these routes is the Tourist Information official Museums and Monuments schedule distributed by Office at the Estense Castle. -

Unione Dei Comuni Savena-Idice
Unione dei Comuni Savena-Idice SUAP ASSOCIATO Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro Prot. 2016/0002550 Pianoro, 03/03/2016 Pratica SUAP n° 70/2015 Referente: Arch. Germana Pozzi INVIATA VIA PEC SPETT .LE ENERGIA VERDE S.R.L. VIA SAN CARLO N . 12/4 40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) INVIATA VIA PEC SPETT .LE ING . MEZZINI ALBERTO VIA DELLA SCALETTA N . 16 40063 MONGHIDORO (BO) INVIATA VIA PEC E.P.C. SPETT .LE COMUNE DI MONGHIDORO VIA MATTEOTTI , 1 40063 MONGHIDORO (B O) C.A. SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO INVIATO VIA PEC E.P.C. SPETT .LE SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO DELLE PROVINCIE DI BO-MO VIA IV NOVEMBRE 5 40123 BOLOGNA [email protected] INVIATO VIA PEC E.P.C. SPETT .LE COMUNE DI MONGHIDORO UFFICIO TECNICO Viale Risorgimento 1 – 40065 Pianoro (Bo) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - C.F. 02961561202 email: [email protected] email certificate: [email protected] VIA MATTEOTTI , 1 40063 MONGHIDORO (BO) [email protected] INVIATO VIA PEC E.P.C. SPETT .LE ARPAE – SAC DI BOLOGNA VIA SAN FELICE 25 40122 BOLOGNA [email protected] INVIATO VIA PEC E.P.C. SPETT .LE REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA , CACCIA E PESCA DI BOLOGNA VIALE A. SILVANI 6 BOLOGNA [email protected] INVIATO VIA PEC E.P.C. SPETT .LE AUSL – DIPARTIMENTO DI SANITA ’ PUBBLICA VIA SEMINARIO 1 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) [email protected] INVIATO VIA PEC E.P.C. -

Revisiting the Geology of the “Sillaro Line”, Northern Apennines, Italy
Rend. online Soc. Geol. It., Vol. 22 (2012), pp. 14-17, 1 figg. © Società Geologica Italiana, Roma 2012 Rendiconti online Soc. Geol. It., Vol. n (2012), n-n (Stile: intestazione prima pagina) Revisiting the Geology of the “Sillaro Line”, Northern Apennines, Italy GIUSEPPE BETTELLI (*), FILIPPO PANINI (*), CHIARA FIORONI (*), GIUSEPPE NIRTA (**), FRANCESCA REMITTI (*), PAOLA VANNUCCHI (**) & MIRKO CARLINI (°) RIASSUNTO this mélange, later reinterpreted as a tectonic mélange by REMITTI et alii (2007, 2012) and VANNUCCHI et alii (2008), Rivisitando la geologia della “Linea del Sillaro”, Appennino BETTELLI & PANINI (1992) distinguished two separate, partly Settentrionale, Italia superimposed informal chaotic units which were recognized on La “Linea del Sillaro” è il segmento nordorientale della “Linea Livorno- the base of their composition (nature, age and provenance of Sillaro” (GHELARDONI, 1965; BORTOLOTTI, 1966; NIRTA et alii, 2007) (Fig. 1A), uno dei più importanti lineamenti trasversali della catena dell’Appennino some rocks incorporated in the two chaotic units) and areal Settentrionale. In corrispondenza di questo lineamento, infatti, si può osservare distribution: the chaotic unit A and the chaotic unit B. The il sovrascorrimento della Falda Ligure sui depositi di avanfossa della basal contact of both chaotic units forming the Firenzuola Successione Umbro-Marchigiana-Romagnola (BRUNI, 1973; DE JAGER, 1979; mélange with the underlying middle to upper Miocene LANDUZZI, 2006). La “Linea del Sillaro” rappresenta, quindi, un’area chiave per la comprensione dei tempi e meccanismi del progressivo avanzamento foredeep succession was recognized of tectonic origin della Falda Ligure sui depositi di avanfossa durante il Miocene e Pliocene. (BETTELLI & PANINI, 1992). On the contrary, the nature of the contact between the two chaotic units forming the Firenzuola mélange remained an unsolved problem. -

Stability and Numerical Modelling of the “King Tiberius” Cave at Riolo Terme (Ravenna-IT)
Risk Analysis VII PI-273 Stability and numerical modelling of the “King Tiberius” cave at Riolo Terme (Ravenna-IT) N. Sciarra1, M. Mangifesta1, A. Fanti1 & R. Margutti2 1Department of Geotechnology, Chieti-Pescara University, Italy 2Saint-Gobain BPB Italia S.p.A - Cinisello Balsamo, Italy Abstract This paper deals with the geo-mechanical characterization and the numerical modelling of the “King Tiberius” natural cave. The so named “Grotta di Re Tiberio”, located near the gypsum quarry of “Monte Tondo”, in Borgo Rivola in the village of Riolo Terme (Ravenna Province – north-east Italy) is the most famous and celebrated natural cavity of the Regional Park of the Vena del Gesso, because of archaeological evidence attesting to the presence of man over several millennia (Age of Copper). The cavity, which is due to karsts phenomena occurring in the Gypsum formation, is more than 4 km long and is easily explored only for a stretch of about 60 m up to the astonishing “Gothic Chamber”. The underground mining of gypsum, which happens within the “Monte Tondo” for more than 20 km, has caused, below the natural cavity, the collapse of a portion of pavement affected by archaeological remains. This has involved the structural analysis of the rock and the stability of the system (natural and anthropic cavities) in correspondence of the “Re Tiberius” cave. The conducted tests have involved the difficult reconstruction of the underground physical model and a numerical modelling of a significant portion of rock mass in order to propose some remedial works to safeguard and preserve the area. The modelling was implemented using a numerical code (FLAC_3D) at finite differences. -

The Bolognese Valleys of the Idice, Savena and Setta
3_ eo_gb 0 008 3: 0 ag a The Bolognese Valleys of the Idice, Savena and Setta 114 _ dce_gb 0 008 3: 9 ag a 5 The Rivers the Futa state highway SS 65 and the road The valleys of the tributaries to the right of along the valley-bottom, which continues as the Reno punctuate the central area of the far as the Lake of Castel dell’Alpi, passing the Bolognese Apennines in a truly surprising majestic Gorges of Scascoli. Along the river, variety of colours and landscapes. They are there are numerous mills, some of which can the Idice, Savena and Setta Rivers, of which be visited, constructed over the centuries. only the Idice continues its course onto the Before entering the plains, the Savena cros- plains, as far as the Park of the Po Delta. ses the Regional Park of Bolognese Gypsums and Abbadessa Gullies, which is also crossed The Idice by the River Idice. The Idice starts on Monte Oggioli, near the Raticosa Pass, and is the largest of the rivers in these valleys. Interesting from a geologi- cal and naturalistic point of view, its valley offers many reasons for a visit. Particularly beautiful is the stretch of river where it joins the Zena Valley: this is where the Canale dei Mulini (mills) branches off, continuing alon- gside it until it reaches the plains, in the ter- ritory of San Lazzaro di Savena. Flowing through the Valleys of Campotto, the Idice finally joins the Reno. Here an interesting system of manmade basins stop the Reno’s water flowing into the Idice’s bed in dry periods. -

Belle Spages
Wine and tourism:new perspectives for vineyard areas in Emilia-Romagna SilviaGATTI Fabrizio INCERTI Mirko RAVAGLI Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 62, 2002 Silvia GATTI*, Fabrizio INCERTI*, Mirko RAVAGLI* Vinettourisme: Résumé –L’Emilie-Romagne représente l’une des régions les plus importantes nouvelles perspectives d’Italie pour la production viticole, avec 12% de la productiontotale, 15% des pour les vignobles exploitations viticoles italiennes et 30% de la superficie,sachant que le vignoble d’Emilie-Romagne détient la valeur record de 63% des vignes concentrées dans la plaine. Il existe une réelle nécessité de réorganiser ce vignoble, en identifiant et en créant de nouvelles opportunités d’emplois tout en améliorant les circuits commerciaux. Contrairement aux solutions apportées dans les années 60 qui ont conduit àl’exode rural, une forte volonté se manifeste afin d’améliorer la qualification, la promotion et la valorisation du terroir àpartir d’un nombre très diversifié d’activités. Le vin représenteaujourd’hui un outil de communication et d’attraction touris- tique pour les zones rurales. La réalisation d’un projet intégré sur la production viticole et le tourisme (tel que les routes du vin) pourrait fournir une solution d’avenir pour développer la promotion du territoire et créer de réelles opportunités de développement. Al’aide d’une méthodedeclassification hiérarchique, inspirée Mots-clés: de l’approche de Ward, nous cherchons àidentifier les différentes sous-régions de vin, tourisme, analyse Romagne de vins DOC et DOCG qui montrent les éléments essentiels favorables multivariée àlamise en place de véritables politiques de tourisme du vin. Wine and tourism : Summary –The wine grape growing sector of the Emilia-Romagna region is one of the new perspectives for most relevant at national level, as it produces 12 %ofthe total Italian production. -

Research Collection
Research Collection Doctoral Thesis Erosion and weathering of the Northern Apennines with implications for the tectonics and kinematics of the orogen Author(s): Erlanger, Erica Publication Date: 2020 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-b-000393261 Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. For more information please consult the Terms of use. ETH Library Diss. ETH No. 26370 Erosion and weathering of the Northern Apennines with implications for the tectonics and kinematics of the orogen Erica Danielle Erlanger Cover artwork by Reed Olsen DISS. ETH NO. 26370 Erosion and weathering of the Northern Apennines with implications for the tectonics and kinematics of the orogen A thesis submitted to attain the degree of DOCTOR OF SCIENCES of ETH ZURICH (Dr. sc. ETH Zurich) presented by ERICA DANIELLE ERLANGER Master of Science, Purdue University born on 22.03.1986 citizen of France and the United States of America accepted on the recommendation of Prof. Dr. Sean D. Willett Prof. Vincenzo Picotti Prof. Sean F. Gallen Prof. Dr. Frank J. Pazzaglia 2020 2019 Abstract Mountainous landscapes reflect the competition between denudation, uplift, and climate, which produce, modify, and destroy relief and topography. Bedrock rivers are dynamic topographic features and a critical link between these processes, as they record and convey changes in tectonics, climate, and sea level across the landscape. River incision models, such as the stream power model, are often used to quantify the relationship between topography and rock motion in the context of landscapes at steady state. -

High Resolution Numerical Simulations at the Reno Rivermouth (Italy): Model Set up and Simulations Under Climate Change Scenarios
Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-2595, 2017 EGU General Assembly 2017 © Author(s) 2017. CC Attribution 3.0 License. High resolution numerical simulations at the Reno rivermouth (Italy): model set up and simulations under climate change scenarios Renata Archetti (1,2), Achilleas Samaras (2,3), M. Gabriella Gaeta (2,3), Davide Bonaldo (4), and Sandro Carniel (4) (1) DICAM, UNIVERSITY OF BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY ([email protected]), (2) CONISMA, ITALY, (3) CIRI Edilizia e Costruzioni, UNIVERSITY OF BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, (4) ISMAR, CNR. VENEZIA, ITALY The paper presents some results obtained within the framework activities foreseen by the "RITMARE Phase II" Flagship Project, one of the National Research Programmes funded by the Italian Ministry of University. More specifically, as part of the activities planned by the Research Line "Coastal erosion, vulnerability and adap- tation to sea level rise and climate change", the work presents the setup and implementation of high-resolution numerical simulations of the nearshore dynamics of an Adriatic sea test site, under representative and extreme wave events and sea level rise scenarios. The selected study site is the mouth of the Reno river, located along the coast of Emilia Romagna Region, an ex- tremly dymanic area that in the last decated has suffered strong erosion processes and is exposed to several climate change related effects. This first part of the presentation deals with the study site description, while in the second part the coupled wave – 2D hydrodynamics model set up and implementation (using the open-source TELEMAC suite) is dicsussed and presented. In the results discussion, specific attention is devoted to simulations of expected modifications to the area dynamics as a response to expected climate change scenarios.. -

Testing a Calibration Approach for a Limited-Area
TESTING A CALIBRATION APPROACH FOR A LIMITED-AREA ENSEMBLE PRECIPITATION FORECAST USING REFORECASTS Tommaso Diomede, Chiara Marsigli, Andrea Montani, Tiziana Paccagnella ARPA-SIMC, HydroMeteorological and Climate Service of the Emilia-Romagna Regional Agency for Environmental Protection, Bologna, Italy E-mail: [email protected] Objective To implement a calibration technique for the precipitation output provided by COSMO-LEPS, the Limited-area Ensemble Prediction System based on the model COSMO. To investigate the potential of using reforecasts for the calibration of the ensemble precipitation forecast, especially with respect to the improvement of the forecast skill for rare events. To test three calibration techniques: Cumulative Distribution Function based corrections, Linear Regression and Analogs. Calibration strategy methodologies study areas data collection • choice of methodologies which enable a calibration of 24h quantitative precipitation • Emilia-Romagna Region (Northern Italy) • Observed precipitation forecasts (QPFs), not only of the probabilities of exceeding a threshold • Switzerland • Emilia-Romagna Region (1971-2007) aim: • Germany • Switzerland (1971-2007) • Germany (1989-2007) –improvement of COSMO-LEPS QPFs especially as an input for hydrological applications • COSMO-LEPS reforecast QPFs • 30 years (1971-2000) • selected methods: • 1 member, nested on ERA40, COSMO v4.0 • 1 run every three days (forecast range 90h) - Cumulative Distribution Function based corrections (CDF) [m] - Linear Regression (LR) • COSMO-LEPS