TUGLIE, Origini, Storia, Tradizioni.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Donne E Agricoltura in Provincia Di Lecce Un'intensa Attività Di Valorizzazione, Promozione E Fruizione Delle Risorse Del Te
PSR REGIONE PUGLIA 2007-2013 - ASSE III - MISURA 331 AZIONE 2 ANNO III - N° 1 - DICEMBRE 2014 IL PERIODICO DEL GAL SERRE SALENTINE PER LO SVILUPPO RURALE La Rivista Rurale delle Serre Salentine ANNO 3 - n° 1 - DICEMBRE 2014 - Chiuso in redazione il 22/12/2014 Responsabile: Gianpiero Pisanello - Direzione: Alessia Ferreri -Redazione a cura dello staff GAL “Serre Salentine” ///// Contatta la redazione: [email protected] UN’INTENSA ATTIVITÀ Prodotti Artigianali”. DONNE E AGRICOLTURA La Misura 312 “Sostegno allo sviluppo DI VALORIZZAZIONE, e alla creazione delle imprese” è stata IN PROVINCIA DI LECCE PROMOZIONE E attuata con il finanziamento di 11 inter- Il recente sesto venti (192.864, 35 euro) per l’Azione 1 FRUIZIONE DELLE RISORSE Censimento “Artigianato tipico Locale”; 10 interventi dell’Agricoltura ha DEL TERRITORIO con 165.348,06 euro nell’Azione 2 “Com- confermato il ruolo mercio di prodotti tipici” e con l’Azio- centrale, per la ne 3 “Servizi alla popolazione” che, con Provincia di Lecce, 123.412,16 euro, ha finanziato 7 interventi. dell’economica L’”Incentivazione di attività turistiche” è agricola ed il suo stata sostenuta dalla Misura 313. L’Azione indotto. 1 “Creazione di Itinerari”, finanziando 6 co- AVV. ALESSIA FERRERI Nel complesso la DIRETTORE GAL muni (Casarano, Alliste, Racale, Taviano, SERRE SALENTINE superficie agricola Matino e Galatone) con 763.225,82 euro. utilizzata (SUA) dalle L’Azione 2 prevede la nascita di 8 “Centri aziende agricole della provincia di Lecce di informazione e accoglienza turistica” a corrisponde al 54,2 % dell’intera superficie Gallipoli, Casarano, Taviano, Racale, Mati- territoriale provinciale; le aziende agricole no, Alliste, Tuglie e Galatone per un finan- censite nella provincia di Lecce sono 71.060, ziamento di 1.092.567,23 euro. -

Delibera Di Approvazione
Deliberazione n° 133 del 02-07-2019 COMUNE DI TUGLIE PROVINCIA DI LECCE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Avvio del procedimento per la formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Tuglie - Approvazione Atto di indirizzo comprensivo del Documento SCOPING. L’anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la presenza dei Sigg.: STAMERRA MASSIMO ROMANO SILVIA GABELLONE ANTONIO MARIA SOLIDA FRANCESCA GUIDO LUCA Assenti: e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giacomo Mazzeo. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i pareri allegati. ======================================================================= LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: • l’Am ministrazione Comunale di Tuglie intende procedere con l'approvazione dell'Atto di Indirizzo comprensivo del Documento di Scoping, nell'ambito della procedura di redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) di cui alla L.R. 20.01; • la G iunta Regionale della Puglia, con propria deliberazione n. 1328 del 03/08/2007, ha approvato il “Documento regionale di assetto generale (DRAG) – Indirizzi e criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG)” , nell’ambito del quale viene disciplinato l’avvio al procedimento di elaborazione del PUG, mediante l’adozione da parte della Giunta Municipale di un “Atto di Indirizzo” comprensivo del Documento di Scoping nel quale: 1. siano determinati gli obiettivi, espressione della volontà politica dell’Amministrazione Comunale; 2. -

Elenco Professionisti Aggiornato Al 31/12/2018
ELENCO PROFESSIONISTI AGGIORNATO AL 31/12/2018 _PROFESSIONISTA_ INDIRIZZO 1 Geom Abate Francesco Maglie (LE) 2 Ing Abati Michela Serena Via Vespucci 43 - Galatone 3 Soc AC2 Architetti Associati C.so due mari - Taranto 4 Arch Accoto Massimo Lecce 5 Geom Agricola Alessandro Casarano 6 Geom Albanese Alessio Via Piave 30 - 73010 Lequile (LE) 7 Ing Albanese Massino Via Monte S. Michele 1/A - 73100 Lecce 8 Geom Albanese Salvatore Via A. Genovesi 16 - Nardò (LE) 9 Ing Alemanno P. C.so Umberto I 53 - 73047 Monteroni (LE) 10 Ing Alemanno Romina Via Giannone 3 - 73048 Nardò (LE) 11 Arch Alfieri Salvatore Via Pascoli 13 - 73020 Carpignano S.no - (LE) 12 Ing Amato Andrea via Sardegna, 20 - Scorrano 13 Arch Ampolo Enrico Lecce 14 Ing Angelini Franco Uggiano la Chiesa 15 Arch. Antonucci Francesco Lecce 16 Ing. Antonucci Giorgio Vernole - fraz. Pisignano - via Umbria 17 Ing Apollo Aldo Pio Via Vecchione 7 - 71036 Lucera (FG) 18 Arch. Aresta Giulio Via Nicola Cataldi 25 - Lecce 19 Ing Arigliano Selenia Via Diaz, 117 - Salve 20 Soc Astra Engineering Via S. F. Saverio 6 - 73013 Galatina (LE) 21 Arch Avantaggiato Sabrina Via A. De Gasperi 121 - Corigliano d'Otranto (LE) 22 Arch Aventaggiato Mauro Lecce 23 Ing Baglivo Cristina Tricase 24 Ing Barbara Marco Via S.D. Savio, 7 - Lecce 25 Ing Basile Cataldo Via Garibaldi 54 - 73010 Porto Cesareo (LE) 26 Ing Basile Marcello Via Plinio 89 - 74100 Taranto 27 Ing Battista Vito Dario Piazza Ludovico Ariosto - Lecce 28 Geol Belgiorno Antonia Presicce 29 Ing Bellomo Giorgio Via Castromediano 132 - 70126 Bari 30 Ing Benizio Giambattista Neviano (LE) 31 Arch Bidetti Stefano Via Grassi 145 - 73017 Sannicola (LE) 32 Arch Blanco Francesca via Solferino 23 - 73011 Alezio (LE) 33 Ing Bleve Aldo Via Regina Elena 69 - 73020 S. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2015
Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) AGRUMETO 25000,00 23900,00 BOSCO D`ALTO FUSTO 13500,00 13500,00 BOSCO MISTO 11000,00 CANNETO 5300,00 FICHETO 7900,00 6800,00 FRUTTETO 18200,00 16000,00 INCOLTO PRODUTTIVO 5500,00 MANDORLETO 10000,00 ORTO 18200,00 14100,00 PASCOLO 4500,00 4500,00 PASCOLO CESPUGLIATO 4800,00 4800,00 SEMINATIVO 7900,00 6800,00 SEMINATIVO ARBORATO 8700,00 7600,00 SEMINATIVO IRRIGUO 15600,00 13300,00 Pagina: 1 di 8 Ufficio del territorio di LECCE Data: 13/04/2016 Ora: 9.11.26 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2015 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 PIANURA DI COPERTINO PIANURA DI LECCE Comuni di: ARNESANO, CAMPI SALENTINA, CARMIANO, Comuni di: LECCE, CALIMERA, CANNOLE, CARPIGNANO COPERTINO, GUAGNANO, LEVERANO, MONTERONI DI LECCE, SALENTINO, CASTRI DI LECCE, CAVALLINO, LIZZANELLO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SAN PIETRO IN LAMA, VEGLIE MELENDUGNO, SQUINZANO, SURBO, TREPUZZI, VERNOLE COLTURA Valore Sup. -
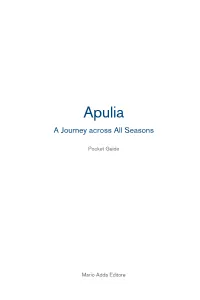
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Candidati Per L'elezione Diretta Del Presidente Della Giunta Regionale
COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0032901 - Ingresso - 11/09/2020 - 17:03 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI LECCE CANDIDATI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 5 CONSIGLIERI REGIONALI (Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni) CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 1. BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO 2. EMILIANO MICHELE 3. LARICCHIA ANTONELLA 4. FITTO RAFFAELE 5. CESARIA NICOLA 6. D’AGOSTO ANDREA 7. CONCA MARIO 8. SCALFAROTTO IVAN detto PIERFRANCO Bari 23-07-1959 Bari 01-05-1986 Maglie 28-08-1969 Milano 02-07-1959 Salerno 03-09-1964 Esslingen (Germania) 03-05-1971 Pescara 16-08-1965 San Lorenzo del Vallo 18-01-1955 LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE -

Atto Di Indirizzo Tuglie
COMUNE DI TUGLIE Provincia di Lecce PUG (Piano Urbanistico Generale) ATTO DI INDIRIZZO Comune di Tuglie (Le) - P.U.G. - ATTO DI INDIRIZZO Premessa Il presente documento, essenziale ai fini dell’avvio del procedimento per la formazione del PUG, viene predisposto secondo le indicazioni del DRAG, di cui alla D.G.R. n. 375/2007 “Schema di Documento Regionale di Assetto Generale (Drag) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento ed il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)” . Proceduralmente tale documento è assentito, unitamente al Documento di Scoping, atto propedeutico alla procedura di VAS, con Delibera della Giunta Municipale, 1^ atto per la redazione del PUG. Il successivo paragrafo A, da intendersi solo quale premessa, sintetizza la nuova forma dello strumento di governo del territorio. A. La nuova forma del Piano Urbanistico Generale (PUG) La nuova forma di piano, delineatasi con la L.R. n° 20/2001 e confermata dal DRAG, segna una netta cesura con i piani ispirati dalla L.R. 56/80, inaugura una nuova stagione dell’urbanistica in Puglia e si allinea con i modelli più moderni ormai da tempo in vigore in altre regioni. Il nuovo strumento supera l’ispirazione “regolativa” dei PRG volta precipuamente a regolamentare l’attività edilizia e introduce il concetto di tutela e sviluppo dell’intero territorio analizzato non solo nell’ambito dei confini comunali, ma nel contesto di area vasta nel quale si trova. Il PUG è articolato in una “parte strutturale”, che comprende il sistema di conoscenze, la loro interpretazione e le relative previsioni, ed in una “parte programmatica”, che detta le previsioni del futuro sviluppo del territorio. -

Classifica Generale Atlete: Elenco Altri Atleti Premiati
Classifica società: Classifica generale atleti: A.S. ACTION RUNNING MONTERONI punti 45002 ZAMINGA SANTINO GYMNASIUM S. PANCRAZIO TRE CASALI SAN CESARIO punti 32194 CONTE ANDREA ATLETICA SURBO ATLETICA SURBO punti 30712 BERGAMO CRYSTIAN ASD LA MANDRA CALIMERA OTRANTO 800 punti 21429 ASD LA MANDRA CALIMERA punti 21356 Classifica generale atlete: DELL`ANNA SIMONA A.S. ACTION RUN MONTERONI ATL. AMATORI CORIGLIANO punti 21287 SCATIGNA ALESSANDRA SALENTO IS RUNNING CLUB CORRERE GALATINA punti 19343 GARGIULO MARIA C.U.S. LECCE Elenco altri atleti premiati: GERARDI MARCO AMATORI CASTRIGNANO DE` GRECI GEMMA EMANUELA TRE CASALI SAN CESARIO CIANCI EMANUELE OTRANTO 800 D`ANTICO SILVIA OTRANTO 800 HOSSEINI SADDIQ NUOVA ATLETICA COPERTINO BOVINO MARINA ASD LA MANDRA CALIMERA DE PASCALIS FRANCESCO S.S.GRECIA SALENTINA OCCHIBIANCO STEFANIA TRE CASALI SAN MARTANO CESARIO FRANCO FRANCESCO ATL. AMATORI CORIGLIANO MELLO MIRIAM S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI SERIO ORONZO ATLETICA SURBO MELE FRANCESCA CLUB CORRERE GALATINA FIORENTINO ORESTE GABRIELE ASD CURSORES SPEDICATO LUIGINA A.S. ACTION RUNNING CANDIDO ANTONIO A.S. ACTION RUNNING MONTERONI MONTERONI NEGRO ALESSANDRO ATLETICA CAPO DI LEUCA PERRONE GIOVANNA ATLETICA SURBO MICCOLI PIERO NUOVA ATLETICA COPERTINO GRECO PAMELA SARACENATLETICA ROSATO SIMONE A.S. ACTION RUNNING MONTERONI MICOCCI LUCIA DOMENICA POLISPORTIVA BPP APRILE ARMANDO ATLETICA SURBO SANTESE CINZIA ASD LA MANDRA CALIMERA CIURLIA ROMEO GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO VENUTI ROSANNA A.S. PODISTICA TUGLIE DE BENEDITTIS ANGELO A.S.D. PODISTICA SOLETUM CUPPONE LAURA A.S. PODISTICA TUGLIE SORRENTO MARCELLO TRE CASALI SAN CESARIO PETRELLI ANNAMARIA TRE CASALI SAN CESARIO LORENZO PIER LUIGI S.S. A.V.I.S. -

PROGRAMMA COMPLETO 2021 Copia
web.it Salento Book Festival 11ª EDIZIONE SI RIACCENDONO LE LUCI SULLA CULTURA ARADEO · CASTRO · CORIGLIANO D’OTRANTO · GALATINA GALATONE · GALLIPOLI · NARDÒ · PARABITA · TRICASE · TUGLIE Organizzato da: Sostenuto da: Sostenuto da: Con il Patrocinio di: ORDINE DEI GIORNALISTI Comune di Città di Comune di Città di Città di Città di Città di Città di Città di CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA ARADEO CASTRO CORIGLIANO GALATINA GALATONE GALLIPOLI NARDÒ PARABITA TRICASE Salento d’Amare D’OTRANTO www.salentobookfestival.it | #salentobookfest2021 | #WeAreinPuglia | #PugliaEvents PROGRAMMA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021 ARADEO CASTRO Salento CORIGLIANO Book GALATINA 11ª EDIZIONE GALATONE Festival GALLIPOLI NARDÒ PARABITA TRICASE TUGLIE Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria. Per prenotarsi è necessario collegarsi al sito www.salentobookfestival.it Ricordiamo la puntualità e l’uso della mascherina. Salento Book Festival 11ª EDIZIONE Incontro con MASSIMO BERNARDINI Intervista a cura di LUCA BIANCHINI 26 GIUGNO GALATINA Ore 20.30 Piazzetta Galluccio Ex Compl. Monastico Carisse di S. Chiara RITANNA ARMENI “Per strada è a felicità” (Ponte alle Grazie) 26 GIUGNO PROGRAMMA GALATINA Ore 21.30 Piazzetta Galluccio GIUGNO Ex Compl. Monastico Carisse di S. Chiara LUGLIO AGOSTO DANIELA TAGLIAFICO 2021 “Le coniugazioni del potere” (Mazzanti Libri) 27 GIUGNO CORIGLIANO Ore 20.30 Castello Voante GABRIELLA GENISI “La regoa di Santa Croce” (Rizzoli) 27 GIUGNO CORIGLIANO Ore 21.30 Castello Voante ARADEO CASTRO CORIGLIANO GALATINA GALATONE GALLIPOLI NARDÒ PARABITA TRICASE TUGLIE Salento SI RIACCENDONO Book LE LUCI SULLA CULTURA Festival 11ª EDIZIONE ORIETTA ANDREA BERTI VIANELLO “Tra bandiere rosse e acquasantiere” “Ogni paroa che sapevo” (Rizzoli) (Mondadori) Intervista a cura di DON LUCA COLOMBO 8 LUGLIO 28 GIUGNO GALATINA Ore 20.30 PARABITA Ore 20.30 Piazzetta Galluccio Cortile Basilica Madonna dela Coltura Ex Compl. -

La Civiltà Romana Le Invasioni - L'impero Bizantino: L Basiliani - Dai Normanni Agli Aragonesi
REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO P.l. E CULTURA C.R.S.E.C. DISTRETTUALE LE/48 - GALLIPOLI JONICA CINQUE CENTRI TRA TERRITORIO E STORIA JONICA Cinque centri fra territorio e storia Eugenio Giustizieri architetto - Sannicola (LE) Francesco Gnoni architetto - Tuglie (LE) stampa Grafo 7 Editrice s.r.l. - Taviano (LE) Novembre 1988 Si ringrazia, la dott.ssa Maria Paola Mezzi per la gentile e preziosa collaborazione. © 1988 - Diritti riservati della Regione Puglia Pubblicazione fuori commercio. Seguendo le direttive dell'Assessorato alla P.l. e Cultura della Regione Puglia e convinti che l'attenzione portata sulla realtà locale è preminente nel loro lavoro, gli Operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali hanno progettato una ricerca mirata alla rilevazione e valorizzazione del patrimonio culturale - architettonico presente nei Comuni di Alezio, Gallipoli. Sannicola. Taviano e Tuglie. ·Per tale progetto ci si è affidati alla competenza degli architetti Eugenio GIUSTIZIERI e Francesco GNONI. l due professionisti non hanno preteso di fare un rilevamento completo ma. su un quadro tracciato per linee generali, hanno posto in evidenza gli aspetti più significativi di un patrimonio ricco in origine e che oggi sempre più è abbandonato al degrado. Le finalità dell'iniziativa sono essenzialmente due: richiamare l'attenzione, a livello informativo, su quanto costituisce un bene comune da difendere; sollecitare, nei più attenti e nei più sensibili. ascolto ed intervento a difesa della memoria storica che è anche stimolo per il presente. Gli Operatori del CR.S.EC Distr.!e di Gallipoli Presentazione Un territorio come quello di cui tratta questa pubblicazione possiede memorie da condizionare in modo determinante il futuro. -

1 Classe 1890 I Categoria Cognome Nome Comune Matricola Vol. Abate
Archivio di Stato di Lecce Classe 1890 I categoria Cognome Nome Comune Matricola Vol. Abate Ildebrando Maglie 31460 193 Abbaterusso Agostino Soleto 32407 195 Abejean Giuseppe Lecce 31191 bis 198 Accogli Donato Casarano 31130 193 Accogli Giuseppe Andrano 32672 195 Accogli Grazio Andrano 32671 195 Accogli Ippazio Montesano 31954 194 Accogli Oronzo Andrano 31783 194 Accoto Dante Minervino 31821 194 Acerno Francesco Maglie 31488 193 Acerno Giovanni Maglie 31552 193 Acerno Giovanni Battista Maglie 29631 bis 196 Acquaviva Fioravante Casarano 31114 193 Adami Vito Corigliano d’Otranto 29703 191 Adamo Pasquale 31072 bis 198 Adamuccio Oronzo 31037 bis 198 Adriani Michele San Cesario 29228 191 Adrisano Lorenzo Brindisi 30037 191 Affinito Enrico Lecce 32162 194 Agostinelli Domenico Ceglie Messapica 30128 191 Agostinelli Oronzo Brindisi 30035 191 Agostinello Fedele Tricase 31362 bis 198 Agrimi Pasquale Lecce 30958 192 Agrosi Oronzo Maglie 31503 193 Agrosi Vincenzo Cannole 29442 bis 195 Ala Luciano Salice Salentino 31581 bis 199 Ala Pompilio Campi Salentina 32316 194 Albano Pancrazio Veglie 31604 bis 199 Albano Pasquale Nardò 31580 193 Albano Raffaele Lecce 32514 195 Alemanno Cosimo Gallipoli 31571 bis 199 Alemanno Giovanni Nardò 31604 194 1 Archivio di Stato di Lecce Classe 1890 I categoria Cognome Nome Comune Matricola Vol. Alemanno Salvatore Sannicola 31434 193 Alessandrello Tommaso Palmariggi 29547 191 Alessandri Luigi Maglie 29234 bis 195 Alessandri Oronzo Uggiano La Chiesa 29572 191 Alessandrì Salvatore Maglie 31519 193 Alessandrini Domenico Galatina -

TAV. 5 Bis Metri Gli Istituti Rappresentati Cartograficamente Fanno Riferimento Alle Sole Aree "Confermate" Dal Piano
ISTITUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2017 – 2022 – PROPOSTA AGGIORNAMENTO PROVINCIA DI LECCE Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali - Servizio Caccia 2760000 4500000 2780000 4490000 2800000 4480000 2820000 4470000 2840000 4460000 LEGENDA OASI DI PROTEZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE 38 - BOSCO PECORARA Sup. 907.80 Ha 39 - BOSCO SERRA DEI CIANCI Sup. 421.24 Ha 40 - LECCE TANGENZIALE EST Sup. 893.12 Ha 41 - MADONNA CONSOLAZIONE - LE COLONNE Sup. 315.78 Ha 0 0 0 42 - MANCARELLA Sup. 292.76 Ha 0 0 5 4 43 - MASSERIA CORILLO Sup. 109.24 Ha 0 44 - MASSERIA DONNA TERESA / AUTOPISTA EX FIAT Sup. 1494.56 Ha 0 0 0 5 4 45 - MASSERIA LA LAMA Sup. 940.46 Ha 4 59 46 - MASSERIA LI BELLI Sup. 259.73 Ha 47 - MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891.58 Ha LECCE 48 - MASSERIA POMPEA O GRANDE Sup. 416.06 Ha SQUINZANO 49 - MASSERIA SANTI DIMITRI Sup. 259.69 Ha Provincia Brindisi 50 - MASSERIA TONDA Sup. 529.21 Ha SURBO 40 51 - MASSERIA ZANZARA Sup. 258.15 Ha TREPUZZI VERNOLE 52 - MASSERIA ZUMMARI Sup. 607.94 Ha 56 53 - MASSERIE ARCHE - CANISI - ANNIBALE Sup. 131.99 Ha 61 54 - MASSERIE LO LEZZI - LA NOVA Sup. 691.45 Ha CAMPI SALENTINA MELENDUGNO 55 - MONTAGNA SPACCATA / RUPI DI S. MAURO Sup. 293.19 Ha LIZZANELLO 56 - TORRE DELL'ORSO Sup. 164.99 Ha 0 0 0 57 - TORRE SUDA Sup. 1025.59 Ha 0 NOVOLI 9 4 4 58 - ZPS BAIA VERDE Sup. 112.09 Ha 0 0 0 0 4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DI NUOVA ISTITUZIONE 4 CASTRI DI LECCE 4 GUAGNANO 59 - MASSERIA CERRATE - BOSCO GALIARDI Sup.