Comune Di Brallo Di Pregola Provincia Di Pavia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Provincia Di Pavia Studio Geologico Idrogeologico E Sismico a Supporto
COMUNE DI BORGO PRIOLO PROVINCIA DI PAVIA STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Art. 57 L.R. 12/05 - D.G.R. Lomb. N.8/1566 del 22/12/2005 D.G.R. Lomb. N.8/7374 del 28/05/2008 e D.G.R. Lomb. N.9/2616 del 30/11/2011 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA OTTOBRE 2012 A cura di: STUDIO TECNICO GUADO GEOLOGIA APPLICATA STUDI PROGETTAZIONI CONSULENZE 27052 - Godiasco - Salice Terme (PV) - Via Mascagni, 1 e-mail: paola @studioguado.com - P. IVA 02345260182 - C.F. GDUPLA69B64B715U DR.SSA GEOL. PAOLA GUADO Collaboratori: DR.SSA GEOL. VALERIA PANARO DR. IVANO POLA STUDIO TECNICO GUADO INDICE PREMESSA pag. 1 1. Metodologia di lavoro pag. 2 2. Riferimenti bibliografici e documentazione consultata pag. 4 3. Inquadramento geografico e climatico pag. 6 4. Inquadramento geologico-strutturale (Tav.1) pag. 15 5. Inquadramento geomorfologico (Tav. 2) pag.21 5.1 Aspetti generali pag.21 5.2 Analisi del dissesto franoso pag.25 6. Carta dell’acclività (Tav. 3) pag.29 7. Carta geolitologica (Tav. 4) pag.30 8. Carta idrogeologica e del sistema idrografico (Tav. 5) pag.33 8.1 Aspetti idrografici e idraulici pag.33 8.2 Aspetti idrogeologici pag.34 8.3 Vulnerabilità degli acquiferi pag.36 9. Caratterizzazione sismica del territorio (Tav. 6 – All.to 1) pag.39 9.1 Analisi sismica di I livello (all.to 1) pag.39 9.2. Analisi sismica di II livello (all. to 1) pag.39 9.2.1. Calcolo di Fa in aree interessate da amplificazioni litologiche e geometriche (PSL Z4) pag.44 9.3. -

Alto Oltrepò Pavese (Regione Lombardia) PARTE PRIMA ANALISI E DESCRIZIONE
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali AREA INTERNA appennino lombardo- O V alto oltrepo' pavese I REGIONE LOMBARDIA T A Z Z I N A G R O A E R A ' D R E I S S O D Nota introduttiva Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale della superficie nazionale e interessa oltre quattromila comuni. Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica, ma anche un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari. La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il territorio nazionale. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione territoriale. Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità di gestire i servizi pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. -
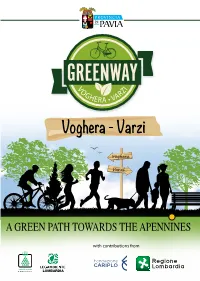
Greenway V O I G Rz Hera • Va
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi A GREEN PATH TOWARDS THE APENNINES with contributions from Credits Voghera - Varzi Greenway: a green path towards the Apennines • The guide to the route is a project promoted by Provincia di Pavia in partnership with Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese and Legambiente Lombardia, with contributions from the Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. Editing, design, graphics, text, layout and printing: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finished printing in the month of June 2021. ©Province of Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 All rights reserved. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it This guide is printed respecting the environment on recycled paper. discovering the OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Exploring Walking Cycling Savouring discovering the OLTREPÒ PAVESE 2 The Voghera - Varzi Greenway is ready. It is a 33 kilometers long dream, begone when dreaming cost nothing. When thinking of recovering the old railway line was a romantic, good and appealing idea, yet so unlikely. Still we succeeded. With passion, persistence, and a lot of good will. If it is true, as Eleanor Roosevelt wrote, “that the future belongs to the ones who believe in the beauty of their dreams”, therefore today we are giving Oltrepò a little something to hope a different, better future. Discovering the territory, experiencing the natural beauty, sharing the pleasure of good food, letting the silence of unexpected and magical places conquer ourselves, being together with friend hoping the time will never pass. -

Piano Annuale Dell'offerta Abitativa 2021
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola,Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA ABITATIVA 2021 CONTESTO Il presente Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali è stato predisposto in conformità all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’Ambito e dall’ALER di Pavia-Lodi, che è stata sentita prima di sottoporre la proposta all’Assemblea dei Sindaci. L’Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese è composto dai Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Colli Verdi, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera e Zavattarello. In data 9.05.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha designato il Comune di Voghera quale Ente capofila dell’Ambito per la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale. Il Presente Piano Annuale 2021 dell’offerta abitativa, come indicato dal punto 3 del Comunicato regionale n. 45 del 2 aprile 2019, contiene tutti i dati indicati come contenuti minimi ed essenziali inviati dai Comuni dell’Ambito territoriale e dall’ALER di Pavia-Lodi. -

Piani Di Zona 2018-2020 Sottoscrizione Dell'accordo Di
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 474/DGi DEL 20/12/2018 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Piani di Zona 2018-2020: sottoscrizione dell'Accordo di programma per la creazione di un nuovo Ambito territoriale costituito dal Piano di Zona di Voghera e dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Vittorio DEMICHELI (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile U.O.C Governo della Presa in carico e dei percorsi assistenziali Dr.ssa Loredana Niutta (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Cristina Cordini Assistente sociale Mariuccia Ghizzoni L'anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. -

Comune Di Robecco Pavese
COMUNE DI ROBECCO PAVESE PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 6 DdP Documento di Piano Fascicolo IL PAESAGGIO PROGETTISTA SINDACO dott. arch. Mario Mossolani Pier Luigi Bianchi COLLABORATORI SEGRETARIO dott. urb. Sara Panizzari dott. Umberto Fazia Mercadante dott. ing. Giulia Natale dott. ing. Marcello Mossolani geom. Mauro Scano STUDI NATURALISTICI TECNICO COMUNALE dott. Massimo Merati geom. Roberto Madama dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Robecco Pavese PAESAGGIO COMUNE DI ROBECCO PAVESE Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Il Paesaggio INDICE 1..PAESAGGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ..................................................................................................... 7 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................. 7 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .......................................................................... 8 PARTE I IL PIANO DEL PAESAGGIO DI ROBECCO PAVESE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ....................... 9 2..IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR ............................................... 10 2.1. CONTENUTI DEL PPR ....................................................................................... 10 2.2. IL VECCHIO -

Via Del Sale”– Allegato 2 Aprile 2014
SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 13 “Via del Mare – Via del Sale”– Allegato 2 aprile 2014 Percorso Ciclabile di Interesse Regionale 13 Via del Mare - Via del Sale Lunghezza: 68 Km Territori provinciali attraversati: Pavia Collegamenti con: l’Emilia Romagna dal Comune di Brallo di Pregola altri percorsi ciclabili regionali 13 Capisaldi PCIR 13: Pavia (PV) – Brallo di Pregola/ Passo del Giona (PV) Il percorso ciclabile di interesse regionale 13 “Via del mare - via del sale” prende spunto da un antico tracciato che permetteva il commercio del sale mettendo in comunicazione Pavia con Genova. Il percorso ha avvio a Pavia – non lontano dal PCIR 5 “Via dei Pellegrini” - e nel suo primo tratto, coincide con il PCIR 1 “Ticino” e con il PCIR 8 “Po”. Il suo tragitto verso sud continua in sovrapposizione con il PCIR 8, in sinistra del Po, dirigendosi verso la frazione Boschi (Comune di Travacò Siccomario), segue percorsi ciclabili dedicati e protetti (via Battella, via Predamasco) e in minima parte strade secondarie per poi oltrepassare il fiume Po, utilizzando la ex SS 35 (Cava Manara). Da qui il percorso, fino a raggiungere Cervesina, utilizza il PCIR 8 in destra Po. Da Cervesina, abbandonato il percorso 8, si dirigere verso Voghera seguendo il Torrente Staffora. Poi sottopassa l’Autostrada A21 Torino - Piacenza e la Linea ferroviaria Voghera - Pavia e, giunto a Voghera, sottopassa la Linea ferroviaria Voghera - Piacenza. Qui si SCHEDA DESCRITTIVA – PCIR 13 “Via del Mare – Via del Sale”– Allegato 2 aprile 2014 stacca dal torrente dirigendosi verso Codevilla, dove percorre la SP1 fino a Rivanazzano, per poi seguire nuovamente il torrente Staffora fino a Varzi. -

Comuni Serviti Da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura
Comuni serviti da Pavia Acque Comune Acquedotto Fognatura ALAGNA SERVITO SERVITO ALBAREDO ARNABOLDI SERVITO SERVITO ALBONESE SERVITO SERVITO ALBUZZANO SERVITO SERVITO ARENA PO SERVITO SERVITO BADIA PAVESE SERVITO SERVITO BAGNARIA SERVITO SERVITO BARBIANELLO SERVITO SERVITO BASCAPE' SERVITO SERVITO BASTIDA PANCARANA SERVITO SERVITO BATTUDA SERVITO SERVITO BELGIOIOSO SERVITO SERVITO BEREGUARDO SERVITO SERVITO BORGARELLO SERVITO SERVITO BORGO PRIOLO SERVITO SERVITO BORGO SAN SIRO SERVITO SERVITO BORGORATTO MORMOROLO SERVITO SERVITO BORNASCO SERVITO SERVITO BOSNASCO SERVITO SERVITO BRALLO DI PREGOLA SERVITO SERVITO BREME SERVITO SERVITO BRESSANA BOTTARONE SERVITO SERVITO BRONI SERVITO SERVITO CALVIGNANO SERVITO SERVITO CAMPOSPINOSO SERVITO SERVITO CANDIA LOMELLINA SERVITO SERVITO CANNETO PAVESE SERVITO SERVITO CARBONARA AL TICINO SERVITO SERVITO CASANOVA LONATI SERVITO SERVITO CASATISMA SERVITO SERVITO CASEI GEROLA SERVITO SERVITO CASORATE PRIMO SERVITO SERVITO CASSOLNOVO SERVITO SERVITO CASTANA SERVITO SERVITO CASTEGGIO SERVITO SERVITO CASTELLETTO DI BRANDUZZO SERVITO SERVITO CASTELLO D'AGOGNA SERVITO SERVITO CASTELNOVETTO SERVITO SERVITO CAVA MANARA SERVITO SERVITO CECIMA SERVITO SERVITO CERANOVA SERVITO SERVITO CERETTO LOMELLINA SERVITO SERVITO CERGNAGO SERVITO SERVITO CERTOSA DI PAVIA SERVITO SERVITO CERVESINA SERVITO SERVITO CHIGNOLO PO SERVITO SERVITO CIGOGNOLA SERVITO SERVITO Comune Acquedotto Fognatura CILAVEGNA SERVITO SERVITO CODEVILLA SERVITO SERVITO COLLI VERDI (ex Canevino, Ruino, Valverde) SERVITO SERVITO CONFIENZA SERVITO SERVITO -

Rideterminazione Ambiti Territoriali Di Assistenza Primaria E Di Pediatria Di Libera Scelta a Seguito Di Fusione Di Comuni
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 495/DGi DEL 08/11/2019 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI OGGETTO: Rideterminazione ambiti territoriali di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta a seguito di fusione di comuni. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile F.F. UOC Rete Assistenza Primaria e Continuità delle Cure Dr.ssa Raffaella Brigada (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Franco Brasca L'anno 2019 addì 08 del mese di Novembre IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia; Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S. -

A Relazione Illustrativa Ruino.Pdf
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI DEL TIDONE PAVESE Studio geologico - tecnico territoriale a supporto del P.G.T. del Comune di RUINO RELAZIONE GEOLOGICA GENERALE Relazione illustrativa INDICE 1. INTRODUZIONE ……..……………………………………………………………………………. 1 1.1 OGGETTO DELLO STUDIO ……………………………………………………………………… 1 1.2 DOCUMENTAZIONE REALIZZATA …….............................……………………..........………. 2 1.3 DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA ................................................……………………….…… 3 1.4 ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO .............................................……………..………….…… 5 2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E CLIMATICO ………………………..… 7 2.1 CARATTERIZZAZIONE FISIOGRAFICA ...............…………………………………................... 7 2.2 UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE AFFIORANTI ........……….……………………….................... 9 2.2.1 Coperture quaternarie di natura alluvionale ........……………………………….………. 10 2.2.2 Formazioni marine (bed-rock) …………………….......….……………...…….………. 11 2.3 ASSETTO GEOLOGICO STRUTTURALE ...............………………………………..................... 13 2.4 GEOMORFOLOGIA ……………………………………………………………………………… 14 2.5 CARATTERIZZAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI – QUADRO DEL DISSESTO ............................ 15 2.5.1 Tipologia ……………….……………………………………. ........……………….………. 16 2.5.2 Localizzazione e descrizione dei dissesti principali .................................................... 17 2.5.3 Cause indotte ………………………..…………………..……......….………….…………. 19 2.6 INQUADRAMENTO CLIMATICO …...………………………………......................................... 19 2.6.1 Pluviometria ........……………….……......................................................................…. -

A V V I S O Contributi Relativi Alle “Misure Forestali” E “Misure Forestali E Sistemazioni Idrauliche Forestali” Di Cui Agli Artt
A V V I S O CONTRIBUTI RELATIVI ALLE “MISURE FORESTALI” E “MISURE FORESTALI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI” DI CUI AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA L.R- 7/2000 Con decreto del Dirigente Unità Organizzativa del 31/05/2006 n° 6070, attuativo della Deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/2219 del 29/03/2006 avente per oggetto “Criteri di riparto per l’esercizio 2006 a favore delle Comunità Montane a sensi artt. 24 e 25 della L.R. 7/2000" é stato effettuato l’impegno di spesa a favore della Comunità Montana Oltrepo Pavese come sotto specificato 1. “MISURE FORESTALI (A)” € 36.032,20 2. “MISURE FORESTALI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI (B)” € 305.133,74 Con nota n° 9845 del 20/04/2006 la Direzione Generale Agricoltura ha ulteriormente autorizzato l’utilizzo delle economie maturate sulle precedenti assegnazioni a sensi L.R. 80/89 che per questa Comunità Montana ammontano ad € 75.389,77 Talché l’assegnazione complessiva risulta essere di € 416.555,71 La Comunità Montana Oltrepo Pavese con Provvedimento del Responsabile Area 5”Agricoltura” n° 53 del 23/06/2006 ha approvato i criteri di selezione e le modalità di presentazione delle domande a sensi artt. 24 e 25 della Legge Regionale 7/2000 con l’attivazione delle Misure sottoelencate per gli importi assegnati sui rispettivi interventi: MISURA (A) Misure Forestali TIPOLOGIA INTERVENTI SOMMA IMPEGNATA Interventi Selvicolturali finalizzati Misura A.B) Al miglioramento ambientale e paesaggistico A.B1) Interventi selvicolturali € 100.000,00 A.B2) Sostituzione Impianti artificiali fuori areale -

Report-Doltrepo1.Pdf
Report d’Oltrepo - Antologia di ricerche, analisi, commenti, considerazioni, esperienze: i prodotti di un dialogo decennale tra GAL e alto Oltrepo Pavese PSL Leader Plus - Azione 7.2.1. “Informazione e comunicazione”; Azione 7.3.1. “Osservatorio Socio Economico Ambientale” Coordinamento: O.S.E.A. GAL Alto Oltrepo s.r.l. Testi: Elena Buscaglia, Marco Degliantoni, Paola Fugagnoli, Raffaella Piazzardi O.S.E.A. GAL Alto Oltrepo s.r.l. Un ringraziamento particolare a Nicola Adavastro per aver ideato e sostenuto l’O.S.E.A. e l’ampia attività di ricerca Editing: Roberta Valle Elaborazioni cartografiche: Marco Degliantoni - O.S.E.A. GAL Alto Oltrepo s.r.l. Si ringraziano per la collaborazione e la preziosa disponibilità: Istituto I.P.S.I.A. “Calvi” - Varzi Angelo Dedomenici - Casanova Staffora, Santa Margherita Staffora Roberto Ferrari - Canova, Menconico Fabrizio Lanzarotti - Loc. Campalbino, Cecima Cristiano Nobile - Canova, Menconico Maria Chiara Onida - Loc. Boscasso, Ruino Cristiano Tagliani - San Martino, Varzi Giorgio e Daniela Tornari - Brallo di Pregola Immagini fotografiche: Roberta Valle Progetto grafico: Studio 66 - Casteggio (PV) Ottobre 2008 INDICE INTRODUZIONE 05 CONOSCERE L’ALTO OLTREPO PAVESE 13 Il territorio 13 La popolazione 14 L’ambiente 15 Gli Enti Locali: attori di un dialogo con il territorio 17 Il Formulario rivolto agli Enti Locali per conoscere i servizi al territorio (FOR.E.L.) 17 Architettura rurale: un patrimonio da recuperare 29 Le strutture edilizie sottoutilizzate nel territorio Leader 31 VIVERE IN ALTO OLTREPO