Report-Doltrepo1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Estratto Le Terre Dei Re
UN FANTASTICO ITINERARIO STORICO E ARCHITETTONICO TRA MEDIOEVO Itineraries E RINASCIMENTO A great historical and architectural tour trough the Middle Ages and Reinassance Le Terre dei Re DAI LONGOBARDI AI VISCONTI The Lands of Kings FROM THE LONGOBARDS TO THE VISCONTI LA PROVINCIA DI PAVIA, THE PROVINCE OF PAVIA, con la forza della qualità e della bellezza, ha selezionato Confident of the beauty of the territory and what it has con gli operatori del territorio 4 itinerari che favoriscono to offer visitors, the provincial authorities have joined with la scoperta di luoghi di grande attrattiva. various organisations operating in the area to draw up four itineraries that will allow travellers to discover intriguing Sono 4 itinerari che suggeriscono approcci diversi new destinations. e che valorizzano le diverse vocazioni di un territorio poco conosciuto e proprio per questo contraddistinto Four different itineraries that present the varied vocations da una freschezza tutta da scoprire. of a little-known territory just waiting to be discovered. Un turismo intelligente fruibile tutti i giorni dell’anno, Intelligent tourism accessible all year-round in the heart vissuto nel cuore del territorio lombardo, fra pianura, of Lombardy - ranging from the plains to the hills and the colline e Appennino, ideale per scoprire la storia, Appenine Mountains, a voyage into the history, the culture la cultura e la natura a pochi passi da casa. and the natural beauty that lies just around the corner. • VIGEVANO • MEDE • PAVIA • MIRADOLO TERME • MORTARA • LOMELLO -

Provincia Di Pavia Studio Geologico Idrogeologico E Sismico a Supporto
COMUNE DI BORGO PRIOLO PROVINCIA DI PAVIA STUDIO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Art. 57 L.R. 12/05 - D.G.R. Lomb. N.8/1566 del 22/12/2005 D.G.R. Lomb. N.8/7374 del 28/05/2008 e D.G.R. Lomb. N.9/2616 del 30/11/2011 RELAZIONE GEOLOGICA ILLUSTRATIVA OTTOBRE 2012 A cura di: STUDIO TECNICO GUADO GEOLOGIA APPLICATA STUDI PROGETTAZIONI CONSULENZE 27052 - Godiasco - Salice Terme (PV) - Via Mascagni, 1 e-mail: paola @studioguado.com - P. IVA 02345260182 - C.F. GDUPLA69B64B715U DR.SSA GEOL. PAOLA GUADO Collaboratori: DR.SSA GEOL. VALERIA PANARO DR. IVANO POLA STUDIO TECNICO GUADO INDICE PREMESSA pag. 1 1. Metodologia di lavoro pag. 2 2. Riferimenti bibliografici e documentazione consultata pag. 4 3. Inquadramento geografico e climatico pag. 6 4. Inquadramento geologico-strutturale (Tav.1) pag. 15 5. Inquadramento geomorfologico (Tav. 2) pag.21 5.1 Aspetti generali pag.21 5.2 Analisi del dissesto franoso pag.25 6. Carta dell’acclività (Tav. 3) pag.29 7. Carta geolitologica (Tav. 4) pag.30 8. Carta idrogeologica e del sistema idrografico (Tav. 5) pag.33 8.1 Aspetti idrografici e idraulici pag.33 8.2 Aspetti idrogeologici pag.34 8.3 Vulnerabilità degli acquiferi pag.36 9. Caratterizzazione sismica del territorio (Tav. 6 – All.to 1) pag.39 9.1 Analisi sismica di I livello (all.to 1) pag.39 9.2. Analisi sismica di II livello (all. to 1) pag.39 9.2.1. Calcolo di Fa in aree interessate da amplificazioni litologiche e geometriche (PSL Z4) pag.44 9.3. -

Alto Oltrepò Pavese (Regione Lombardia) PARTE PRIMA ANALISI E DESCRIZIONE
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali AREA INTERNA appennino lombardo- O V alto oltrepo' pavese I REGIONE LOMBARDIA T A Z Z I N A G R O A E R A ' D R E I S S O D Nota introduttiva Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale della superficie nazionale e interessa oltre quattromila comuni. Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica, ma anche un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari. La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il territorio nazionale. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione territoriale. Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità di gestire i servizi pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. -

Frane in Collina: Chiuse Le Strade a Montesegale E Lirio Di Alessandro Disperati
1 Anno 7 - N° 65 Montù Beccaria Aprile 2013 La minoranza 20.000 contesta le scelte COPIE della giunta Frane in collina: chiuse le strade a Montesegale e Lirio DI ALESSANDRO DISPERATI Tanta neve. E poi tanta, tantissima pioggia. E le col- line dell’Oltrepò pavese, così come accaduto negli anni scorsi non hanno retto a questo maltempo che non sembra concedere una tregua. Girando per l’Ol- trepo in questi giorni si possono vedere campi com- pletamente allagati: il terreno dopo così tanta acqua non è più in grado di assorbirne. E poi molti campi franati alcuni in mezzo ad altri terreni, altri invece si sono riversati in strada o nei torrenti. Come acca- duto a Broni, dove una frana ha rischiato di ostruire completamente il torrente Scuropasso rischiando di formare un effetto diga che sarebbe stato devastante. E poi a Montesegale dove un intero versante si sta muovendo verso valle rischiando anche di travolgere la piccola frazione di Casa Biotto a ridosso della bel- la chiesa di San Damiano. Qui è stata chiusa anche la La svolta per le Terme strada provinciale che porta alla frazione Zuccarello e che collega Montesegale con la Val di Nizza. Arriva Elio Rosada SERVIZI A PAGINA 23 E 41 Elio Rosada ha acquistato le Terme di Salice e si accinge a rilanciare la struttura termale, che ha ri- aperto i battenti proprio nei giorni scorsi dopo una chiusura di tre mesi. L’ufficializzazione è arrivata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale andato in scena a Godiasco quando il sindaco, Anna Corbi, ha comunicato che la società Terme di Salice passa news nelle mani di Elio Rosada, Presidente di Sapo Spa, il quale dovrà effettuare la compravendita della so- cietà entro fine aprile. -
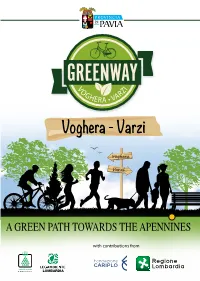
Greenway V O I G Rz Hera • Va
GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Voghera Varzi A GREEN PATH TOWARDS THE APENNINES with contributions from Credits Voghera - Varzi Greenway: a green path towards the Apennines • The guide to the route is a project promoted by Provincia di Pavia in partnership with Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese and Legambiente Lombardia, with contributions from the Fondazione Cariplo and Regione Lombardia. Editing, design, graphics, text, layout and printing: Bell&Tany, Voghera, bell-tany.it. Finished printing in the month of June 2021. ©Province of Pavia 2021 ©Bell&Tany 2021 All rights reserved. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited. www.provincia.pv.it www.visitpavia.com www.greenwayvogheravarzi.it This guide is printed respecting the environment on recycled paper. discovering the OLTREPÒ PAVESE 2044 0053 AT / 11 / 002 GREENWAY V O I G RZ HERA • VA Voghera - Varzi Exploring Walking Cycling Savouring discovering the OLTREPÒ PAVESE 2 The Voghera - Varzi Greenway is ready. It is a 33 kilometers long dream, begone when dreaming cost nothing. When thinking of recovering the old railway line was a romantic, good and appealing idea, yet so unlikely. Still we succeeded. With passion, persistence, and a lot of good will. If it is true, as Eleanor Roosevelt wrote, “that the future belongs to the ones who believe in the beauty of their dreams”, therefore today we are giving Oltrepò a little something to hope a different, better future. Discovering the territory, experiencing the natural beauty, sharing the pleasure of good food, letting the silence of unexpected and magical places conquer ourselves, being together with friend hoping the time will never pass. -

Comune Di Miradolo Terme
COMUNE DI MIRADOLO TERME PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 6 DdP Documento di Piano IL PAESAGGIO ED IL RAPPORTO Fascicolo CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA Gianpaolo Troielli dott. arch. Mario Mossolani COLLABORATORI dott. urb. Sara Panizzari dott. Ing. Giulia Natale SEGRETARIO dott. ing. Marcello Mossolani Dott. Flavia Fulvio geom. Mauro Scano TECNICO COMUNALE Geom. Orazio Pacella STUDI NATURALISTICI dott. Massimo Merati dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Miradolo Terme PAESAGGIO COMUNE DI MIRADOLO TERME Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Il Paesaggio INDICE 1..PAESAGGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ..................................................................................................... 8 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................. 8 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .......................................................................... 9 PARTE I IL PIANO DEL PAESAGGIO DI MIRADOLO TERME SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ..................... 11 2..IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR ............................................... 12 2.1. CONTENUTI DEL PPR ...................................................................................... -

Comune Di Brallo Di Pregola Provincia Di Pavia
COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 DdP 8 Documento di Piano RELAZIONE ILLUSTRATIVA Fascicolo DEL DOCUMENTO DI PIANO allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. del SINDACO PROGETTISTA dott. Bruno Tagliani dott. arch. Mario Mossolani COLLABORATORI ASSESSORE ALL’URBANISTICA dott. ing. Marcello Mossolani dott. Arch. Osvaldo Ravetta geom. Mauro Scano SEGRETARIO dott. Sandro Sciamanna STUDI NATURALISTICI dott. Niccolò Mapelli Tecnico Comunale geom. Silvano Re STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Brallo di Pregola DdP– Relazione illustrativa COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Relazione illustrativa INDICE PARTE I RIFERIMENTI NORMATIVI, PROCEDURE E CONTENUTI ......... 6 1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO ........................................................... 7 1.1. PGT DI BRALLO DI PREGOLA .................................................................. 7 1.2. NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE ............................................... 7 1.2.1. DOCUMENTO DI PIANO ............................................................................................. 7 1.2.2. PIANO DEI SERVIZI ................................................................................................... 7 1.2.3. PIANO DELLE REGOLE .............................................................................................. -

Commissione Provinciale Di Pavia
Allegato 1 COMMISSIONE PROVINCIALE per l’indicazione dei valori fondiari medi di PAVIA - Costituita con decreto n. 12701 del 26/10/2020 Tabella dei valori fondiari medi dei terreni valida per l’Anno 2020 Reg. Ag. 1 Reg. Ag. 2 Reg. Ag. 3 Reg. Ag. 4 Reg. Ag. 5 Reg. Ag. 6 Reg. Ag. 7 Reg. Ag. 8 Reg. Ag. 9 Reg. Ag. 10 Reg. Ag. 11 COLTURA €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq.. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. €/mq. Seminativo 0,78 2,00 1,35 3,00 3,40 3,50 3,80 3,30 3,00 3,80 3,30 Seminativo Arb. 0,85 2,20 1,05 === === === === === === 3,75 === Seminativo Irr. === === === 3,50 3,95 4,25 4,90 3,80 3,40 === 3,70 Prato 0,56 1,70 1,05 === === === === === === === === Prato Irriguo === 2,17 === 2,40 2,90 3,36 3,10 2,56 === 2,70 2,80 Prato a Marcita === === === 2,30 3,00 3,10 3,00 2,43 2,45 === 2,50 Risaia Stabile === === === 3,00 2,86 3,30 3,50 3,00 2,78 === 3,00 Pascolo 0,33 0,36 0,33 === === === === === === === === Pascolo Arb. 0,34 0,37 0,34 === === === === === === === === Orto === 3,07 === 2,78 3,09 2,77 2,95 2,77 2,77 3,44 2,77 Orto Irriguo === === === 3,60 4,25 4,35 5,10 3,90 3,40 3,90 3,80 Vigneto I.G.P. 1,27 4,00 3,20 === === === === === === 3,20 2,20 Vigneto D.O.C. === 5,04 4,00 === === === === === === 4,00 2,68 Frutteto 2,75 3,30 2,90 === === === === === === 3,80 2,50 Bosco Alto F. -

Curriculum Professionale Segretario Comunale Dr
CURRICULUM PROFESSIONALE SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAN LUCA MUTTARINI AL 30/06/2009 - Assunzione in servizio in qualità di segretario comunale: 18 agosto 1991 a seguito concorso pubblico nazionale, con nomina a segretario capo con decorrenza 19.2.96 - Dal 18.8 al 30.9.81 in servizio fra i Comuni di Arena Po (PV) e Bosnasco (PV) - Dal 1.10.91 al 14.12.92 in servizio presso la segreteria comunale di Bascapè (PV) - Dal 15.12.92 al 31.3.93 in servizio presso la convenzione fra i Comuni di Arena Po (PV) e Bosnasco (PV) e, in qualità di supplente, alla segreteria convenzionata di Corteolona- Genzone (PV) - Dall’ 1.4.93 al 14.7.96 in servizio presso la convenzione fra i Comuni di Corteolona (PV) e Torre d’Arese (PV) - Dal 15.7.96 al 31.5.00 in servizio presso la convenzione fra i Comuni di Rovescala (PV) e San Damiano al Colle (PV), alla quale si aggiunse per breve periodo il Comune di San Zenone al Po (PV), con incarico di direttore generale - Dall’ 1.6.00 in servizio presso la segreteria comunale di Miradolo Terme (PV) e, dal 4.7.01 della sede convenzionata fra questo comune e quello di Salerano sul Lambro (LO) nonchè – dall’ 1.1.04 – presso la segreteria convenzionata fra questi ed il Comune di Villanova del Sillaro (LO) - In servizio con incarico di reggente presso la segreteria comunale di Volpara (PV) dal 18.5.99 al 31 marzo 2000 - Incarico di reggenza, dal 1.2.00 al 31.5.00 presso la segreteria del Comune di Miradolo Terme (PV) con incarico di Direttore generale con contestuale incarico di reggenza in servizio dall’ 1.6.00 presso il Comune -

Piano Annuale Dell'offerta Abitativa 2021
COMUNE DI VOGHERA Provincia di Pavia PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola,Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera, Zavattarello PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA ABITATIVA 2021 CONTESTO Il presente Piano Annuale dell’Offerta dei Servizi Abitativi Pubblici e Sociali è stato predisposto in conformità all’articolo 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e sulla base dei dati forniti dai Comuni dell’Ambito e dall’ALER di Pavia-Lodi, che è stata sentita prima di sottoporre la proposta all’Assemblea dei Sindaci. L’Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese è composto dai Comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Colli Verdi, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera e Zavattarello. In data 9.05.2019 l’Assemblea dei Sindaci ha designato il Comune di Voghera quale Ente capofila dell’Ambito per la programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale. Il Presente Piano Annuale 2021 dell’offerta abitativa, come indicato dal punto 3 del Comunicato regionale n. 45 del 2 aprile 2019, contiene tutti i dati indicati come contenuti minimi ed essenziali inviati dai Comuni dell’Ambito territoriale e dall’ALER di Pavia-Lodi. -

Piani Di Zona 2018-2020 Sottoscrizione Dell'accordo Di
AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA (DGR n. X/4469 del 10.12.2015) Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187 DECRETO N. 474/DGi DEL 20/12/2018 IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Anna PAVAN OGGETTO: Piani di Zona 2018-2020: sottoscrizione dell'Accordo di programma per la creazione di un nuovo Ambito territoriale costituito dal Piano di Zona di Voghera e dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Codifica n. 1.1.02 Acquisiti i pareri di competenza del: DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Vittorio DEMICHELI (Firmato digitalmente) DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Francesca Laura FANCELLI (Firmato digitalmente) DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Firmato digitalmente) Il Responsabile del Procedimento: Responsabile U.O.C Governo della Presa in carico e dei percorsi assistenziali Dr.ssa Loredana Niutta (La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso) Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Cristina Cordini Assistente sociale Mariuccia Ghizzoni L'anno 2018 addì 20 del mese di Dicembre IL DIRETTORE GENERALE Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.); Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e successive modifiche e integrazioni; Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"; Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. -

Comune Di Robecco Pavese
COMUNE DI ROBECCO PAVESE PROVINCIA DI PAVIA PGT Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n 12 6 DdP Documento di Piano Fascicolo IL PAESAGGIO PROGETTISTA SINDACO dott. arch. Mario Mossolani Pier Luigi Bianchi COLLABORATORI SEGRETARIO dott. urb. Sara Panizzari dott. Umberto Fazia Mercadante dott. ing. Giulia Natale dott. ing. Marcello Mossolani geom. Mauro Scano STUDI NATURALISTICI TECNICO COMUNALE dott. Massimo Merati geom. Roberto Madama dott. Niccolò Mapelli STUDIO MOSSOLANI urbanistica architettura ingegneria via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 82423 – www.studiomossolani.it PGT del Comune di Robecco Pavese PAESAGGIO COMUNE DI ROBECCO PAVESE Provincia di Pavia PGT Piano di Governo del Territorio DOCUMENTO DI PIANO Il Paesaggio INDICE 1..PAESAGGIO: RIFERIMENTI NORMATIVI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ..................................................................................................... 7 1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI .................................................................................. 7 1.2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO .......................................................................... 8 PARTE I IL PIANO DEL PAESAGGIO DI ROBECCO PAVESE SECONDO LE INDICAZIONI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE ....................... 9 2..IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE PPR ............................................... 10 2.1. CONTENUTI DEL PPR ....................................................................................... 10 2.2. IL VECCHIO