Venere E Totò
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
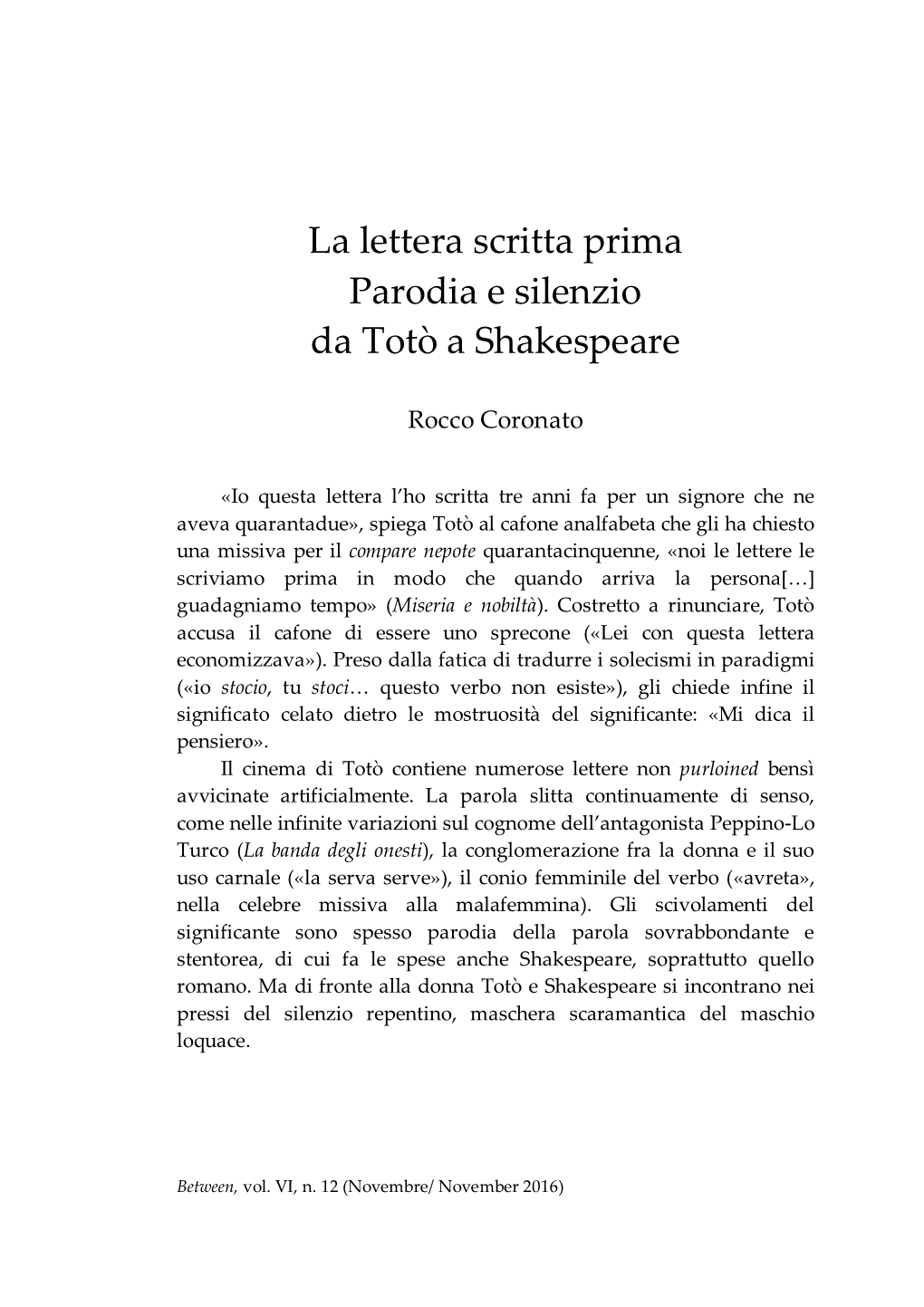
Load more
Recommended publications
-

Festival Speciale Direttore Responsabile: Paola Cristalli
festival Speciale Direttore responsabile: Paola Cristalli. Direzione culturale: Cineteca di Bologna. Coordinamento redazionale: Mauro Bonifacino, Alessandro Cavazza, Valeria Dalle Donne, Andrea Meneghelli, Sandro Toni. Collaboratori: Roberto Benatti, Guy Borlée, Alberto Boschi, Michele Canosa, Rinaldo Censi, Luisa Ceretto, Filippo D’Angelo, Gualtiero De Marinis, Anna Di Martino, Anna Fiaccarini, Vittoria Gua- landi, Franco La Polla, Loris Lepri, Andrea Maioli, Giacomo Manzoli, Nicola Mazzanti, Roy Menarini, Patrizia Minghetti, Andrea Morini, Francesco Pitassio, Paolo Simoni, Angela Tromellini, Romano Zanarini. Edizione on-line: Alessandro Cavazza. Grafica: Studio Kuni. Composizione e stampa: Linosprint - Tipografia Moderna. Proprietà: Cineteca di Bologna (aut. Trib. N. 5243 del 14-2-1985) - Presi- dente: Giuseppe Bertolucci. Direttore: Gian Luca Farinelli. Consiglio d’amministrazione: Giuseppe Bertolucci, Francesco Arnone, Gian Piero Brunetta, Alberto Clò, Marco Sermenghi. festival mostra delle scuole europee di cinema - 6a edizione visioni italiane - 10a edizione esordire al Cinema premio luca de nigris “È ora di fare cinema” Bologna Venerdì 21 – Mercoledì 26 novembre 2003 festival Con il contributo di Foto in copertina da destra a sinistra: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema RECONSTRUCTION (Danimarca/2003) di Christoffer Boe (© Linn Sandholm) Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna COMING HOME (Gran Bretagna/2003) di Gemma Carrington Emilia-Romagna Film Commission FINO A CHE -

Fascist Italy's Aerial Defenses in the Second World War
Fascist Italy's Aerial Defenses in the Second World War CLAUDIA BALDOLI ABSTRACT This article focuses on Fascist Italy's active air defenses during the Second World War. It analyzes a number of crucial factors: mass production of anti- aircraft weapons and fighters; detection of enemy aircraft by deploying radar; coordination between the Air Ministry and the other ministries involved, as well as between the Air Force and the other armed services. The relationship between the government and industrialists, as well as that between the regime and its German ally, are also crucial elements of the story. The article argues that the history of Italian air defenses reflected many of the failures of the Fascist regime itself. Mussolini's strategy forced Italy to assume military responsibilities and economic commitments which it could not hope to meet. Moreover, industrial self-interest and inter-service rivalry combined to inhibit even more the efforts of the regime to protect its population, maintain adequate armaments output, and compete in technical terms with the Allies. KEYWORDS air defenses; Air Ministry; anti-aircraft weapons; bombing; Fascist Italy; Germany; radar; Second World War ____________________________ Introduction The political and ideological role of Italian air power worked as a metaphor for the regime as a whole, as recent historiography has shown. The champions of aviation, including fighter pilots who pursued and shot down enemy planes, represented the anthropological revolution at the heart of the totalitarian experiment.1 As the Fascist regime had practiced terrorist bombing on the civilian populations of Ethiopian and Spanish towns and villages before the Second World War, the Italian political and military leadership, press, and industrialists were all aware of the potential role of air 1. -

L'arte Dell'interpretazione Attraverso Il Racconto Degli Autori Della Fotografia AIC AIC
AIC L'Immagin' ae RecitazionCinematografice a L'arte dell'interpretazione attraverso il racconto degli autori della fotografia AIC AIC » Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. J II direttore della fotografia, in un film, dà qualcosa di suo, una qualità ineffabile, che non si riesce a descrive- re a parole, ma che fa riconoscere agli occhi dell'esper- to, lo stile e la qualità della prestazione. Per esempio, Tonino Delli Colli, ha un suo modo tutto particolare di riprendere gli occhi e i lineamenti del volto umano e cer- tamente io mi servo di questa sua straordinaria abilità per ricavare, dal mio punto di vista, tutta l'espressività psicologica dei personaggi. Pier Paolo Pasolini, 1971 AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFICINEMATOGRAFICAA AIC AIC ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA AIC Associazione Italiana Autori della Fotografia IMAGO Membro "Federazione Europea degli Autori della Fotografia Cinematografica" IMAGO AIC costituita il 13 maggio 1950 AIC Presidente Collegio Sindacale Franco Di Giacomo Sergio Salvati Sebastiano Celeste Sergio D'Offizi Angelo Filippini Alessandro Feirachios Vicepresidenti Mario Vulpiani Paolo Ferrari Alessio Gelsini Torresi Angelo Filippini Giuseppe Lanci Soci effettivi Roberto Forges Davanzati Marcello Montarsi Cesare Accetta Giovanni Galasso Maxime Alexandre Marcello Gatti Segretario generale Manfredo Archinto Alessio Gelsini Torresi Giuseppe Berardini Adolfo Bartoli Roberto Girometti Gianlorenzo Battaglia Giuliano Giustini Consiglieri Tarek Ben Abdallah Antonio Grambone -

Remembering World War Ii in the Late 1990S
REMEMBERING WORLD WAR II IN THE LATE 1990S: A CASE OF PROSTHETIC MEMORY By JONATHAN MONROE BULLINGER A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Communication, Information, and Library Studies Written under the direction of Dr. Susan Keith and approved by Dr. Melissa Aronczyk ________________________________________ Dr. Jack Bratich _____________________________________________ Dr. Susan Keith ______________________________________________ Dr. Yael Zerubavel ___________________________________________ New Brunswick, New Jersey January 2017 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Remembering World War II in the Late 1990s: A Case of Prosthetic Memory JONATHAN MONROE BULLINGER Dissertation Director: Dr. Susan Keith This dissertation analyzes the late 1990s US remembrance of World War II utilizing Alison Landsberg’s (2004) concept of prosthetic memory. Building upon previous scholarship regarding World War II and memory (Beidler, 1998; Wood, 2006; Bodnar, 2010; Ramsay, 2015), this dissertation analyzes key works including Saving Private Ryan (1998), The Greatest Generation (1998), The Thin Red Line (1998), Medal of Honor (1999), Band of Brothers (2001), Call of Duty (2003), and The Pacific (2010) in order to better understand the version of World War II promulgated by Stephen E. Ambrose, Tom Brokaw, Steven Spielberg, and Tom Hanks. Arguing that this time period and its World War II representations -

POPULAR DVD TITLES – As of JULY 2014
POPULAR DVD TITLES – as of JULY 2014 POPULAR TITLES PG-13 A.I. artificial intelligence (2v) (CC) PG-13 Abandon (CC) PG-13 Abduction (CC) PG Abe & Bruno PG Abel’s field (SDH) PG-13 About a boy (CC) R About last night (SDH) R About Schmidt (CC) R About time (SDH) R Abraham Lincoln: Vampire hunter (CC) (SDH) R Absolute deception (SDH) PG-13 Accepted (SDH) PG-13 The accidental husband (CC) PG-13 According to Greta (SDH) NRA Ace in the hole (2v) (SDH) PG Ace of hearts (CC) NRA Across the line PG-13 Across the universe (2v) (CC) R Act of valor (CC) (SDH) NRA Action classics: 50 movie pack DVD collection, Discs 1-4 (4v) NRA Action classics: 50 movie pack DVD collection, Discs 5-8 (4v) NRA Action classics: 50 movie pack DVD collection, Discs 9-12 (4v) PG-13 Adam (CC) PG-13 Adam Sandler’s eight crazy nights (CC) R Adaptation (CC) PG-13 The adjustment bureau (SDH) PG-13 Admission (SDH) PG Admissions (CC) R Adoration (CC) R Adore (CC) R Adrift in Manhattan R Adventureland (SDH) PG The adventures of Greyfriars Bobby NRA Adventures of Huckleberry Finn PG-13 The adventures of Robinson Crusoe PG The adventures of Rocky and Bullwinkle (CC) PG The adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D (SDH) PG The adventures of TinTin (CC) NRA An affair to remember (CC) NRA The African Queen NRA Against the current (SDH) PG-13 After Earth (SDH) NRA After the deluge R After the rain (CC) R After the storm (CC) PG-13 After the sunset (CC) PG-13 Against the ropes (CC) NRA Agatha Christie’s Poirot: The definitive collection (12v) PG The age of innocence (CC) PG Agent -

Morocco Quits Libya Treaty Over Criticism
MANCHESTER CONNECTICUT SPORTS MCC gears up Murray Gold gets Carter kills Sox; for another year 25-year sentence lead is cut to ZV2 |MIQ0 3 ... page 11 anrhratrrManchester — A City ol Village Charm linnlh ^ ^ 25 Cents A Claims Morocco quits get tough Libya treaty U scrutiny over criticism Insurance crisis R ABAT, Morocco (AP) — King endangers town Hassan’s meeting July 22-23 in Hassan II said in a letter released Ifrane with Israeli Prime Minister G Friday that he was abrogating a Shimon Peres. By George Loyng 1984 treaty of union with Libya ■'The terms of the Syrian-Libyan Herald Reporter ■ because of Col. Moammar Gadha- communique, published ... at the fi’s criticism of a meeting last end of the visit of (Syrian) When a Glastonbury couple month between Hassan and Israeli President Hafez el-Assad to Libya, notified the town of Manchester Prime Minister Shimon Peres. do not allow our country to earlier this month that they Hassan said in the letter written continue on the path of the union of intended to sue over injuries their Thursday to Gadhafi that the states instituted with your coun teenage son suffered while using a criticism contained in a joint try,” Hassan said in the letter. rope swing at the Buckingham Libyan-Syrian statement issued Hassan became the only Arab Reservoir, it made some officials the day before had reached "the head of state outside Egypt to meet angry. threshold of the intolerable." publicly with the head of the The boy, Matthew Lawrence, He said it was not possible to Jewish nation. -

Auch Die Körper Von Jago Und Othello. Eine Lange Fahrt Mit Subjektiver
Auch die Körper von Jago und Othello. angeht, die 'Sittenkomödie' mit ihrer opportunistischen Korrum- Eine lange Fahrt mit subjektiver Kamera, die Erde, Himmel und piertheit, auch wenn diese zum Schein hinter Denunziationspro Müllhalde schwindelerregend sich drehen läßt, aus der Sicht der blemen verborgen ist. beiden Körper, die schreiend vor Entsetzen hinunterrollem Bis Diese Unterscheidung und diese Bevorzugung decken sich mit un das Objektiv, unbewegt, nach oben gerichtet ist, gegen den un serer eigenen Beurteilung. Das Totb-Revival ist also nicht nur An endlichen blauen Himmel, über den weiße Wolken eilen. laß zur Freude. Aber gerade deshalb ist es notwendig, den Punkt In dem aufgeplatzten, geschwollenen Gesicht Othellos leuchten auf das i zu setzen, bevor man uneingeschränkte Genugtuung die Augen vor brennender Neugier und nicht unterdrückbarer äußert oder die neue Vorliebe gänzlich und ausschließlich positiv Freude. interpretiert. Tatsächlich geht die subproletarische Komik oft und Auch Jagos Augen betrachten höchst verblüfft oder in Ekstase gern in die unpolitische Haltung des kleinen Mannes über und hat wesentliche Beiührungspunkte mit der kleinbürgerlichen Komik. dieses nie gesehene Schauspiel von Himmel und Welt. Da es ihr an einer genau bestimmten Verwurzelung in einer Klasse Othello: Was ist denn das? und an expliziten Widersprüchen mangelt, ist die Ideologie, die sie Jago: Das sind ... das sind ... die Wolken ... zum Ausdruck bringt, die Frucht einer verzweifelten Lebensangst, Othello: Und was sind Wolken? die im täglichen -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles Misery Is the True Script For
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Misery is the True Script for Comedy: A Study of Italian Film Comedy in the 1950s A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Christopher Burton White 2014 © Copyright by Christopher Burton White 2014 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Misery is the True Script for Comedy: A Study of Italian Film Comedy in the 1950s by Christopher Burton White Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2014 Professor Thomas J. Harrison, Chair This dissertation fills a lacuna in the history of Italian cinema, formally analyzes a selection of significant film comedies from the 1950s, and challenges many of the assumptions that have been made about postWar Italian cinema. The conservative atmosphere of the fifties, the detrimental effects of censorship on Italian cinema, and the return of popular genres after the end of the widely-acclaimed neorealist period have led to assumptions about a limited engagement With contemporary Italian society in the motion pictures produced in Italy during the 1950s. While most critics and film historians vieW these years in Italian cinema as the disappointing aftermath of neorealism, a decade in Which conservative elements in Italian society pushed national cinema in the direction of facile optimism and escapism, this dissertation demonstrates that many comedies in fact engaged with Italian society, ii offering incisive critiques of contemporary Italy that pinpoint and satirize hypocrisy, inequality, and a host of other ills of the Italian republic in the 1950s. This study considers existing scholarship on Italian cinema and reevaluates films starring the popular Neapolitan actor Antonio De Curtis (Totò), Renato Castellani’s Due soldi di speranza (Two Cents Worth of Hope, 1952) and other examples of neorealismo rosa (rosy or pink neorealism), and the movies directed by Federico Fellini featuring Alberto Sordi, both in terms of aesthetics as well as subject matter. -

Copia Privata" Per L'anno 2011 (*) Per I Film Esteri Usciti in Italia L’Anno Corrisponde All’Anno Di Importazione Titolo Anno Paese
Elenco dei titoli interessati ai compensi "copia privata" per l'anno 2011 (*) Per i film esteri usciti in Italia l’anno corrisponde all’anno di importazione titolo anno paese 101 Reykjavik 2000 Islanda/Danimarca/Francia/Norvegia/Germania 12 round 2009 USA 1408 2007 USA 16 VIAGGI DELLA SPERANZA 2005 ITALIA 17 again - Ritorno al liceo 2009 USA 1814 2007 Russia 1960 2010 Italia 2001 UN'ASTRONAVE SPUNTATA NELLO SPAZIO 2000 Canada/Germania 2012 2009 USA 20 sigarette 2010 Italia 28 settimane dopo 2007 GB 2 Fast 2 Furious 2003 USA 2 giorni a Parigi 2007 Francia 301 - La Leggenda Di Maximus Il Fichissimo 2009 USA 30 anni in 1 secondo 2004 USA 30 giorni di buio 2008 USA 30 GIORNI PER INNAMORARSI 2009 Germania 36, quai des orfévres 2005 Francia 3 ciento chi l'ha duro... la vince 2008 USA 3 STRIKES 2000 USA 400 colpi (I) 1959 Francia 40 anni vergine 2005 USA 42 PLUS 2007 Austria 48ORE DI TERRORE 2010 Canada 4 bastardi per un posto all'inferno 1973 USA 4BIA (See prang) 2008 Thailandia 4 mesi, 3 settimane 2 giorni 2007 Romania 4 per Cordoba 1970 USA 500 giorni insieme 2009 USA 5 matti alla corrida 1974 Francia 5 matti al servizio di leva 1973 Francia 5 matti al supermercato 1973 Francia 5 matti vanno in guerra (Les bidasses s'en vont en guerre) 1975 Francia/Italia/Germania Occ. 7 cadaveri per Scotland Yard (Jack, el destripador de Londres) 1972 Spagna/Italia 7° viaggio di Sinbad (Il) 1958 USA 88 Minutes 2007 USA 8 amici da salvare 2006 USA 9 E 1/2 DATES (9 és 1/2 randi) 2008 Ungheria 98 OTTANI 2006 Portogallo A CONFRONTO 2009 Austria/Germania A HERO NEVER DIES 1998 Hong Kong A KIND OF AMERICA 2 (Valami Amerika 2) 2008 Ungheria A SWEDISH LOVE STORY 1970 Svezia A/R andata + ritorno 2004 Italia 1 Elenco dei titoli interessati ai compensi "copia privata" per l'anno 2011 (*) Per i film esteri usciti in Italia l’anno corrisponde all’anno di importazione titolo anno paese A 30 secondi dalla fine 1986 USA A.A.A. -

Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Edwin Thomas, Emily Watson
Ein Film von Rupert Everett Mit Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan, Edwin Thomas, Emily Watson Kinostart : 24. Mai 2018 Dauer: 105 min. Pressematerial : http://www.frenetic.ch/espace-pro/details//++/id/929 Medienbetreuung DISTRIBUTION Jasmin Linder FRENETIC FILMS AG 044 488 44 26 Lagerstrasse 102 • 8004 Zürich [email protected] Tel. 044 488 44 00 • Fax 044 488 44 11 www.frenetic.ch 1 SYNOPSIS Im Zimmer einer Absteige in Paris liegt Oscar Wilde (Rupert Everett) auf seinem Sterbebett, Erinnerungen an früher versetzen ihn in andere Zeiten und an andere Orte. War er wirklich einst der berühmteste Mann in London? Der Künstler, der von einer Gesellschaft gekreuzigt wurde, die ihn einst anhimmelte? Der Liebhaber, verhaftet und freigelassen, der im letzten Abschnitt seines Lebens dennoch dem Ruin entgegentaumelt? Wilde lässt sein Leben nochmals Revue passieren: der gescheiterte Versuch, sich mit seiner Ehefrau Constance (Emily Watson) zu versöhnen, die wieder aufflammende, fatale Liebesaffäre mit Lord Alfred Douglas (Colin Morgan) sowie die warmherzige Hingabe von Robbie Ross (Edwin Thomas), der vergeblich versuchte, Wilde vor sich selbst zu retten. 2 BESETZUNG Oscar Wilde RUPERT EVERETT Reggie Turner COLIN FIRTH Alfred Bosie COLIN MORGAN Robbie Ross EDWIN THOMAS Constance Wilde EMILY WATSON Felices Mutter FRANCA ABATEGIOVANNI Mr. Howard ALISTER CAMERON Mrs. Arbuthnott ANNA CHANCELLOR Maurice Gilbert TOM COLLEY Managerin Café Concert BÉATRICE DALLE Krankenschwester JOHANNA KIRBY Monsieur Dupoirier ANDRÉ PENVERN Richter RONALD -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Misery is the True Script for Comedy: A Study of Italian Film Comedy in the 1950s Permalink https://escholarship.org/uc/item/52s6f970 Author White, Christopher Burton Publication Date 2014 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Misery is the True Script for Comedy: A Study of Italian Film Comedy in the 1950s A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Christopher Burton White 2014 © Copyright by Christopher Burton White 2014 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Misery is the True Script for Comedy: A Study of Italian Film Comedy in the 1950s by Christopher Burton White Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2014 Professor Thomas J. Harrison, Chair This dissertation fills a lacuna in the history of Italian cinema, formally analyzes a selection of significant film comedies from the 1950s, and challenges many of the assumptions that have been made about postWar Italian cinema. The conservative atmosphere of the fifties, the detrimental effects of censorship on Italian cinema, and the return of popular genres after the end of the widely-acclaimed neorealist period have led to assumptions about a limited engagement With contemporary Italian society in the motion pictures produced in Italy during the 1950s. While most critics and film historians vieW these years in Italian cinema as the disappointing aftermath of neorealism, a decade in Which conservative elements in Italian society pushed national cinema in the direction of facile optimism and escapism, this dissertation demonstrates that many comedies in fact engaged with Italian society, ii offering incisive critiques of contemporary Italy that pinpoint and satirize hypocrisy, inequality, and a host of other ills of the Italian republic in the 1950s. -

Marquesini Df Me Assis.Pdf (1.537Mb)
DANIELE FABÍOLA MARQUESINI A pluralidade de Antonio de Curtis-Totò: o poeta, o ator e a representatividade dramática na cultura italiana ASSIS 2021 DANIELE FABÍOLA MARQUESINI A pluralidade de Antonio de Curtis-Totò: o poeta, o ator e a representatividade dramática na cultura italiana Dissertação apresentada à Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis, para a obtenção do título de Mestra em Letras (Área de conhecimento: Literatura e Vida Social) Orientadora: Prof. Dra. Gabriela Kvacek Betella Bolsista: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001 Assis 2021 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Biblioteca da F.C.L. - Assis - Unesp Marquesini, Daniele Fabíola M357p A pluralidade de Antonio de Curtis-Totò: o poeta, o ator e a representatividade dramática na cultura italiana / Daniele Fabíola Marquesini. Assis, 2021. 117 f. : il. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências e Letras, Assis Orientadora: Dra. Gabriela Kvacek Betella 1. Totò, 1898-1967. 2. Humorismo italiano. 3. Cinema italiano. I. Título. CDD 857 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA Câmpus de Assis CERTIFICADO DE APROVAÇÃO TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: A pluralidade de Antonio de Curtis-Totò: o poeta, o ator e a representatividade dramática na cultura italiana AUTORA: DANIELE FABÍOLA MARQUESINI ORIENTADORA: GABRIELA KVACEK BETELLA Aprovada como parte das exigências para obtenção do Título de Mestra em LETRAS, área: Literatura e Vida Social pela Comissão Examinadora: Profa. Dra. GABRIELA KVACEK BETELLA (Participaçao Virtual) Departamento de Letras Modernas / UNESP/Assis Prof. Dr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES MARQUES (Participaçao Virtual) Departamento de Letras Modernas / UNESP/Assis Profa. Dra.