Marcello.Foa.Manuel.A.Bragonzi.Il
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
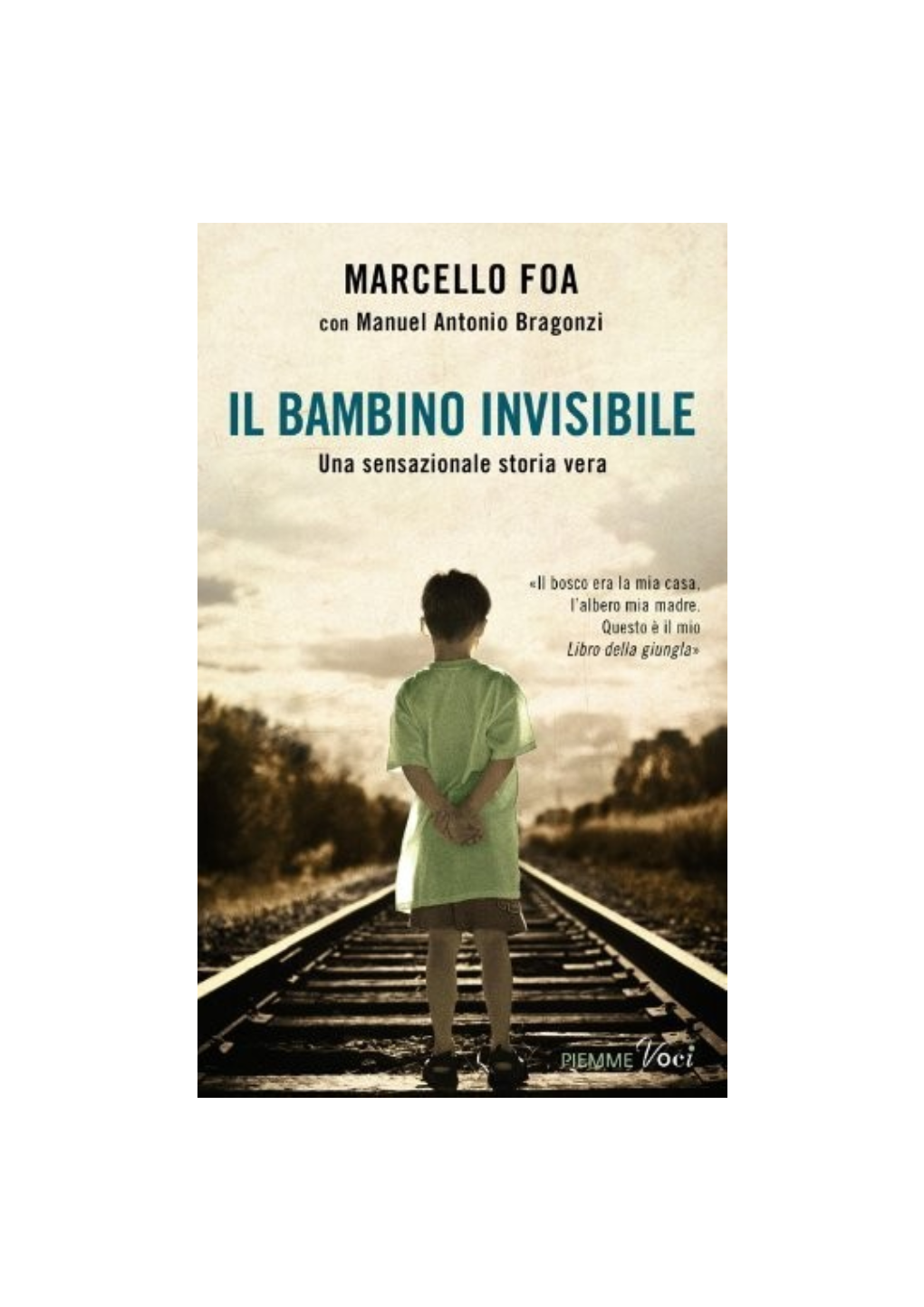
Load more
Recommended publications
-

Il Psi Attacca De Mita «O Cambi Passo O Te Nevai»
I està Nazionale de l'Unita SS Firenze V i'88| Giornale Anno 65* n 182 Spedizione in abb post gr 1/70 " Fiorente SS del Partito L 1000 / arretrati L 2000 ////////% comunista Sabato 85 agosto • 18 settembre rilnità italiano 20 agosto 1988 ' Marco Boato denuncia isuoi Editoriale MARETTA NEL GOVERNO De Michelis pone una scadenza: autunno accusatori Intanto la manovra economica rischia di saltare Marco Boato (nella foto), raggiunto da comunicazione giudiziana per il caso Sofn, passa al contrattacco e sporge denuncia contro gli ignon che lo hanno accusato «pur sapendo che e innocente» Mauro Rostagno e Roberto Agosto '88: Monm, gli altn due ex leader di Lotta continua, «avvisati» dal giudice Lombardi, promettono di fare altrettanto Nel prossimi giorni verranno sentiti tutti gli altri inquisiti rimasti riabilitate; Il Psi attacca De Mita fino ad ora senza nome Rostagno «Combattevamo Cala Dubcek bresi solo con armi politiche- A PAOnM g George Bush ha chiuso la Ora Bush Convention di New Orleans «O cambi passo o te nevai» insegue con il discorso più abile della sua carriera politica; liSiraiBTSAPSuTSSB Dukakis per la prima volta, taf loca al centro to la carta del pragmatismo stato ed è giusto ricordare insieme - in questo Fuochi ferragostani nella maggioranza di governo deciso di procedere a ranghi sione fiscale, mentre 1 liberali no de, Guido Bodrato, se la e della moderazione, goar- 1988-1 vent'annl della primavera di Praga e I sulla manovra economica. Alsoctalista De Miche compatti contro il volo segre premono per un drastico ridi prende con I socialisti «Sono ««•^^^"•"••i^" dando al centro come DM- vent'anro dell'Invasione e occupazione della to a cominciare dall'appunta mensionamento della spesa - dice - da anni al governo, kakls e accorciando perciò le sue distanze dal rivale Sia Cecoslovacchia Per lungo tempo, da parte lis non piace il «passo» di De Mita: troppo lento. -

La Voce Della Scuola Annuale Della
La voce della Scuola Annuale della ScuolaTiepoloTiepolo Media Tiepolo Anno XXIX, Maggio 2020, Distribuzione gratuita l’emergenza sanitaria Coronavirus ha interrotto il nostro progetto che sarà ripreso l’anno prossi- mo. Tuttavia. durante il nostro mercatino benefico di Natale, sono stati esposti lavori realizzati La scuola Tiepolo non si è mai dai ragazzi in laboratori condotti dai volontari della comunità “Il seme”, come alcuni bigliettini fermata, nonostante l’emergenza tridimensionali, che hanno riscosso enorme successo, accanto a numerosi lavori dei nostri alunni sanitaria Coronavirus e così, realizzati insieme ai docenti. Sono stati proposti anche oggetti ideati dai docenti di sostegno nel grazie all’impegno costante dei nostri laboratorio “Diversamente creativi” ed abbiamo aderito al progetto Pigotte per l’Unicef. Alcuni nostri alunni hanno anche partecipato alla colletta alimentare. alunni e al lavoro In questa sezione trovate anche articoli e riflessioni scritti nelle lingue studiate a scuola: proficuo della didattica a inglese, francese, spagnolo, tedesco distanza, il nostro giornale esce ugualmente anche se, per la prima volta, solo in versione online. Buona lettura! ALLA SCOPERTA DELLA NUOVA SCUOLA I racconti dei primi giorni di scuola media con la gita per le classi prime alla Rocca di Lonato e altre numerose attività che si svolgono nei primi mesi. Una foto rielaborata e scattata nella sua camera da Elena Costa, 1ª A PICCOLI CRITICI Si possono trovare i commenti ai libri letti, con la guida dei docenti, e in autonomia dagli -
La Questione Del Dispositivo 39 Roberto De Gaetano Un Sentimento Scettico Del Mondo 55 Massimo Donà Cinema E Menzogna
FATA MORGANA Quadrimestrale di cinema e visioni Pellegrini Editore Direttore Roberto De Gaetano Comitato scientifico Dudley Andrew, Raymond Bellour, Sandro Bernardi, Francesco Casetti, Antonio Costa, Georges Didi-Huberman, Ruggero Eugeni, Annette Kuhn, Jacques Rancière, David N. Rodowick, Giorgio Tinazzi Comitato direttivo Marcello W. Bruno, Alessia Cervini, Daniele Dottorini, Bruno Roberti, Antonio Somaini, Salvatore Tedesco, Luca Venzi Caporedattore Alessandro Canadè Redazione Daniela Angelucci, Francesco Ceraolo, Massimiliano Coviello, Paolo Godani, Andrea Inzerillo, Carmelo Marabello, Emiliano Morreale, Antonella Moscati, Ivelise Perniola, Francesco Zucconi Coordinamento segreteria di redazione Loredana Ciliberto (resp.), Simona Busni Segreteria di redazione Raffaello Alberti, Andreina Campagna, Giovanni Festa, Greta Himmelspach, Caterina Martino, Clio Nicastro, Antonietta Petrelli, Annunziata Procida, Antonio Russo Progetto grafico Bruno La Vergata Webmaster Alessandra Fucilla Direttore Responsabile Walter Pellegrini Redazione DAMS, Università della Calabria Cubo 17/b, Campus di Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza) E-mail [email protected] Sito internet http://fatamorgana.unical.it Amministrazione - Distribuzione GRUPPO PERIODICI PELLEGRINI Via Camposano, 41 (ex via De Rada) - 87100 Cosenza Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672 E-mail [email protected] Sito internet www.pellegrinieditore.com ISSN 1970-5786 Abbonamento annuale € 35,00; estero € 47,00; un numero € 15,00 (Gli abbonamenti s’intendono rinnovati automaticamente se non disdetti 30 gg. prima della scadenza) c.c.p. n. 11747870 intestato a Pellegrini Editore - Via G. De Rada, 67/c - 87100 Cosenza Per l’abbonamento on line consultare il sito www.pellegrinieditore.com 2 FATA MORGANA SOMMARIO PAS UNE IMAGE JUSTE 9 Francesco Casetti La questione del dispositivo 39 Roberto De Gaetano Un sentimento scettico del mondo 55 Massimo Donà Cinema e menzogna. -

Baba Bye E Poi Non Ti Ho Vista Più Giorno Di Sole Sandra Vado Al
Sei Uno Sfigato Senza Averti Qui Siamo Al Centro Del Mondo 0-9 Tenendomi Ti Sento Vivere Tieni Il Tempo (K 360 Gradi: Tutto Cio Che Ho Baba Bye Un Giorno Così E Poi Non Ti Ho Vista Più Una Canzone D'amore Giorno Di Sole Uno In Più Sandra Viaggio Al Centro Del Mondo Vado Al Mare 78 Bit: Fotografia A 883: Aereoplano Andrà Tutto Bene ADAMO: Bella Vera Accanto a te l'estate Chiuditi Nel Cesso Affida Una Lacrima Al Vento Ci Sono Anch'io (Vers.havanamambo) Come Deve Andare Affida Una Lacrima Al Vento Come Mai Amo Con Un Deca Cade La Neve Così Come Sei Cade la neve Cumuli Delilah Dimmi Perchè Dolce Paola Dove Vai E La Mia Vita (Rhumba) Eccoti Felicità Fai Come Ti Pare Fiori Bianchi Per Te Favola Semplice Il Nostro Romanzo Finalmente Tu Inchallah Gli Anni Insieme Grazie Mille La Mia Vita Hanno Ucciso L'uomo Ragno La Notte è Fatta Per Amare Il Mondo Insieme A Te La donna dell'amico mio Innamorare Tanto La notte Io Ci Saro La notte Jolly Blue Lei L'ultimo Bicchiere Mes mains sur tes hanches La Dura Legge Del Goal Non Mi Tenere Il Broncio La Lunga Estate Caldissima Non sei tu La Regina Del Celebrità Non voglio nascondermi La Regola Dell'amico Sei Qui Con Me Lasciati Toccare Tu Somigli All'amore Le Luci Di Natale Una Ciocca Di Capelli Lo Strano Percorso Medley 1 (L'uomo Ragno - Sei Un Mito ADELMO: - Nord Sud Ovest Est - Rotta Per Casa E cosi viene Natale Di Dio ECOSIVIENENATALE Medley 2 LaPiu'BelladelMondo Nella Notte Nessun Rimpianto AFTERHOUSE: Nient'altro Che Noi Non è per sempre Niente Da Dire Non Mi Arrendo ALBANO & ROMINA: Non Ti Passa Più -

Periodico Di Cultura Arte E Letteratura Libreria Dante & Descartes € 7,00 2 Sud 4/5
RIVISTA EUROPEA REVUE EUROPÉENNE EUROPEAN REVIEW EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT sudREVISTA EUROPEA 4/5. > Testi Yvonne Baby Elisabeth Barillé Frédérich Beigbeder Piero Berengo Gardin Emmanuel Bonetti Gherardo Bortolotti Alessandro Broggi Esteban Buch Angelo Castrovilli Maria Grazia Calandrone Ennio Cavalli Gianni Celati Biagio Cepollaro Stanko Cerovic Fiammetta Cirilli Thierry Crifo Cesare Cuscianna Dominique Delcourt Paola De Luca Luis De Miranda Jean Philippe Domecq Francesco Forlani Gabriella Fuschini Antonio Ghirelli Marco Giovenale Paolo Graziano Benoît Gréan Domenico Grifoni Andrea Inglese Petr Král > Immagini Olivier Maillart Giorgio Mascitelli Frédéric Pajak Walter Nardon Marie B.Cros Marino Niola Archivio Fiat Michel Odoul Fulvio Caporso Jean-Pierre Ohl Davide Sala Matteo Palumbo Roger Salloch Alexandra Petrova Fulvio Caporso Felice Piemontese Emmanuel Bonetti Philippe Pogam Guy Debord Lakis Proguidis Philippe Schlienger Renata Prunas Mimmo Jodice Laura Pugno * Luca Anzani Eleonora Puntillo Philippe Schlienger Davide Racca Francis Amiand Raiz Roger Salloch Margherita Remotti Bruno Bressolin François Ricard > Traduzioni Marc Garcia Massimo Rizzante Frédérique Francesco Rosi Cris Altan Giacomazzi Daniéle Rousselier Paola De Luca Luigi Esposito Roger Salloch Federica Di Lella Roger Salloch Lucio Saviani Francesco Forlani Romain Slocombe Roberto Saviano Martina Mazzacurati Roberta della Volpe Domenico Scarpa Paola Micalizzi Luca Dalisi Carmelo Seminara Paolo Nusco Andréas Lang Romain Slocombe Valentina Parisi Patrick Chevaleyre Michele Sovente Alesandra Rivazio Archivio Nunziatella Michael Sullivan Laura Toppan Carlo Levi (archivio François Taillandier questo numero è Francesca Spinelli Prunas) Jean-Charles dedicato Irene Stelli Archivio Storico Vegliante a Pasquale Prunas e Maria Laura Vanorio Chantal Nau Ornela Vorpsi Giancarlo Mazzacurati Lidia Verde Rafaele Ide Stefano Zangrando periodico di cultura arte e letteratura Libreria Dante & Descartes € 7,00 2 sud 4/5.