Manuale Architettura
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
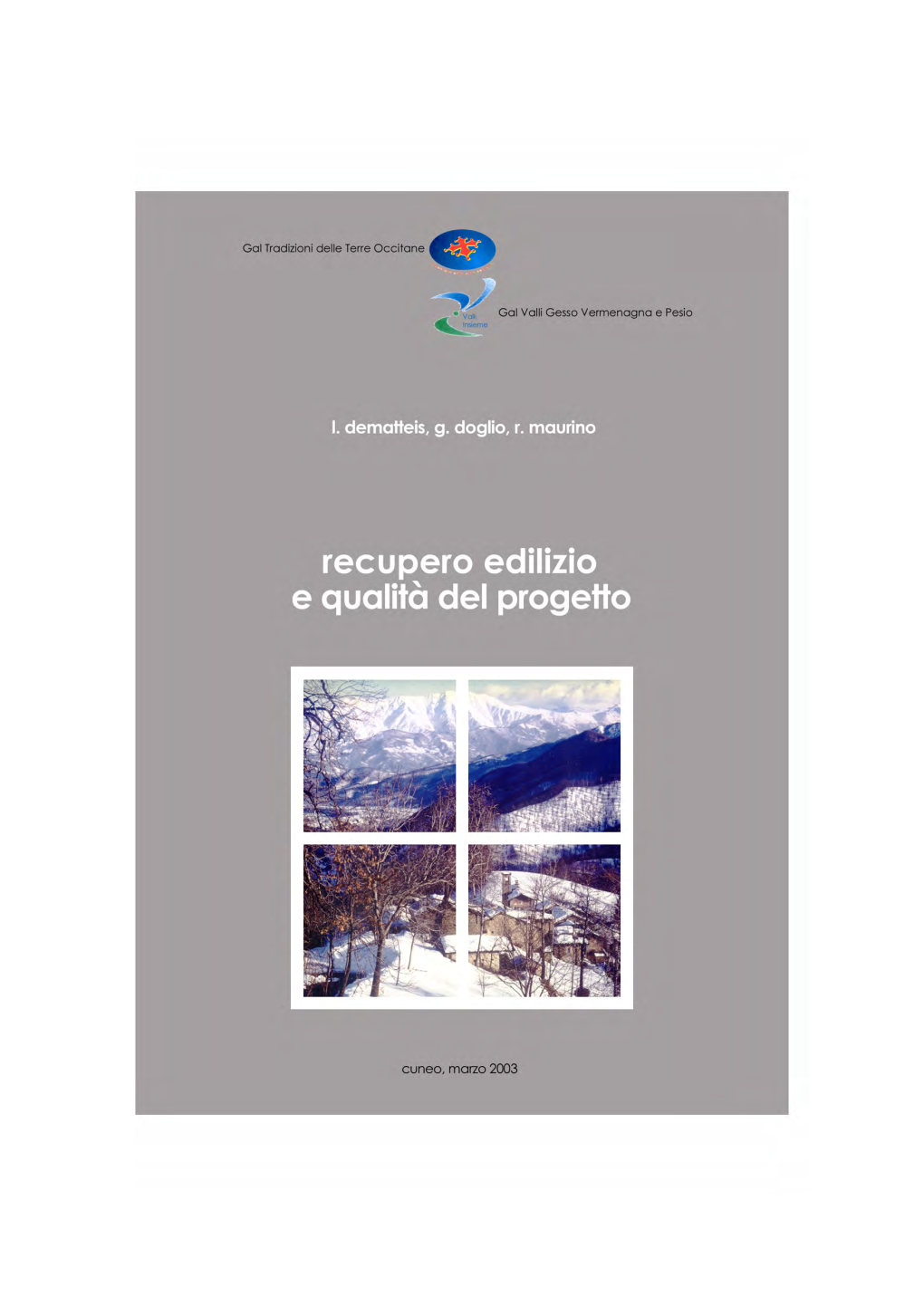
Load more
Recommended publications
-

Publication of an Application for Approval of a Minor Amendment in Accordance with the Second Subparagraph of Article 53(2)
30.8.2016 EN Official Journal of the European Union C 315/3 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2016/C 315/03) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘BRA’ EU No: PDO-IT-02128 — 18.3.2016 PDO ( X ) PGI ( ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP (association for the protection of ‘Bra’ PDO cheese) Via Silvio Pellico 10 10022 Carmagnola (TO) ITALIA Tel. +39 0110565985. Fax +39 0110565989. Email: [email protected] The Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [to be specified] 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amend ment to the published single document. -

Cartografia Del Piano Faunistico Venatorio Provinciale
0 10 20 40 km SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO POLIZIA LOCALE FAUNISTICO AMBIENTALE Cartografia del Piano Faunistico Venatorio 2003 – 2008 Istituti Provinciali aggiornamento anno 2018 1:135.000 AFV Ternavasso ha 306 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 articolo 10 RNS Confluenza del Maira ha 71 Delibera del Consiglio Provinciale n. 10-32 del 30 giugno 2003 e s.m.i. Delibera della Giunta Regionale n. 102-10160 del 28 luglio 2003 M! Casalgrasso e s.m.i. RNS Confluenza del Varaita ha 387 ZRC Pautasso ha 432 ZRC Valoira ha 236 Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio Monta' OAP San Nicolao ha 137 M! Corso Nizza 21 – 12100 CUNEO RNS Fontane ha 24 Faule Polonghera AFV Ceresole d'Alba ha 948 M! M! http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/caccia/piano-faunistico-venatorio Ceresole d'Alba M! M! OAP Piloni Votivi ha 16 Canale Govone AC Area contigua della fascia fluviale del Po - Tratto Cuneese ha 427 ZRC Centro cicogne ha 376 M! ZRC San Defenddente - Molino ha 234 Santo Stefano Roero Priocca ZRC Bosco di Caramagna ha 724 M! M! ZRC Roncaglia ha 375 ZRC Bonavalle ha 396 OAP Santuario Mombirone ha 45 Caramagna Piemonte M! Monteu Roero OAP Parco castello ha 171 M! ZRC Robella ha 364 Castellinaldo Sommariva del Bosco M! ZRC Priocca - San Vittore ha 583 M! M! Montaldo Roero Bagnolo Piemonte Moretta M! M! M! Magliano Alfieri Racconigi Vezza d'Alba M! Baldissero d'Alba M! M! ZRC Madonna Loreto ha 248 Castagnito ZRC Vaccheria - Baraccone - Canove ha 1336 ZRC America - Ruà Perassi ha 511 M! Murello Sanfre' M! M! ZPS Fiume Tanaro e Stagni di Neive ha 208 M! Carde' CP Murello ha 6 « Sommariva Perno Cavallerleone ZRC Canfré - Mulino ha 342 M! Torre San Giorgio ! ZRC Vendole - Piobesi ha 295 ZRC Castagnito - San Giuseppe ha 359 M! M Corneliano d'Alba M! M!Piobesi d'Alba OAP P.S.G. -

Dalla Mobilità All'emigrazione. Il Caso Del Piemonte Sud-Occidentale
Dalla mobilità all'emigrazione. Il caso del Piemonte sud-occidentale Dionigi Albera Realtà molto complesse e modelli troppo semplici Lo studio dei fenomeni migratori è stato per lungo tempo incline ad adagiarsi nell'alveo di una interpretazione dicotomica e meccanica. Alcuni modi di ragionare tipici del senso comune sono filtrati nella riflessione accademica, in un crescendo culminato col successo della teoria della modernizzazione, che ha condotto ad esasperare la contrapposizione tra la "modernità" e un universo "tradizionale" privo, tra le altre cose, anche di una consistente mobilità. Tutto può diventare molto semplice, in questo modo. Un mondo rurale, essenziamente statico e tendenzialmente autosufficiente, ad un certo punto sarebbe stato indotto ad espellere una parte della popolazione in seguito alla rottura dell'equilibrio: una rottura dovuta a fattori quali l'incremento demografico, l'insufficienza dell'agricoltura o l'influsso del mondo esterno. Un simile modello è stato spesso applicato al periodo della "grande emigrazione" europea. Così, studiando la mobilità, si è finito spesso per suggerire l'immobilità del periodo precedente a quello che si metteva a fuoco. Negli ultimi anni un deciso rinnovamento è venuto da una serie di studi che hanno cercato di evadere dalle griglie amministrativo-burocratiche delle rilevazioni statistiche. Ricerche di taglio micro-storico, prosopografico o biografico, così come lavori di carattere antropologico hanno fatto emergere la complessità dei movimenti di popolazione all'interno dell'Europa. Le tecniche d'indagine della demografìa storica, inoltre, hanno spesso consentito di misurare l'intensità di questi movimenti per periodi pre-statistici(l). Così, la situazione attuale appare piuttosto contraddittoria: vecchie e nuove tendenze convivono in qualche modo, spesso senza che la loro incompatibilità venga alla luce. -

Work in a Place with a Unique Past, Surrounded by Pristine Nature
Open call for a coordinator and a chef to work in Paraloup, a hamlet in Rittana (Cuneo, Italy) Deadline: 22 August 2020 WORK IN A PLACE WITH A UNIQUE PAST, SURROUNDED BY PRISTINE NATURE At the heart of a wonderful valley, a mountain hamlet that played an important role in Italian history now needs you to complete its rebirth About us Paraloup is a charming mountain hamlet at 1,360 meters of altitude, in the municipality of Rittana: a gem nestled in the Alps, overlooking the Stura Valley in the province of Cuneo, Italy. In 2006, the Nuto Revelli Foundation – in close collaboration with the community in Rittana and the Valley – decided to redevelop the hamlet for its historical and symbolic value. Indeed, Paraloup was where the first partisan formation in Italy came together: the “Italia Libera” band, led by Duccio Galimberti and Livio Bianco, with whom essayist Nuto Revelli fought. In those years, Paraloup was the epicenter of a unique kind of community Resistance: 149 youths gathered here from all over the country, to receive the political and military training they needed to fight to free Italy from Nazi-fascism, thanks to the crucial contribution and extraordinary solidarity of the Valley’s residents. In the decades after the war, the hamlet was gradually abandoned within the broader depopulation experienced in the Alps – but came back to life thanks to the Foundation’s work. In 2012, once the renovation was complete, the Foundation established the Rifugio Paraloup social enterprise with a specific mission to manage all hospitality activities; in late 2019, it also started a new transformation process: thanks to the constant communication and dialog with local institutions, many networking projects and the collaboration with an innovation manager, the Foundation and the social enterprise are planning a reorganization that will turn the hamlet into a new type of destination. -

Scarica L'appendice Con L'elenco Completo Degli Edifici Dismessi
Appendice II del Quaderno 37 della Collana della Fondazione CRC Rigenerare spazi dismessi Nuove prospettive per la comunità Elenco completo dei beni dismessi rilevati in provincia di Cuneo attraverso le fonti e grazie alle segnalazioni degli enti territoriali (aggiornato al 18 giugno 2018) Nota metodologica A cura di Fondazione Fitzcarraldo Si rende disponibile l’elenco dei 449 beni dismessi in provincia di Cu- neo rilevati attraverso le fonti disponibili e grazie alle segnalazioni dirette degli enti territoriali nell’ambito della mappatura realizzata per il Quaderno 37 Rigenerare spazi dismessi. Nuove prospettive per la comunità, pro- mosso dalla Fondazione CRC e realizzato da Fondazione Fitzcarraldo. Di seguito si specificano alcune considerazioni relative alla metodolo- gia adottata e alcune indicazioni utili alla consultazione dell’elenco. La scelta effettuata per disporre di una prima ricognizione di parte del patrimonio dismesso cuneese si è concretata, da un lato, in una ricerca e una lettura dei dati estrapolati dalle poche fonti disponibili e, dall’altro, nella raccolta di segnalazioni dirette da parte degli enti territoriali. Una mappatura efficace e puntuale in grado di fotografare dal punto di vista quantitativo e localizzativo tutte le opportunità e gli edifici in stato di abbandono e di sottoutilizzo in un territorio così vasto come la provincia di Cuneo non può prescindere da sopralluoghi mirati in tutti i 250 comuni del territorio. Per questo è più realistico definire questa parte della ricerca come una ricognizione “a maglie larghe” di un immenso patrimonio di- smesso che comprende una moltitudine di proprietari differenti. Le diverse fonti oggetto della presente ricognizione individuano beni le cui condizioni effettive non sono direttamente verificate, non essendo stati effettuati i sopralluoghi. -

Comune Di Verzuolo Regione Piemonte
Studio G E O E C O S Dott. Geol. G. MENZIO Programmazione Territoriale-Geotecnica-Idrogeologia Sede : Via Cavour 34 - SAMPEYRE (CN) Tel. 0175977186-Fax 1782737211 Cell. 3402572786 - E-mail: [email protected] Recapito: Via Magenta 12 – 10079 Collegno (TORINO)-Tel./fax 1786023725 Relazione Geologico – Idrogeologico – Tecnica (L.R. 56/77 e Circ. P.G.R. 7/ LAP dell’8/5/96) COMUNE DI VERZUOLO REGIONE PIEMONTE – Provincia di CUNEO Progetto : Redazione elaborati Geologici per Variante Generale dello Strumento Urbanistico; Progetto Preliminare. Committente : Amministrazione Comunale Gennaio 2009 G E O E C O S INDICE 1 - PREMESSA . 4 2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL'AREA . 6 3 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO . 8 3.1 - Inquadramento generale . 8 3.2 - Litotipi . 9 3.3 - Depositi quaternari . 10 4 – DATI PREGRESSI . 11 5 – CENNI di GEOIDROLOGIA . 14 6 - COMMENTO ALLA CARTA GEOLOGICO-MORFOLOGICA E DEI DISSESTI . 16 7 - COMMENTO ALLA CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE, DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE. 20 7.1 – Torrente Varata . 20 7.2 – Rii minori e canali. 26 8 - COMMENTO ALLA CARTA DI SINTESI . .28 8.1 - Premessa . 28 8.2 - Descrizione . 28 8.3 - Risultati . 33 Studio GEOECOS Relazione geologico – idrogeologico - tecnica Comune di Verzuolo (CN) Pagina 2 G E O E C O S ALLEGATI CARTOGRAFICI FUORI TESTO - CARTA CLIVOMETRICA – 1: 10.000; - CARTA GEOLOGICO - MORFOLOGICA E DEI DISSESTI – 1: 10.000; - CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE, DEL RETICOLATO IDROGRAFICO MINORE E DEI DISSESTI – 1: 10.000; - CARTA DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA CENSITE – 1: 10.000; - CARTA GEOIDROLOGICA – 1: 10.000; - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DELL’IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA – 1: 10.000; Studio GEOECOS Relazione geologico – idrogeologico - tecnica Comune di Verzuolo (CN) Pagina 3 G E O E C O S 1. -

Zone Del Sistema Confartigianato Cuneo -> Comuni
“Allegato B” UFFICI DI ZONA DELL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE CUNEO Zone e loro limitazione territoriale. Elenco Comuni. Zona di ALBA Alba Albaretto della Torre Arguello Baldissero d’Alba Barbaresco Barolo Benevello Bergolo Borgomale Bosia Camo Canale Castagnito Castelletto Uzzone Castellinaldo Castiglione Falletto Castiglione Tinella Castino Cerretto Langhe Corneliano d’Alba Cortemilia Cossano Belbo Cravanzana Diano d’Alba Feisoglio Gorzegno Govone Grinzane Cavour Guarene Lequio Berria Levice Magliano Alfieri Mango Montà Montaldo Roero Montelupo Albese Monteu Roero Monticello d’Alba Neive Neviglie Perletto Pezzolo Valle Uzzone Piobesi d’Alba Priocca Rocchetta Belbo Roddi Rodello Santo Stefano Belbo Santo Stefano Roero Serralunga d’Alba Sinio Tone Bormida Treiso Trezzo Tinella Vezza d’Alba Zona di BORGO SAN DALMAZZO Aisone Argentera Borgo San Dalmazzo Demonte Entracque Gaiola Limone Piemonte Moiola Pietraporzio Rittana Roaschia Robilante Roccasparvera Roccavione Sambuco Valdieri Valloriate Vernante Vinadio Zona di BRA Bra Ceresole d’Alba Cervere Cherasco La Morra Narzole Pocapaglia Sanfrè Santa Vittoria d’Alba Sommariva del Bosco Sommariva Perno Verduno Zona di CARRÙ Carrù Cigliè Clavesana Magliano Alpi Piozzo Rocca Cigliè Zona di CEVA Alto Bagnasco Battifollo Briga Alta Camerana Caprauna Castellino Tanaro Castelnuovo di Ceva Ceva Garessio Gottasecca Igliano Lesegno Lisio Marsaglia Mombarcaro Mombasiglio Monesiglio Montezemolo Nucetto Ormea Paroldo Perlo Priero Priola Prunetto Roascio Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto -

Maira Stradale Botte
Pontechianale Serro Maddalena Saluzzo Castello Gambasca Martiniana Maurin Borga Pagno Caldane Bianchi S.Anna Villar Dragoniere Casteldelfino Becetto Brodello Ve 1882 Belllino Sampeyre Masueira Torrete M.Maniglia Rore Isasca www.locandamistral.com •3177 )(Colle Bicocca Frassino 2637 Pratolungo Brossasco Brec de )( Torr Colle Maurin S.Annna ente Varaita Chambeyron Melle Piasco •3411 )( Colle di Sampeyre S.Maurizio S.Antonio Chiosso Venasca Elva Serre Valmala Cerreto Chesta Rossana Rocca Cucchiales Provenzale Eremo Bersia Lemma S.Michele Prazzo Stroppo Busca M.Sautron Chiappera Bedale Camoglieres •3166 Ussolo Ponte Maira Torrente Maira Macra Lottulo Prazzo ra Ponte Marmora ai Acceglio Bassura San Damiano Macra M M.Soubeyran te S.Giuseppe Locanda n 2701 Celle di Macra Roccabruna re )( MISTRAL Maddalena Albareto Villar San r Pas.della Cavalla o Costanzo T Morra Combamala DRONERO Marmora Cartignano Canosio Chialvetta Reinero M.Oronaye Paglieres Tetti •3100 S.Margherita Pratorotondo Pratavecchia Villata Viviere Tolosano Allardo 1997 Preit Colle della Maddalena Montemale P.della Gardetta )( Pas.Peroni )( S.Lorenzo Pradleves S.Giorgio )( Grangie a Castelmagno n M.VentasusoGite MTB Argenterdalla a Col Osero Cavaliggi Caraglio ra •2701 na e G Rua Bernardo Locanda Mistral S.Magno Campomolino e Gra nt Colle Colle Torrent rre 01 Xc Experience )( Valgrana To San Bernardo Margherita d’Eschiele Chiappi 02 bassa valle )( Chiotti Monterosso 03 Dragon Bike Bersezio Frise Grana 04 Colli Birrone, Melle, Ciabra 05 Strada dei Cannoni Figliere S.Anna 06 Rocca -

Dati Catastali
ISTAT TOPONIMO SEZ FOGLIO ATTITUDINE 001201 Pragelato 00 131 N 001198 Pomaretto 00 018 N LEGENDA 001168 None 00 011 S2 N suoli non idonei 001309 Vinovo 00 013 S2 S1 suoli senza limitazioni 001198 Pomaretto 00 022 N S2 suoli con limitazioni moderate 001186 Perrero 02 006 N S3 suoli con limitazioni elevate 001315 Volvera 00 030 S2 S4 suoli con limitazioni severe 001186 Perrero 01 011 N 001186 Perrero 08 004 N 001186 Perrero 08 007 N 001309 Vinovo 00 012 S2 001186 Perrero 05 007 N 001315 Volvera 00 023 S2 001053 Cantalupa 00 009 N 001190 Pinasca 00 031 N 001122 Inverso Pinasca 00 002 N 001168 None 00 010 S2 001087 Claviere 00 005 N 001156 Moncalieri 01 056 S2 001186 Perrero 03 005 N 001097 Cumiana 01 087 S4 001053 Cantalupa 00 015 S3 001186 Perrero 06 002 N 001215 Riva presso Chieri 00 054 S4 001315 Volvera 00 021 S2 001197 Poirino 00 008 S2 001122 Inverso Pinasca 00 003 S4 001198 Pomaretto 00 024 N 001234 Salza di Pinerolo 00 008 N 001198 Pomaretto 00 025 N 001186 Perrero 02 011 N 001168 None 00 009 S2 001315 Volvera 00 019 S2 001145 Massello 00 028 N 001097 Cumiana 02 006 S2 001198 Pomaretto 00 026 N 001051 Candiolo 00 011 S2 001186 Perrero 03 006 N 001097 Cumiana 01 086 S4 001309 Vinovo 00 019 S2 001309 Vinovo 00 016 S2 001186 Perrero 08 005 N 001097 Cumiana 02 005 S4 001258 Sauze di Cesana 00 002 N 001097 Cumiana 01 110 S3 001257 Santena 00 007 S4 001097 Cumiana 01 092 S3 001186 Perrero 01 001 N 001097 Cumiana 01 093 S3 001197 Poirino 00 006 S2 001234 Salza di Pinerolo 00 001 N 001258 Sauze di Cesana 00 015 N 001051 Candiolo 00 010 S2 -

C O M U N I C a T O S T a M
COMUNICATO STAMPA 59^ EDIZIONE FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO Cuneo - 8 dicembre 2011 complesso monumentale di San Francesco Cuneo - Con la consegna di premi a operatori economici e lavoratori che, con l’esempio di una vita dedicata al lavoro, hanno contribuito validamente e proficuamente al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia, si svolge giovedì 8 dicembre la cerimonia della Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2011 a Cuneo, presso il complesso monumentale di San Francesco - Via Santa Maria, 10 Saranno consegnati complessivamente 183 diplomi e medaglie d’oro, dei quali: - 42 ad industriali e commercianti con 35 anni di propria ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; - 65 ad artigiani con 35 anni di propria ininterrotta attività oppure appartenenti a famiglia titolare di azienda da almeno 80 anni; - 70 a coltivatori diretti con 40 anni di ininterrotto lavoro; - 3 ad affittuari con 35 anni di propria ininterrotta conduzione del fondo; - 3 a cooperative attive costituite da almeno 40 anni. Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” della Camera di commercio di Cuneo alcune persone che si sono particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato particolare capacità ed impegno nel settore in cui svolgono la loro attività: - Cristoforo CANAVESE - Savona - Presidente Autorità Portuale di Savona - Celestino COSTA - Pagno (Agricoltura) - Andreino DURANDO - Caraglio (Commercio) - Enzo GILETTA - Saluzzo (Industria) Giletta Spa - Giuseppe OLIVA - Borgo San Dalmazzo (Artigianato) Dulcioliva Srl - Primo SANTINI - Beinette (Cooperazione) Direttore generale F.A.I. Service Soc. Coop. Sarà altresì assegnato il premio speciale “Cuneese nel mondo” al Signor Bruno CERETTO della Ceretto Srl. -

Bollettino Trasferimenti Infanzia
SMOW5A 14-05-16PAG. 1 SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : CUNEO ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016/17 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. BORGHESE LOREDANA . 5/ 2/75 (CN) DA : CNAA85800A - MONDOVI' 1 (MONDOVI') A : CNAA859006 - MONDOVI' 2 (MONDOVI') PUNTI 102 2. BRUNENGO DANIELA . 4/ 1/84 (CN) DA : CNAA85800A - MONDOVI' 1 (MONDOVI') A : CNAA859006 - MONDOVI' 2 (MONDOVI') DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 69 3. CARAFA ROBERTA . 13/11/75 (LE) DA : CNAA861006 - CUNEO VIA SOBRERO (CUNEO) A : CNAA861006 - CUNEO VIA SOBRERO (CUNEO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 103 4. DOGLIANI MONICA . 17/ 2/79 (CN) DA : CNAA81800X - SOMMARIVA PERNO (SOMMARIVA PERNO) A : CNAA81800X - SOMMARIVA PERNO (SOMMARIVA PERNO) DA POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 107 5. MANGINI ROSANNA . 19/ 9/70 (GE) DA : CNAA85800A - MONDOVI' 1 (MONDOVI') A : CNAA859006 - MONDOVI' 2 (MONDOVI') PUNTI 155 6. PELLEGRINO ELENA . 12/ 4/78 (CN) DA : CNAA033003 - FOSSANO-SECONDO CIRCOLO (FOSSANO) A : CNAA032007 - FOSSANO-PRIMO CIRCOLO (FOSSANO) PUNTI 34 7. SEIMANDI LAURA . 3/10/64 (CN) DA : CNAA85700E - CUNEO-CORSO SOLERI (CUNEO) A : CNAA86000A - CUNEO VIALE ANGELI (CUNEO) PUNTI 236 SMOW5A 14-05-16PAG. 2 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - POSTO DI SOSTEGNO MINORATI FISIOPSICHICI 1. -

L'economia Cuneese
L’economia cuneese di fronte alla sfida della crisi 1 Per sopravvivere efficacemente in un ambiente competitivo la Provincia di Cuneo dovrà assumere la connotazione di Territorio sistema vitale Entità Entità spazialmente verso Socio-economica limitata organizzata GEO-COMUNITÀ Sviluppo Obiettivo: garantire la sopravvivenza Competitività 2 La provincia di Cuneo ricca di IMPRESE DI CRISTALLO Estremamente Estremamente preziose fragili Sono il motore Devono essere supportate, di sviluppo dell’economia difese e protette 3 Scenario di riferimento delle imprese di cristallo Tendenze per l’anno 2009 Diminuzione Mercati finanziari Azzeramento del potere Aree lontani della crescita New comers di acquisto di disagio sociale dalla ripresa del PIL reale Difficoltà di Contrazioni Rallentamento Redistribuzione Tensioni reperimento fondi dei consumi nello sviluppo dei mercati 4 La Provincia Granda di fronte alla sfida della recessione Scelte vincenti Basate su Sinergia Capacità Passione Capacità di cogliere Legame virtuosa di investire per il le richieste con il territorio tra i settori in mercati prodotto del mercato di nicchia Riflettono le VIRTÙ 5 La Granda nell’ambito del Piemonte sud-occidentale: la criticità CROCEVIA tra la nostra Penisola ed il resto dell’Europa Forte criticità per la Provincia di Cuneo Rischio di perdere il “treno” ⇓ Carenze infrastrutturali 83° posto per le infrastrutture Aeroporto Levaldigi Rete stradale Collegamento in cerca di soluzioni Rete ferroviaria Compromessa con la Francia efficaci per sviluppare obsoleta da una stasi inadeguato ai tempi inarrestabile le grandi potenzialità 6 Il diamante delle infrastrutture Stradale 250 Tot 200 Ferroviaria 150 100 Strutt. San Aereoporti e bacini 50 0 Strut. Istr. Energ. amb. Strut. Ricr Telefon.