Scarica Il Documento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
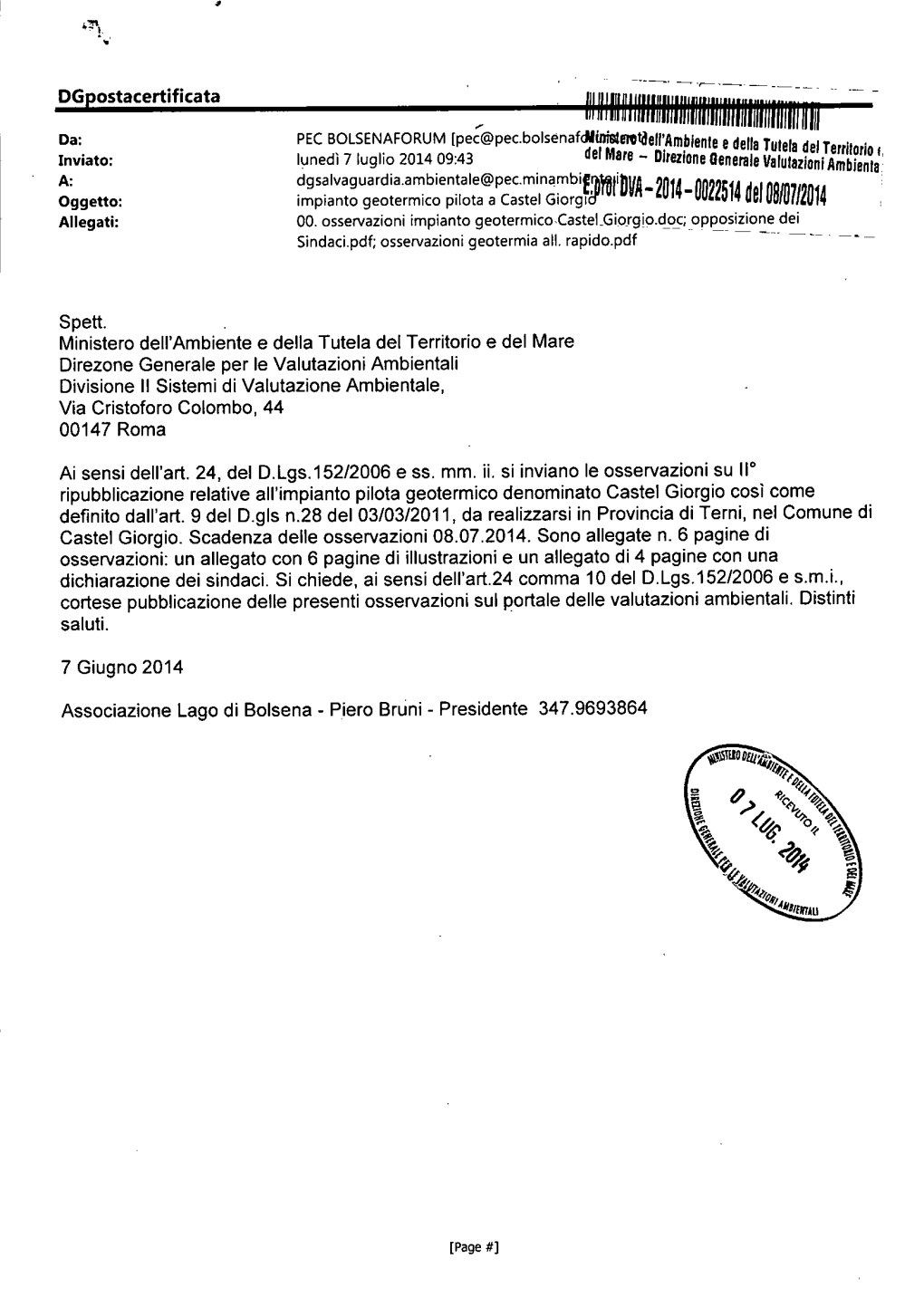
Load more
Recommended publications
-

10.1 - Frequenza Delle Sorgenti Di Inquinamento Elettromagnetico(SRB) (P)
10.1 - Frequenza delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico(SRB) (P) Definizione dell’indicatore e metodologia di calcolo L’indicatore intende misurare la presenza sul territorio delle sorgenti di onde elettromagnetiche non ionizzanti quali le Stazioni Radio Base per telefonia mobile (SRB). Obiettivo ambientale auspicabile Minore esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Evidenze riscontrate All’interno del territorio della provincia di Viterbo al giugno 2005 erano presenti 198 Stazioni Radio Base (SRB), sui cui siti si ritrovano 260 antenne con 626 celle. Nelle figure 10.1.1, 10.1.2, e 10.1.3 è riportato il numero di stazioni radio base, di antenne e di parabole, suddiviso per operatore. Fig.10.1.1: N. stazioni radio base nella provincia di Viterbo per operatore (dati fino a Giugno 2005) 80 72 70 60 52 50 45 40 30 28 n. stazioni radio base radio stazioni n. 20 10 0 TIM Vodafone H3G WIND Fonte: Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni 1 Fig.10.1.2: N. antenne nella provincia di Viterbo per operatore (dati fino a Giugno 2005) 100 90 90 82 80 70 70 60 50 40 28 n. stazionin. radio base 30 20 10 0 TIM Vodafone H3G WIND Fonte: Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni Fig.10.1.3: N. parabole nella provincia di Viterbo per operatore (dati fino a Giugno 2005) 250 212 200 174 162 150 100 78 n. stazioni n. radio base 50 0 TIM Vodafone H3G WIND Fonte: Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale per le Concessioni e le Autorizzazioni 2 La localizzazione delle stazioni è riportata nelle tabelle seguenti (Tab. -

3.1 – Presenza Di Aree a Rischio Idrogeologico in Attuazione Della
3.1 – Presenza di aree a rischio idrogeologico In attuazione della Legge 183/89 è stato emanato il D.L. n. 180 dell’11 giugno 1998 (Decreto Sarno) con la finalità di individuare le aree a più elevato rischio idrogeologico e di adottare idonee misure di salvaguardia e prevenzione. La difesa del suolo diviene in tal modo, se pur sulla base della emotività scatenata dalla tragedia di Sarno, una attività preventiva e non, come in precedenza, riparativa di danni ormai avvenuti sul territorio. Lo stesso decreto fu convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 e promulgato il D.P.C.M 29 settembre 1998 per la individuazione dei criteri relativi agli adempimenti da compiere in merito alla perimetrazione delle aree esposte a diversi livelli di rischio. Esso traccia, inoltre, la fase di programmazione della mitigazione del rischio attraverso elaborazioni, anche grafiche tali da individuare le tipologie di interventi da realizzare per mitigare o rimuovere lo stato di rischio. In attesa di un riordino successivo all’entrata in vigore del nuovo Decreto legislativo 152/2006 si riportano le strategie di intervento fino ad oggi attuate per quanto riguarda la difesa del suolo. Esse si inquadrano nell’ambito della pianificazione di bacino che le 5 Autorità di bacino competenti sul territorio regionale (Tevere, Liri-Garigliano, Fiora, Tronto, Bacini regionali) elaborano ed approvano. Lo strumento pianificatorio attualmente approvato e vigente su tutto il territorio regionale è il Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico (PSAI). Le Autorità di Bacino che interessano il territorio provinciale sono tre, di seguito si riportano i dati salienti (Tab. -

Giornale Civitella
COMUNE DI ONANO www.comune.onano.vt.it Supplemento al numero 15/16 del Periodico IL?CENTRO?ITALIA ? Dicembre 2016 ? Editore S.Ed Editrice Srl ? Viterbo Un annoBisogna agiredifficile: non sono mancate speculazioni sempre nel rispetto della legge Quest’anno non è facile scrivere il solito articolo di fine anno, o me- glio non è facile scriverlo dopo tutti gli avvenimenti accaduti nel 2016. E’ nella logica e nella democrazia che tutti noi abbiamo il sacrosanto diritto di dire e fare quello che è nella nostra intenzione, ma l’im- portante è che il tutto avvenga senza ledere il diritto altrui. In parole povere bisogna agire se- condo legge. E’ la norma che consente che un determinato numero di per- sone possano costituirsi in co- vengono date risposte. Altra cosa cui le persone che vi scrivono non Comunale ha presentato querela mitati spontanei, ma è da perso- squallida è fare uso di facebook conoscono minimamente la realtà verso persone che hanno diffama- ne responsabili, civili e serie, per attaccare il Comune, o meglio dei fatti. to in maniera ignobile e falsa la che non ci si debbano “vergo- il Sindaco e la Giunta su cose di Non a caso l’Amministrazione Giunta Comunale. gnare” anche di rendere pubbli- Io non dico che l’Amministrazio- ca la propria volontà, il proprio ne Comunale non sbaglia mai, per statuto, i componenti del “diret- carità!, sbagliare è umano, ma non tivo” e le persone che hanno sopporto le persone che chiacchie- aderito a detto comitato. rano senza sapere minimamente Il Comune di Onano, con nota del come stanno le cose. -

1911 1 Acquapendente Anno Ditta Localita' B. Fasc. 1967
1911 ELENCO FASCICOLI CONTENENTI PRATICHE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO “ESAURITI” ACQUAPENDENTE DITTA LOCALITA' ANNO 1 B. FASC. 1967 BISCONTI ARNOLDO VIA CASSIA KM. 137+57 13 434 1967 RONCA NOE' ACQUAPENDENTE 13 435 1968 19 627 D'ORAZIO ADOLFO E RUFFALDI MARIELLAVIALE DELL'ANNUNZIATA 1969 CANTERA GADDO E VENTURI ROSA VIALE DELL'ANNUNZIATA 23 772 1969 CERRINI EVARISTO ACQUAPENDENTE 23 770 1969 GIOACCHINI (IMPRESA) VIA ONANESE 23 767 1969 PERUZZI CORRADO (DITTA) ACQUAPENDENTE 23 766 1969 SMOVICA (IMPRESA) ACQUAPENDENTE 23 771 1969 SODA GIUSEPPE VIA DEL RIVO 23 769 1969 VITALI VITALIANO VIALE DELL'ANNUNZIATA 23 768 1970 BISOGNI ILIO VIA CASSIA – LOC. MADONNINA31 1025 1970 BRAMINI GIUSEPPE LOC. PODERE POPINZO 31 1031 1970 31 1027 CAMPANA VELIA IN FRANCO LOC. TORRE ANNUNZIATA 1970 31 1030 FANI RAFFAELLA E PIERI ALFIA LOC. PORTA DELLA MADONNA 1970 31 1021 FELICIOTTI EDELBERTO VIA DEL RIVO 1970 MONCELSI MARIA IN FORNACA PODERE LAZZANO – OPERE DI MIGLIORAMENTO31 1024 FONDIARIO 1970 NERI NERINO SS.CASSIA KM 132 + 0,48 31 1022 1970 31 1028 PERUZZI (SOCIETA') – TAURELLI E SALIMBENIACQUAPENDENTE (IMPRESA) – CAPANNONE ADIBITO A STALLA 1970 POLI M.CONCETTA IN FABI LOC. PODERE S.PIETRO 31 1026 1970 31 1023 SAVELLI CORNELIA IN CERRINI (IMPRESA)LOC. PORTA DELLA MADONNA 1970 SODA STEFANO LOC. VIGNOLO 31 1029 1971 BENOTTI GIUSEPPE E MUZZI EVELINOLOC. CASINO 40 1329 1971 PRUDENZI GIUSEPPE E ILIO LOC. VILLA FIORENTINA 40 1330 1971 SODA STEFANO VIA CASSIA – LOC. VIGNOLO 40 1328 1972 48 1652 COSTANTINI COSTANTINO E GIOVANNIVIA ONANESE 1972 SM. OVI. CA. (DITTA) – PERUZZI (SOCIETA')LOC. S. CATERINA 48 1651 1974 BERTANI M. -

Path to Rome Walk May 8 to 20, 2018
Path to Rome Walk May 8 to 20, 2018 “A delight—great food and wine, beautiful countryside, lovely hotels and congenial fellow travelers with whom to enjoy it all.” —Alison Anderson, Italian Lakes Walk, 2016 RAVEL a portion of the Via Francigena, the pilgrimage route that linked T Canterbury to Rome in the Middle Ages, following its route north of Rome through olive groves, vineyards and ancient cypress trees. Discover the pleasures of Central Italy’s lesser-known cities, such as Buonconvento, Bolsena, Caprarola and Calcata. With professor of humanities Elaine Treharne as our faculty leader and Peter Watson as our guide, we refresh our minds, bodies and souls on our walks, during which we stop to picnic on hearty agrarian cuisine and enjoy the peace and quiet that are hallmarks of these beautiful rural settings. At the end of our meanderings, descend from the hills of Rome via Viale Angelico to arrive at St. Peter’s Basilica, the seat of Catholicism and home to a vast store of art treasures, including the Sistine Chapel. Join us! Faculty Leader Professor Elaine Treharne joined the Stanford faculty in 2012 in the School of Humanities and Sciences as a Professor of English. She is also the director of the Center for Spatial and Textual Analysis. Her main research focuses on early medieval manuscripts, Old and Middle English religious poetry and prose, and the history of handwriting. Included in that research is her current project, which looks at the materiality of textual objects, together with the patterns that emerge in the long history of text technologies, from the earliest times (circa 70,000 B.C.E.) to the present day. -

First Premarital Screening of Thalassaemia Carriers in Intermediate Schools in Latium
Journal ofMedical Genetics, 1978, 15, 202-207J Med Genet: first published as 10.1136/jmg.15.3.202 on 1 June 1978. Downloaded from First premarital screening of thalassaemia carriers in intermediate schools in Latium E. SILVESTRONI, I. BIANCO, B. GRAZIANI, C. CARBONI, AND S. U. D'ARCA From the 'Centro di Studi-della Microcitemia di Roma% Istituto d'Igiene dell'Universitd di Roma, Italia SUMMARY In the 1975 to 1976 school year, under the auspices of the Health Authorities of the Latium Region, the Rome Microcythaemia Centre carried out for the first time a partial screening survey of thalassaemia carriers among the students of the compulsory intermediate school in Latium. This work was the beginning of a new preventive school health service aimed at the prophylaxis of Cooley's disease. In 23 places investigated in Latium, 17 724 students were examined, 13 354 of whom were in Rome and 4370 elsewhere. The mean percentage of co-operation was 70% and the mean percentage of thalassaemia 2.42%. Thalassaemic students were invited to attend the centre for a check-up along with their families: about half had already come in by the end of June 1976. All students examined, whether normal or thalassaemic, have received written results of the tests. The screening survey aroused notable interest and obtained wide approval both at school and at home. The news of being thalassaemia carriers, even if not welcome, was never the cause of family tragedy. copyright. Under the auspices of and with financial support from Informed consent having been obtained, a team of the Health Authorities of the Latium Region, the doctors took 1 ml venous blood from each student in Rome Microcythaemia Centre initiated and carried out the school dispensary. -

Esordienti Misti
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CALENDARIO FASE PRIMAVERI LE ESORDIENTI MISTI GIRONE A .-------------------------------------------------------------- . -------------------------------------------------------------- . I ! ! I I ! ! I I ! 1 G I O R N A T A ! I I ! 5 G I O R N A T A ! I I-------------------------------------------------------------- I I -------------------------------------------------------------- I I BARCO MURIALDINA A R.L. - CANEPINESE I I BARCO MURIALDINA A R.L. - FONTUS I I FONTUS - CELLENO I I CANEPINESE - PRO ALBA CANINO I I G.B. BAGNAIA - PRO ALBA CANINO I I CURA CALCIO - CELLENO I I VIRTUS MARTA - CURA CALCIO I I G.B. BAGNAIA - VIRTUS MARTA I .-------------------------------------------------------------- . .--------------------------------- ----------------------------- . I ! 2 ! I I ! ! I I ! 1 G I O R N A T A ! I I ! 6 G I O R N A T A ! I I-------------------------------------------------------------- I I -------------------------------------------------------------- I I CANEPINESE - G.B. BAGNAIA I I FONTUS - CANEPINESE I I CELLENO - VIRTUS MARTA I I G.B. BAGNAIA - CELLENO I I CURA CALCIO - BARCO MURIALDINA A R.L. I I PRO ALBA CANINO - CURA CALCIO I I PRO ALBA CANINO - FONTUS I I VIRTUS MARTA - BARCO MURIALDINA A R.L. I .------------------------------------------- ------------------- . -------------------------------------------------------------- . I ! ! I I ! ! I I ! 3 G I O R N A T A ! I I ! 7 G I O R N A T A ! I I-------------------------------------------------------------- I I -------------------------------------------------------------- -

Strutture Private Accreditate
Strutture private accreditate RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) Viterbo (San Martino al VILLA IMMACOLATA Str. Sammartinese, 64/A Cimino) Viterbo (San Martino al VILLA IMMACOLATA Str. Sammartinese, 64/A Cimino) VILLA SERENA Str. Statale Cassia, Km. 103 Montefiascone VILLA BENEDETTA Via S.Barbara, 22 Viterbo VILLA ROSA V.le F.Baracca, 21 Viterbo RSA VITERBO Viale Fiume, 78 Viterbo (La Quercia) RESIDENZA CIMINA Via Dell'Ospedale, 2 Ronciglione L'ASSUNTA Via dei Cappuccini, 1 Bassano Romano MYOSOTIS Via Verga, snc Bomarzo PADRE LUIGI MONTI Via Bertina, 13 Montefiascone S.RITA (Ro.Ri) Via Cassia, Km 37 Nepi VILLA ANNA Via Falisca, 21 Faleria (VT) Hospice VILLA ROSA V.le F. Baracca, 21 Viterbo MY LIFE (Ro.RI) Via Cassia, Km. 37 Nepi CASA DI CURA SALUS V.le Trieste, 97 Viterbo Centri di riabilitazione ex art. 26 Viterbo (San Martino al VILLA IMMACOLATA Str. Sammartinese, 64/A Cimino) VILLA S.MARGHERITA Via Bertina, 13 Montefiascone VILLA BUON RESPIRO Str.Filante, 16 Viterbo AIRRI MEDICAL Via Carlo Cattaneo, 46 Viterbo Psichiatria VILLA ROSA V.le F.Baracca, 21 Viterbo Medicina acuti NUOVA S.TERESA (Ro.Ri) Str. Prov.le Tuscanese, snc Viterbo CASA DI CURA SALUS V.le Trieste, 97 Viterbo Riabilitazione motoria Viterbo (San Martino al VILLA IMMACOLATA Str. Sammartinese, 64/A Cimino) Lungodegenza medica Viterbo (San Martino al VILLA IMMACOLATA Str. Sammartinese, 64/A Cimino) SPECIALISTICA AMBULATORIALE CASA DI CURA SALUS V.le Trieste, 97 Viterbo Nuova CASA DI CURA S.TERESA (Ro.RI) Strada Prov.le Tuscanese, snc Viterbo RADIOLOGIA CIARPAGLINI s.a.s. Via G. Matteotti, 38 Viterbo C.d.R. -

Nepi Monterosi Civita Castellana
Elenco Vie NEPI S R-S-T . S . S Valdiano FFABRI REPUBBLICA PIAZZA DELLA . .D5 3 . S A-B-C S A 1 . S 1 RESISTENZA, VIA DELLA . .A7 . Gabelletta 3 B ADOLINI, VIA . .D6 2 1 ZA R ROMA, VIA . .E1/B6 1 ISTEN ANGUILLARA, VIA . .B8 I V V A RES CAC DI ROMA DELL O ARMA DEI CARABINIERI, P.ZA . .D5 ROSCHINI P.G., VIA . .E5/D6 I I A A A VI V A L ROSSI SEM, VIA . .CD4 ARTIGIANI, VIA DEGLI . .E1/2 I N I D V Regione Lazio A O LE E O E ARL BACHELET, VIA . .D5/6 SAN BERNARDO, PIAZZA . .D5 I P VIA C GNO A V GIU V Monterosi LaghettoC S 2 IA E V R Nepi I . BATTISTI C., VIA . .E5/D6 I SAN BIAGIO, PIAZZA . .C8 A P S I DEI FARNES S M IA D O . A V G I N BOTTATA, PIAZZALE DELLA . .B7 I 2 SAN CARLO BORROMEO, VIA . .D5 O . N M D A CIVITA CADORNA, VIA . .B7 A N I SAN GIOVANNI, PIAZZA . .B8 V I A I T INI S CADUTI, PIAZZA DEI . .BC6 VIA MAZZ SAN PAOLO, VIA . .B7/A9 T CASTELLANA M V A O GUE N CARMINE, VIA DEL . .BC8 R SAN PIETRO, VIA . .C8 I Zona I I SAN O VIA DONATOR A N DI CASTELLANA AGLIANO CATALANI, PIAZZA . .C7 M FABRICA DI R. SAN PIO, VIA . .DE5 Z CATTANEO, VIA . .B5 P M Industriale I N A SAN ROCCO, V.LO . .B9 V O SABINA N O CAVALIERI DI V. -

Intendenza Di Finanza. Danni Di Guerra
INVENTARIO MINISTERO DEL TESORO INTENDENZA DI FINANZA DI VITERBO DIREZIONE GENERALE DEI DANNI DI GUERRA A CURA DI PASQUALE AUTUNNO (2013) 1 Introduzione Intendenza di finanza Organo locale dell’amministrazione finanziaria istituito nel 1869 con il compito di vigilare sulle pubbliche entrate e provvedere alla riscossione di tributi o altri proventi. L’Intendenza di Finanza fu istituita in ogni capoluogo di provincia in seguito alla legge 26 settembre 1869, n. 3286 e R.D. 18 dicembre 1869, n. 5397 con compiti di controllo sul personale e di coordinamento sulle attività degli uffici finanziari. Alle Intendenze furono attribuite le competenze delle Direzioni compartimentali esistenti nei vari rami dell'amministrazione finanziaria: demanio e tasse sugli affari, imposte dirette, catasto, pesi e misure e gabelle. Il R.D. 22 gennaio 1922, n.200 sul decentramento delle funzioni alle Intendenze di Finanza e il R.D. 25 marzo 1923 n. 796 sul contenzioso penale tributario, ampliarono i poteri e i compiti dell’Intendenze, in tale modo gli Intendenti furono chiamati "prefetti finanziari". L'Intendenza di finanza di Viterbo, organo amministrativo finanziario di competenza territoriale pari a quella della provincia, fu istituita nel 1927 ((R.D.L. 17/1/1927, n.42) ma la formazione dell'archivio risale ad un periodo anteriore. La legge del 29 ottobre 1991, n. 358 ha dettato le norme sulla ristrutturazione del Ministero delle Finanze prevedendo l’abolizione delle Intendenze . La documentazione in oggetto tratta di pratiche relative ai danni di guerra e alle richieste di indennizzo dei danni subiti. Sono state versate all'ASVT nel 1982 e nel 1987 (1944-1980). -

Rund Um Den Lago Di Bolsena Der Annähernd Kreisrunde Bolsena-See Liegt Im Nördlichen Zipfel Von La- Tium, Fast in „Sichtweite“ Der Südlichen Toskana Und Umbriens
56 Lago di Bolsena Capodimonte am Bolsena-See im Abendlicht Rund um den Lago di Bolsena Der annähernd kreisrunde Bolsena-See liegt im nördlichen Zipfel von La- tium, fast in „Sichtweite“ der südlichen Toskana und Umbriens. Wegen der günstigen Windverhältnisse ist der See darüber hinaus bei Surfern und Seg- lern beliebt. Enstanden ist der 14 km lange und 12 km breite Lago di Bolsena vor etwa 300.000 Jahren aus vulkanischer Aktivität: Im Gebiet rund um den heutigen See spuckten mehrere Vulkane unentwegt Lava aus, sodass sich unterirdische Magmakammern leerten und schließlich in sich zusammenbrachen. Zurück blieb ein gigantisches Loch, das sich nach und nach mit Wasser füllte. Den augenfälligsten Hinweis auf den vulkanischen Ursprung des Sees liefern seine schwarzen, mit Tuffpartikeln durchsetzen Strände. Die von bäuerlichen Kleinbetrieben bewirtschaftete Landschaft rund um den See, Lago di der auf gut ausgebauten Straßen komplett umfahren werden kann, strahlt eine Bolsena wohltuende, romantische Ruhe aus. Geprägt ist sie von weich gewellten Hügelfor- mationen, vielerorts reichen auch schöne Buchenwälder und Wiesen an den See heran, vereinzelt gedeihen Weinreben. Mehrere alte Ortschaften liegen malerisch direkt am Ufer oder auf den hügeligen bzw. felsigen „Aussichtbalkonen“ hoch über dem See: im Süden die beiden Küstenorte Marta und Capodimonte (mit einem in Privatbesitz befindlichen Farneseschloss), im Nordwesten das oberhalb des Sees auf einer Hangkante gelegene Gradoli, im Südosten das kleine, für seinen Wein be- Rund den L di Bols Toscanca a BolsenaRund um den Lago di Bolsena 57 Civita di Lago di Bagnoregio Bolsena Lago di Bolsena CiviCivi veccvecc GenzanoGenzano AnagniAnagni FiumicinFiumicin i RomaRoma AlatriAlatri VelletriVelletri FroFro ApriliaAprilia LatinaLatina Ǥ AnzioAnzio Karte S. -

SNC, VIA VASIANO, 01037, Ronciglione (VT) Italia 0761/625484
F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM V I T A E INFORMAZIONI PERSONALI Nome STOCCHI VITTORIO Indirizzo SNC , VIA VASIANO , 01037, Ronciglione (VT) Italia Telefono 0761/625484 – mobile: 339/7040030 Fax 0761/625484 E-mail [email protected] Nazionalità italiana Data di nascita 17/07/1961 ALCUNE ESPERIENZE LAVORATIVE • Date (dal 1991) Consulente geologico tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo (aree in frana su s. p. Orte – Vasanello, lungo le provinciali per Civita Castellana e Castel S.Elia (2006, 1.000.000 €), s.p. Marignano Centinano (10 miliardi di Lire 1998), studio geomorfologico del lago di Vico ecc. Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di un versante del comune di Montalto di Castro (VT), (500.000 euro, 2005). Applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione di un versante proprietà Acque di Nepi, Nepi (VT), (130.000 euro, 2007). Adeguamento sismico plesso scolastico Paolo III di Canino VT (2006, 1.500.000 €); Adeguamento sismico plesso scolastico di Carbognano VT (2007, 300.000 €); Consulente geotecnica per costruzioni Guardia di Finanza (area di Castiglione del Lago PG, 2006 300.000 €) Relazioni geotecniche per enti privati e pubblici quali scuole, abitazioni, caserme, parcheggi interrati ed a raso, capannoni industriali (p.es. soc. Acque di Nepi, 4.000.000 € 2005) ecc. Lavori di sistemazione idrogeologica comune di Faleria (360.000 € 2007); Indagine geotecnica realizzazione nuova scuola materna (Sutri, 1.000.000 € 2009,); Indagine geotecnica ampliamento scuola