Rapporto Ambientale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
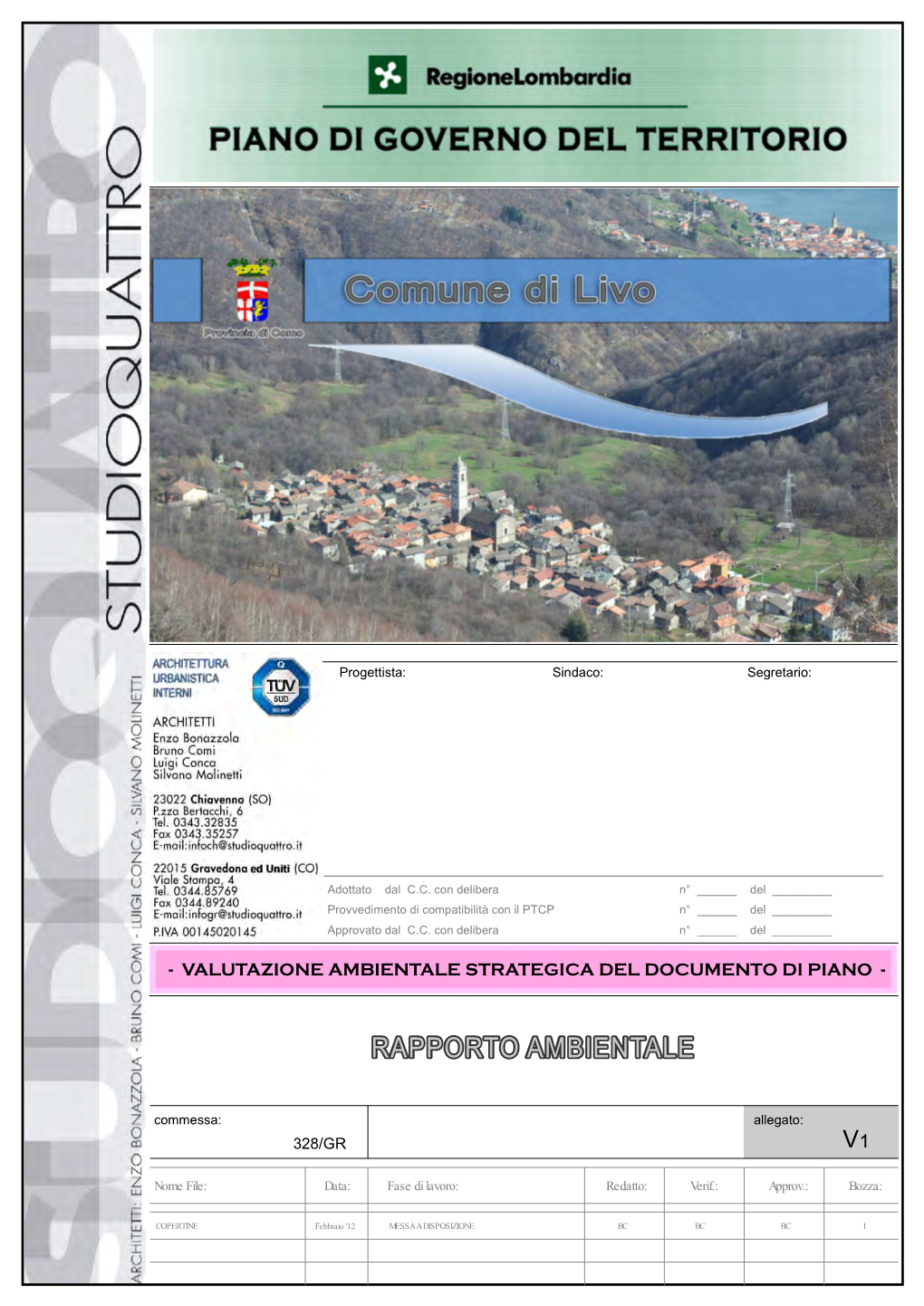
Load more
Recommended publications
-

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como
1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

Bandi Youthbank
Como, 25 febbraio 2019 All’attenzione delle amministrazioni comunali della provincia di Como OGGETTO: BANDI YOUTHBANK La Fondazione Comasca in collaborazione con quattro non profit della provincia mette a disposizione 150.000 € per progetti realizzati da ragazzi under 25 nel territorio della provincia di Como. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella provincia di Como entro il 2 maggio 2019. I progetti non potranno essere a scopo di lucro e dovranno essere di utilità sociale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.nonunodimeno.eu/youthbank o contattare le singole YouthBank. Per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie iniziative, ogni YouthBank mette a disposizione risorse umane in grado di aiutare gli interessati nella fase di progettazione e realizzazione del progetto. BANDO YOUTHBANK COMO – 6° 2018 Risorse a disposizione: euro 40.000 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto) Importo massimo del progetto: 6.000 euro Comuni nei quali possono realizzarsi i progetti: Albese con Cassano, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio; (N.B. I progetti realizzati nei comuni di Lezzeno e Bellagio possono essere presentati SOLO sul Bando YouthBank Centro Lago 2018) Si terranno presso la Fondazione Comasca il 6 marzo e il 19 marzo alle ore 15,00 due incontri di formazione per i ragazzi partecipanti su progettazione e raccolta fondi. -

TREKKING PROVINCIA DI COMO Settore Turismo
TREKKING PROVINCIA DI COMO Settore Turismo In futuro, il turismo attivo sarà la formula vincente per lo sviluppo turistico di qualsiasi territorio; il Lago di Como, da sempre meta di un turismo legato al lago e alla sua rilassante bellezza, intende rafforzare e ampliare la propria offerta, già interessante, in questo segmento di mercato ormai strategico. Oggigiorno numerose sono le attività sportive praticabili sul nostro territorio, dai più classici sport nautici: vela, surf, canotaggio e kitesurf, al ciclismo e al più sofisticato golf, per non parlare delle passeggiate a cavallo, ma è il Trekking che da sempre ha esercitato un particolare fascino, permettendo di scoprire antichi sentieri, vecchi cam - minamenti e, nel contempo, di ammirare paesaggi unici per bellezza del nostro territorio. Con questo intento si è realizzata la nuova edizione della guida Lago di Como - Trekking , proponendo una ver - sione aggiornata dei testi e dei punti di appoggio dei tre più collaudati itinerari a piedi della nostra zona. La Via dei Monti Lariani , che rimane lo storico percorso di trekking, di 125 km, e si snoda lungo i “monti” della sponda occidentale del Lago e da dove si godono panorami mozzafiato. La Dorsale Como Bellagio , un bellissimo percorso di 2 giorni che attraversa in verticale il “Triangolo Lariano”, cioè quel territorio compreso tra i due rami del Lago di Como. Il Sentiero delle 4 Valli , forse il meno noto dei tre ma altrettanto affascinante, soprattutto per i luoghi sorpren - dentemente incontaminati che ci propongono queste bellissime vallate. La pubblicazione della guida dei Trekking del Lago di Como ha l’intento di offrire al turista uno strumento utile per la scoperta di angoli paesaggistici della nostra zona altrimenti poco noti e una motivazione forte per prolun - garne il soggiorno in questo angolo di paradiso che è il lago di Como. -

Giro Montano Del Lario 2013 Dettaglio Tappe E Orari Di
ASD FALCHI LECCO GIRO MONTANO DEL LARIO 2013 Staffetta no-stop - 250 km - 12.000 m D+ 7-9 giugno 2013 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FALCHI LECCO - Via S. EgiDio, 31 | 23900 Lecco (LC) Tel. 339 7393485| Web: www.asfalchi.it | E-mail: [email protected] | P. IVA e C.F.: 03011410135 DETTAGLIO TAPPE E ORARI DI PASSAGGIO Distanza Dislivello tappa Orario di passaggio: Tempo tappa Tappa Percorso tappa D+ (m) D- (m) Lecco 7/6/13 19.35 (km) 1 LECCO - ABBADIA Lecco, Val CalolDen, Piani Resinelli, Campelli, Abbadia L. 01:50 14 1277 1234 Abbadia 7/6/13 21.25 Sentiero del Viandante 2 ABBADIA - LIERNA Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna 01:15 10 353 341 Lierna 7/6/13 22.40 Sentiero del Viandante 3 LIERNA - DERVIO Lierna, Variante Alta, Ortanella, Bellano, Dervio 03:05 18 1045 1098 Dervio 8/6/13 1.45 Sentiero del Viandante 4 DERVIO - COLICO Dervio, Santuario MaDonna Di ValpoZZo 02:25 15 659 676 Valpozzo 8/6/13 4.10 5 COLICO - SORICO SS36, SS340dir, pista ciclabile 00:40 6 13 0 Sorico 8/6/13 4.50 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 6 SORICO - PEGLIO Sorico, ForDeccia, Montalto, Livo, Peglio 04:15 22 1205 680 Peglio 8/6/13 9.05 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 7 PEGLIO - GARZENO Peglio, Dosso Del Liro, PiazZa, GarZeno 03:05 24 626 612 Garzeno 8/6/13 12.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 3 8 GARZENO - CROCE GarZeno, Montuglio, Breglia, GranDola eD Uniti, Croce 05:00 26 858 1190 Croce 8/6/13 17.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 2 9 CROCE - S. -

Cartelli Fine Della Guerra
La ne della guerra Le vie della salvezza verso la Svizzera I percorsi partigiani tra i due laghi A Paths to freedom towards Switzerland B Partisan routes between the two lakes San Siro, località Santa Maria Rezzonico Claino con Osteno. Il capitano Ricci e la prima Resistenza San Siro, Santa Maria Rezzonico Hamlet Claino con Osteno. Captain Ricci and the early Resistance Cremia Porlezza. Il controllo fascista e la guerriglia partigiana Cremia Porlezza. Fascist control and partisan guerrilla Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. Le prime bande fra Porlezza e Galbiga Dosso del Liro Carlazzo, S. Pietro Sovera. The first armed bands between Porlezza and Galbiga San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Gli sfollamenti sul Lario San Bartolomeo Val Cavargna Tremezzo. Lake Como evacuations San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. Le residenze di ministri e gerarchi della RSI San Nazzaro Val Cavargna Griante, Cadenabbia. The Residences of ministers and fascist leaders of the RSI Cavargna Lenno, Monte Galbiga. La prima azione partigiana in centro lago Cavargna Lenno, Monte Galbiga. The first partisan action in the Center Lake region Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Abbazia dell'Acquafredda. La Resistenza civile del clero Cavargna, Bocchetta di Stabiello Lenno, Acquafredda Abbey. Civil Resistance of the clergy Cavargna, Passo di San Lucio e Monte Garzirola Lenno. L'attività del Comitato di Liberazione Nazionale Cavargna, San Lucio Pass and Mount Garzirola Lenno. The activities of the National Liberation Committee Gravedona ed Uniti, Passo di San Iorio Ossuccio, località Boffalora. Crocevia e base partigiana Gravedona ed Uniti, San Iorio Pass Ossuccio, Boffalora Hamlet. Crossroads and partisan headquarters Mezzegra, confine con Lenno. -

Fognatura - Infrastrutture Presenti.Xlsx - Infrastrutture Fognatura
Allegato 4.4b - Fognatura - infrastrutture presenti.xlsx - Infrastrutture fognatura CONFORMITA' DIRETTIVA 91/271/CE Terminali di Comune Lunghezza % in corso STIMA RETE Comune ricadente Comune non RETE FOGNARIA Stazioni di Scaricatori fognatura sottoscrittore e reti fognarie copertura ADEGUAMENTO DA in bacino Contratto ricadente in bacino sollevamento di piena (AE recapitati ricadente in bacino (km) servizio COMPLETO REALIZZARE di Fiume Contratto di Fiume in ambiente) Contratto di Fiume Albavilla 0 9 30,2 98,8% 0 0 360 X Albese con Cassano 0 6 24,3 100,0% 0 0 0 X Albiolo 2 0 10,2 100,0% 0 0 0 X Alserio 1 0 6,0 100,0% 0 0 0 X Alzate Brianza 4 8 22,1 100,0% 0 0 0 X Anzano del Parco 0 0 18,6 100,0% 0 0 0 X Appiano Gentile 1 9 29,2 98,8% 0 x 340 X Argegno 1 6 4,7 100,0% 0 0 0 X Arosio 0 0 15,0 100,0% 0 0 0 X Asso 0 5 24,1 100,0% 0 0 0 X Barni 0 0 2,1 87,9% 0 x 250 X Bellagio 12 3 14,1 100,0% 0 0 0 X Bene Lario 0 1 7,3 100,0% 0 0 0 X Beregazzo con Figliaro 1 2 13,0 100,0% 0 0 0 X Binago 0 6 17,7 100,0% 0 0 0 X Bizzarone 4 2 9,3 100,0% 0 0 0 X Blessagno 0 2 2,3 100,0% 0 0 0 X Blevio 2 4 4,5 100,0% 1.405 x 0 X Bregnano 2 4 21,8 100,0% 0 x 0 X Brenna 1 3 17,0 100,0% 0 0 0 X Brienno 0 3 2,5 75,9% 270 0 600 X Brunate 0 0 12,5 95,0% 0 0 625 X Bulgarograsso 0 4 13,5 100,0% 0 0 0 X Cabiate 0 10 30,0 100,0% 0 0 0 X Cadorago 1 7 27,1 98,7% 0 x 355 X Caglio 0 3 4,6 98,5% 0 x 70 X Cagno 4 1 5,9 100,0% 0 0 0 X Campione d'Italia 2 2 14,2 100,0% 0 0 0 X Cantù 0 21 114,7 99,8% 0 0 700 X Canzo 1 11 19,9 97,0% 0 x 600 X Capiago Intimiano 1 8 21,9 100,0% 0 0 -

Dm 26 Maggio 2016
PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Livo Montemezzo Dosso del Liro Sorico Peglio VercanaTrezzone Gravedona ed Uniti Gera Lario Stazzona Domaso Garzeno Dongo Musso CavargnaSan Nazzaro Val Cavargna Pianello del Lario San Bartolomeo Val Cavargna Cremia Cusino Val Rezzo Plesio San Siro Corrido Carlazzo Grandola ed Uniti Valsolda Porlezza Bene Lario Menaggio Claino con Osteno Ponna Griante Tremezzina Laino Alta Valle Intelvi Campione d'Italia Sala Comacina BlessagnoPigra Colonno Bellagio Centro Valle Intelvi Dizzasco Argegno Lezzeno Cerano d'Intelvi Centro Valle IntelviSchignano Magreglio Veleso Brienno Cerano d'Intelvi Barni Nesso Zelbio Sormano Laglio Lasnigo Pognana Lario Carate Urio Valbrona Caglio Moltrasio Asso Faggeto Lario Rezzago Cernobbio Torno Canzo Maslianico Caslino d'Erba Bizzarone Blevio Castelmarte Ronago Ponte LambroProserpio Rodero Uggiate-Trevano Brunate Longone al SegrinoEupilio Valmorea Pusiano Tavernerio San Fermo della Battaglia Faloppio Albese con CassanoAlbavilla Albiolo Colverde Como Erba Solbiate con Cagno Montano Lucino Lipomo Olgiate Comasco Merone Montorfano Alserio Orsenigo Monguzzo BinagoBeregazzo con Figliaro Villa Guardia Grandate Capiago Intimiano Anzano del Parco Lurate Caccivio Senna Comasco Alzate Brianza Luisago Lambrugo Castelnuovo Bozzente Casnate con Bernate Lurago d'Erba Oltrona di San MametteCassina Rizzardi Bulgarograsso Brenna Fino Mornasco Cucciago Cantù Appiano Gentile Guanzate Inverigo Anno 2010 Vertemate con Minoprio Cadorago Arosio Veniano Figino Serenza Carugo Carimate -

Pescare Nel Bacino 5 (Verbano
ANNO 2020 2 INDIRIZZI UTILI E RIFERIMENTI TERRITORIALI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Varese Orario di apertura al pubblico: Viale Belforte, 22 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 21100 VARESE (VA) ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Attività: gestione faunistica Sportello Utenza: 0332.338367 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA INSUBRIA -Como Orario di apertura al pubblico: Via L. Einaudi, 1 ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 22100 COMO (CO) Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 031.320570 [email protected] AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Brianza -Lecco Corso Promessi Sposi, 132, Orario di apertura al pubblico: 23900 LECCO (LC) ▪ da lunedì a venerdì: 09.00 - 12.30 Attività: gestione faunistica ▪ Mercoledì: 14.30 - 16.30 Sportello Utenza: 0341.358946 [email protected] PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO 4 PESCARE NEL BACINO 5 – VERBANO LARIO CERESIO PREMESSA Questa pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale; essa riassume i regolamenti di pesca in vigore nel bacino n° 5 -Verbano, Lario, Ceresio- al 1 gennaio 2020 Il bacino 5 comprende la porzione lombarda dei laghi Verbano, Ceresio, Lario e i laghi Mezzola, Garlate e Olginate, Varese, Comabbio, Monate, Montorfano, Alserio, Segrino, Piano, Pusiano, Annone, con i loro tributari. Sono escluse tutte le acque che ricadono nella Provincia di Sondrio. Appartengono al bacino 5 il fiume Adda immissario nel tratto compreso fra il Lario e il confine con la provincia di Sondrio, il fiume Adda emissario fino al nuovo Ponte ferroviario del Lavello, il fiume Ticino fino al ponte di Sesto Calende, il fiume Olona fino al ponte di Vedano e il fiume Lambro fino al ponte di Nibionno sulla Sp 342. -

Scarica Le Informazioni Sui Seggi Allestiti Per Il Voto Delle Primarie
ELEZIONI PRIMARIE Domenica 18 novembre per la scelta del Segretario e dell’Assemblea Regionale Ecco dove votare in provincia di Como PER INFORMAZIONI www.pdlombardia.it - www.partitodemocratico.co.it Ecco dove votare in provincia di Como Gli orari di apertura sono indicati a fianco di ciascun seggio COMUNE SEDE DI VOTO ORARIO COMUNE SEDE DI VOTO ORARIO Sala Affreschi Casnate Albavilla 11.30 / 20.00 Si vota a Cucciago Ex Municipio di Albavilla con Bernate Albese con Cassina Rizzardi Si vota a Cucciago Si vota a d Albavilla Cassano Castelmarte Si vota a Canzo Albiolo Si vota a Uggiate Trevano Castelnuovo Si vota a Appiano Gentile Alserio Si vota a d Albavilla Bozzente Alta Valle Intelvi Si vota Centro Valle Intelvi Loc. San Fedele Intelvi Biblioteca Comunità Alzate Brianza Si vota a Erba Centro Valle Intelvi 8.00 / 20.00 Anzano del Parco Si vota a Erba Montana Lario Intelvese Via Roma 8 Ex Municipio Appiano Gentile 8.00 / 13.00 P.zza Libertà, 13 Cavargna Si vota a Tremezzina Cerano Intelvi Si vota Centro Valle Intelvi Argegno Si vota a Tremezzina Palazzina Sala Civica Arosio Si vota a Mariano comense Cermenate 8.00 / 13.00 Via Garibaldi, 3 Asso Si vota a Canzo Sala Consiliare del Comune, Cernobbio 8.00 / 13.00 Barni Si vota a Canzo dietro al Municipio Bellagio Si vota a Pognana Lario Cirimido Si vota a Lomazzo Bene Lario Si vota a Tremezzina Claino con Osteno Si vota a Tremezzina Beregazzo Si vota a Appiano Gentile Colonno Si vota a Tremezzina con Figliaro Colverde Si vota a Villa Guardia Binago Si vota a Appiano Gentile Como Albate Sala Felice Villa 8.00 / 13.00 Bizzarone Si vota a Uggiate Trevano sez. -

La Via Dei Monti Lariani
LA VIA DEI MONTI LARIANI È un bellissimo percorso escursionistico che da Cernobbio collega località disseminate 4 SORICO lungolemontagnedellaspondaoccidentale VALLE ALBANO del lago di Como, giungendo =no a Sorico GARZENO dopo un tragitto di 125 km. 3 Moltissime di queste località, comprese in VAL una fascia variabile dai 600 ai 1200 metri di MENAGGIO 2 altitudine, erano un tempo alpeggi (deno- GRANDOLA ED UNITI VAL minatimûnt),utilizzatidallepopolazionico- D INTELVI stiere del Lario (nome antico del lago di Como); da qui il nome 'VIA DEI MONTI LA- SAN FEDELE RIANI', intesa appunto come strada di colle- gamento tra questi antichi insediamenti in 1 parte ancora attivi, in parte abbandonati o distrutti dal tempo. CERNOBBIO Si tratta di un sentiero frequentabile da escursionisti con preparazione elementare, COMO che consente di ammirare panorami esclusivi ed é uno degli itinerari più interes- santi delle montagne lombarde. Il percorso, progettato dal CAI di Como, é interamente segnato e diviso in quattro sezioni. La prima va da Cernobbio alla Val d'Intelvi ed é lunga 28 km, la seconda dalla Val d'Intelvi alla Val Menaggio (26 km.), la terza dalla Val Menaggio alla Valle Albano (24 km.) e la quarta dalla Valle Albano a Sorico (46 km.). I segnavia (bandierine rosse-bianche-rosse in vernice sui sassi e in alluminio sui tronchi e sui muri) di conseguenza riportano la numerazione da 1 a4.SulpianopraticoèestremamentediFcilepercorrerelaViadeiMontiLarianiin4tappe,essendoque- ste troppo lunghe e impegnative. Si propone di suddividerle in almeno 6 tappe, pernottando nei rifugi oneglialberghidislocatilungoilcammino.Itempiindicatinelladescrizionedelpercorsosonoperescur- sionistiallenati.La'Via'puòessereseguita anchepertratti parzialieinentrambi isensi; lestrade, lemu- lattiere che si percorrono, o;rono numerose possibilità di ritorno a valle, attraverso sentieri non sempre segnalati. -

PAI) Interventi Sulla Rete Idrografica E Sui Versanti
Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 11.05.1999 3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico 3.6 Adda sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna) Parte 1 – assetto idrogeologico Indice parte 1 Indice parte 1 1 Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino dell’Adda sopralacuale ........................................................................................................................... 1 1.1 Caratteristiche generali ....................................................................................................1 1.1.1 Inquadramento fisico e idrografico ......................................................................... 1 1.1.2 Caratteri generali del paesaggio............................................................................. 6 1.1.3 Aspetti geomorfologici e litologici ........................................................................... 8 1.1.4 Aspetti idrologici...................................................................................................... 9 1.1.4.1 Caratteristiche generali................................................................................ 9 1.1.4.2 Portate di piena e piene storiche principali................................................ 10 1.1.5 Assetto morfologico e idraulico............................................................................ -

Gravedona, 15 Aprile 2009
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana SEDE LEGALE: Via Maglio 31 - 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) - C.F. e P.I. 03160550137 SEDE OPERATIVA: Via Don P. Pedroli 2 – 22015 – Gravedona ed Uniti (CO) – tel. 0344 916031 – fax 0344 85684 - [email protected] ________________________________________________________________________________________________________________ DIREZIONE Direttore – Angelo Barindelli AMBITO ORIENTAMENTO E POLITICHE DEL LAVORO - Responsabile Ambito - Chiara Sotgiu SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZI PER IL LAVORO - Chiara Sotgiu - Karis Nonini e-mail: [email protected] SPORTELLO PER L'ASSISTENZA FAMILIARE - Chiara Sotgiu e-mail: [email protected] - Karis Nonini e-mail: [email protected] - Francesca Gioé e-mail: [email protected] AMBITO MINORI E FAMIGLIA SERVIZIO TUTELA MINORI - Marzia Giana - Cristina Gilardoni e-mail: [email protected] UNITA' OPERATIVA PENALE MINORILE - Marzia Giana - Cristina Gilardoni e-mail: [email protected] SERVIZIO EDUCATIVO MINORI - Marzia Giana -Cristina Gilardoni SERVIZIO ACCOGLIENZE E AFFIDI - Marzia Giana - Cristina Gilardoni e-mail: [email protected] UNITA' OPERATIVA ADOZIONI - Marzia Giana -Cristina Gilardoni AZIENDA SPECIALE CONSORTILE Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno,