L'emigrazione Italiana in Argentina (Parte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
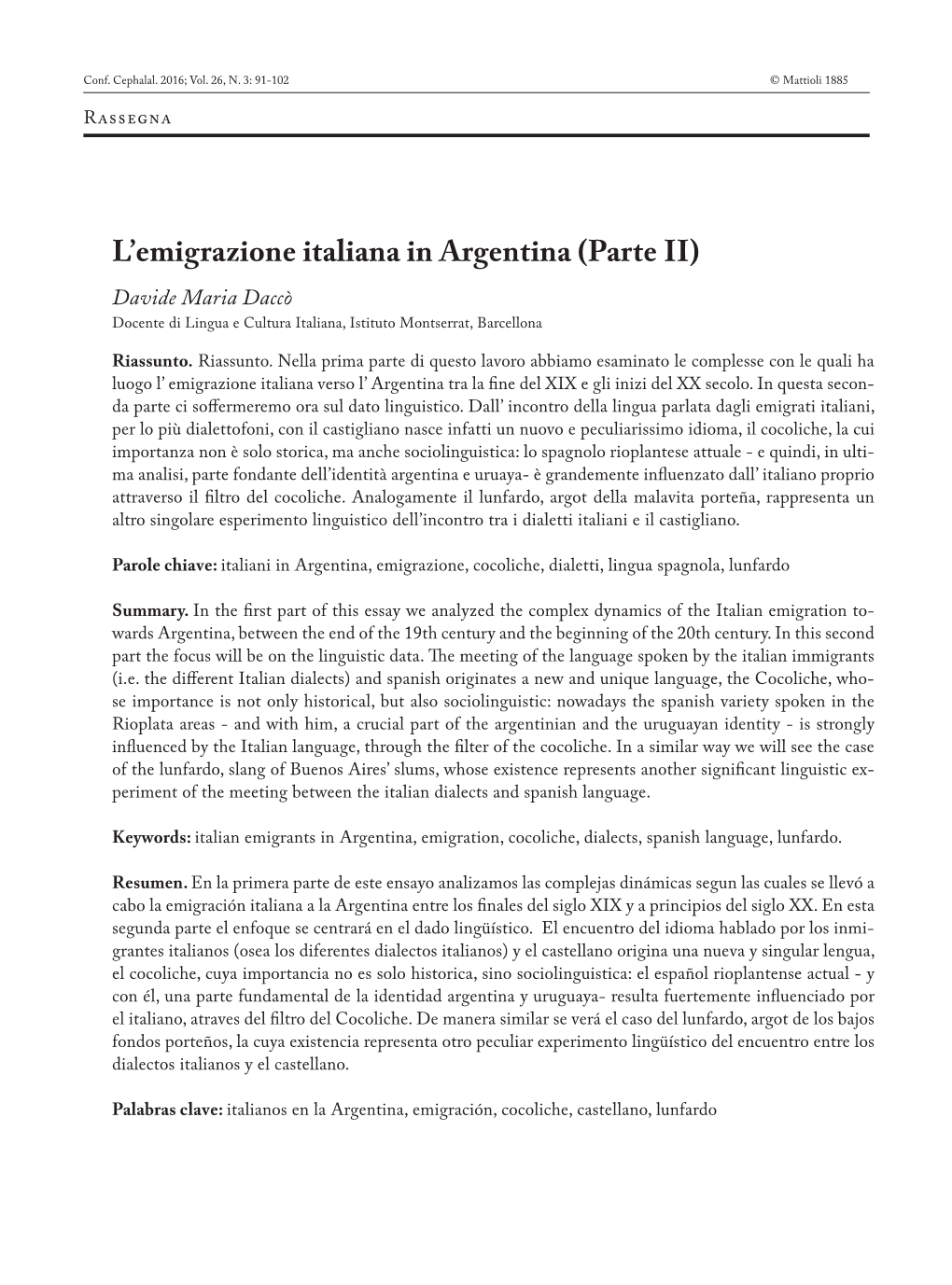
Load more
Recommended publications
-

CHE MALAMBO MARCH 10, 2020 10:00Am
CHE MALAMBO MARCH 10, 2020 10:00am STANDARDS DA:Ra.7.1 Perceive and analyze artistic work. DA:Re8.1 Interpret intent and meaning in artistic work. DESCRIPTION OF MATINEE Presenting a thrilling, percussive dance and music spectacle, Che Malambo’s work celebrates the unique South American gaucho tradition. The Argentine-based company excites audiences through precise footwork, rhythmic stomping, drumming of the bombos, and singing and whirling boleadoras. Danced solely by men, the Malambo began in the 17th century as competitive duels that would challenge skills of agility, strength, and dexterity. Che Malambo brings these fiery traditions and virtuosic dancing to the contemporary stage for an exhilarating and entertaining show that is perfect for the entire family. WHAT’S INSIDE A message from Gilles Brinas La Compañía | The company Que es Che? | What is che? Que es Malambo? | What is malambo? Que es un Gaucho?| What is a Gaucho? El Zapateo | The footwork las Boleadoras | The boleadoras El bombo legüero | The legüero drum Sureño & norteño | Southern & northern Tiempo para poesía| Poetry time Gracias! | Thank you! Reference GRADE RECOMMENDATION: CURRICULUM CONNECTIONS: Elementary, Middle and High School Dance Music World Civilization A MESSAGE FROM GILLES BRINAS Che Malambo is the name of the performance that I have created by incorporating traditional Malambo which is a style of dance practiced in Argentina and a few other South American countries. Like many who fall under the spell of traditional dances, I was fascinated by Malambo. I flew to Buenos Aires in search of this dance so typical of the Pampa region of Argentina. -

EL "COCOLICHE" RIOPLATENSE O. Introducción. 1. Fonética Y Grafía. 2
EL "COCOLICHE" RIOPLATENSE O. Introducción. 1. Fonética y grafía. 2. Léxico. 3. Morfología y deri vación. 4. Sintaxis. 5. Aspectos estilísticos. 6. Conclusión. 7. Textos en cocoliche. O. INTRODUCCION • 0.1. El problema de las resultantes lingüísticas debidas al en cuentro del italiano con el español en el Río de la Plata (es decir, de las influencias recíprocas de las dos lenguas en esta zona) , presenta dos aspectos interesantes para el glotólogo: 1) influencia del español rio platense sobre el italiano hablado en el Plata (sea por los inmigrados, sea por los rioplatenses) 1; 2) influencia del italiano sobre el español hablado en el Plata (tanto por los rioplatenses como por los inmi grados). La diferenciación de estos dos aspectos, que puede resultar bas tante clara en boca de un rioplatense (para el cual la base lingüística • Este trabajo se publicó por pri Instrucción Pública del Uruguay (1956). mera vez en artículos sueltos (en ita La versión española se publica liano) en diferentes números de la re pues, ahora, por vez primera. Lo único vista "Lingua Nostra" de Florencia que el autor le ha agregado es el apén (1955-1956). Luego el autor ha refun dice donde figuran algunos textos de dido los distintos artículos y los ha tra cocolicbe. ducido al español agregando tan sólo algunas pequeñas modificaciones de de 1Estudiantes de italiano, hijos de talle para dar unidad a la obra la que italianos, profesores de italiano, traduc ganó, de esta manera, el premio na tores públicos, o quienquiera que se cional de investigaciones literarias (pa sirva de algún modo, aunque sea oca ra obras inéditas) , del Ministerio de sionalmente, de la lengua italiana. -

Italian-Spanish Contact in Early 20Th Century Argentina
journal of language contact 8 (2015) 112-145 brill.com/jlc Italian-Spanish Contact in Early 20th Century Argentina Juan Antonio Ennis conicet/Universidad de La Plata [email protected] Abstract This article attempts to provide a general approach to the exceptional language contact situation that took place in Argentina from the end of the 19th century until the first decades of the 20th century, in which an enormous immigration flow drastically modified the sociolinguistic landscape. This was most evident in urban environments—and among them especially the Buenos Aires area—and led the local ruling elites to set up a complex and massive apparatus for the nationalisation of the newcomers, which included a language shift in the first stage. Given that the majority of immigrants came from Italy, the most widespread form of contact was that between the local varieties of Spanish and the Italian dialects spoken by the immigrants, which led to the creation of a contact variety called Cocoliche that arose, lived then perished. Although this contact variety did not survive the early years, at least not as a full- fledged variety, the history of its emergence and the ways in which it can be studied today nevertheless make it an object of special interest for research perspectives ori- ented around the question of the early years of language contact. This article gives an account of this history so as to provide an analysis of a series of documents that, in a highly mediated way, can be used as an unreliable but nonetheless interesting corpus for the study of language and culture contact. -

Italian-Spanish Contact in Early 20Th Century Argentina
Ennis, Juan Antonio Italian-Spanish Contact in Early 20th Century Argentina Journal of language contact 2015, vol. 8, nro. 1, p. 112-145 Ennis, J. (2015). Italian-Spanish Contact in Early 20th Century Argentina. Journal of language contact, 8 (1), 112-145. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9987/pr.9987.pdf Información adicional en www.memoria.fahce.unlp.edu.ar Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ journal of language contact 8 (2015) 112-145 brill.com/jlc Italian-Spanish Contact in Early 20th Century Argentina Juan Antonio Ennis conicet/Universidad de La Plata [email protected] Abstract This article attempts to provide a general approach to the exceptional language contact situation that took place in Argentina from the end of the 19th century until the first decades of the 20th century, in which an enormous immigration flow drastically modified the sociolinguistic landscape. This was most evident in urban environments—and among them especially the Buenos Aires area—and led the local ruling elites to set up a complex and massive apparatus for the nationalisation of the newcomers, which included a language shift in the first stage. Given that the majority of immigrants came from Italy, the most widespread form of contact was that between the local varieties of Spanish and the Italian dialects spoken by the immigrants, which led to the creation of a contact variety called Cocoliche that arose, lived then perished. Although this contact variety did not survive the early years, at least not as a full- fledged variety, the history of its emergence and the ways in which it can be studied today nevertheless make it an object of special interest for research perspectives ori- ented around the question of the early years of language contact. -

El Lunfardo En Las Versiones Polacas De Rayuela Y Torito De Julio Cortázar
Romanica Cracoviensia 4 (2020): 175–187 doi 10.4467/20843917RC.20.017.13303 www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia Joanna Nowak-Michalska http:/orcid.org/0000-0001-8791-2587 Universidad Adam Mickiewicz de Poznań Instituto de Lingüística Aplicada [email protected] LA TRADUCCIÓN DEL ARGOT: EL LUNFARDO EN LAS VERSIONES POLACAS DE RAYUELA Y TORITO DE JULIO CORTÁZAR Translating slang: Lunfardo in the Polish translation of Julio Cortázar’s Rayuela and Torito ABSTRACT The objective of this article is to study how selected Lunfardo words and expressions in the prose of Julio Cortázar have been translated into Polish by Zofia Chądzyńska. Lunfardo is an urban slang typi- cal of the Río de la Plata region in Argentina. The works of Cortázar analysed for the purpose of this paper are: Rayuela (Hopscotch) and Torito, a short story which contains a comparatively large number of Lunfardisms. The paper examines how Lunfardo, a sociolinguistic phenomenon closely linked to Argentina and its culture, is reflected in the translation into Polish. It also identifies the strategies and techniques chosen by the translator and examines to what extent Chądzyńska allows the Polish reader to become aware of the existence of Lunfardo. KEYWORDS: Lunfardo, slang, literary translation, Julio Cortázar, Zofia Chądzyńska. 1. INTRODUCCIÓN En algunas obras de Julio Cortázar, como en la novela Rayuela o el cuento Torito cuyas traducciones analizaremos a continuación, aparecen numerosos lunfardismos, es decir las palabras y expresiones pertenecientes al lunfardo – un argot argentino, utilizado sobre todo en Buenos Aires y sus alrededores. Para explicar qué es el lunfardo retomamos la definición formulada por Óscar Conde, autor de numerosas publicaciones dedicadas a este tema. -

Download Download
Downloaded from the Humanities Digital Library http://www.humanities-digital-library.org Open Access books made available by the School of Advanced Study, University of London ***** Publication details: Revisiting the Falklands-Malvinas Question: Transnational and Interdisciplinary Perspectives Edited by Guillermo Mira Delli-Zotti and Fernando Pedrosa https://humanities-digital-library.org/index.php/hdl/catalog/book/ falklands-malvinas DOI: 10.14296/1220.9781908857804 ***** This edition published in 2021 by UNIVERSITY OF LONDON SCHOOL OF ADVANCED STUDY INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU, United Kingdom ISBN 978-1-908857-80-4 (PDF edition) This work is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. More information regarding CC licenses is available at https://creativecommons.org/licenses Revisiting the Falklands-Malvinas Question Transnational and Interdisciplinary Perspectives edited by Guillermo Mira and Fernando Pedrosa INSTITUTE OF LATIN AMERICAN STUDIES Revisiting the Falklands– Malvinas Question Transnational and Interdisciplinary Perspectives edited by Guillermo Mira and Fernando Pedrosa University of London Press Institute of Latin American Studies, School of Advanced Study, University of London, 2021 British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library This book is published under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. More information regarding CC licenses is available at https:// creativecommons.org/licenses/. This book is also available online at http://humanities-digital-library.org. ISBN: 978-1-908857-56-9 (paperback edition) 978-1-908857-85-9 (.epub edition) 978-1-908857-86-6 (.mobi edition) 978-1-908857-80-4 (PDF edition) DOI: 10.14296/1220.9781908857804 (PDF edition) Institute of Latin American Studies School of Advanced Study University of London Senate House London WC1E 7HU Cover illustration by Marcelo Spotti. -

Our America and Theirs Kennedy and the Alliance for Progress — the Debate at Punta Del Este
Copyright 2005 Aleida March, Che Guevara Studies Center and Ocean Press. Reprinted with their permission. Not to be reproduced in any form without the written permission of Ocean Press. For further information contact Ocean Press at [email protected] and via its website at www.oceanbooks.com.au Our America and Theirs Kennedy and the Alliance for Progress — The Debate at Punta del Este Contents Preface 1 Introduction 9 ECONOMICS CANNOT BE SEPARATED FROM POLITICS Speech at Punta del Este (August 8, 1961) 19 THE REAL ROAD TO DEVELOPMENT Second Speech at Punta del Este (August 16, 1961) 69 THE BATTLE IS NOT YET DECIDED Press Conference in Cuba on the Punta del Este Conference (August 23, 1961) 81 Copyright 2005 Aleida March, Che Guevara Studies Center and Ocean Press. Reprinted with their permission. Not to be reproduced in any form without the written permission of Ocean Press. For further information contact Ocean Press at [email protected] and via its website at www.oceanbooks.com.au Copyright 2005 Aleida March, Che Guevara Studies Center and Ocean Press. Reprinted with their permission. Not to be reproduced in any form without the written permission of Ocean Press. For further information contact Ocean Press at [email protected] and via its website at www.oceanbooks.com.au ECONOMICS CANNOT BE SEPARATED FROM POLITICS Speech at Punta del Este (August 8, 1961) Che Guevara’s speech on behalf of the Cuban government to the ministerial meeting of the Inter-American Economic and Social Council (CIES), sponsored by the Organization of American States (OAS) at Punta del Este, Uruguay, on August 8, 1961. -

Collana Diretta Da Patrizia Botta Sezione II, “Ricerca” 11 Collana “Terra Iberica”
“Terra Iberica” Collana diretta da Patrizia Botta Sezione II, “Ricerca” 11 Collana “Terra Iberica” diretta da Patrizia BOTTA Comitato di redazione Debora VACCARI (Capo–Redattore) e Cristina ARAGÓN Aviva GARRIBBA Massimo MARINI Natalia RODRÍGUEZ Sezione II, “Ricerca”, n. 11 Direzione e Redazione Cattedra di Lingua e Letteratura Spagnola Dipartimento di Lettere e Culture Moderne Facoltà di Lettere e Filosofia Sapienza – Università di Roma Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma [email protected] [email protected] La Collana “Terra Iberica” è volta ad accogliere lavori di iberistica di livello universitario e ha per logo una mappa antica della Penisola tracciata da To lo meo. A promuoverla è la Cattedra di Spagnolo della Facoltà di Lettere e Filo sofia dell’Università di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di Lettere e Culture Moderne). La Collana si articola in tre Sezioni: Sezione I, “Didattica”, maneggevole e in piccolo formato, per il ma te riale finalizzato alle attività di insegnamento iberistico sia di Laurea Triennale che di Laurea Specialistica (testi in lingua, dispense, bre vi saggi, grammatiche, esercizi, ecc.). - Sezione II, “Ricerca”, per i risultati di singole ricerche (monografie e miscellanee di un solo autore) o di ricerche collettive (atti di convegni e libri a firma plurima). Sezione III, “Il Traghetto”, per le traduzioni di importanti opere lette rarie iberiche non ancora diffuse in Italia e che necessitano di es se re ‘traghettate’ dalla lingua originale, elaborate sia dal “Master di II livello in Traduzione specializzata” (che la Cattedra coordina) sia da traduttori esperti in campo iberistico. Le proposte di pubblicazione vanno rivolte alla Direzione o alla Redazione della Collana. -

Decreto Del Direttore Amministrativo N
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) in Scienze del linguaggio Tesi di Laurea Cocoliche Necesidad, esfuerzo, identidad y, quizá, un idioma Relatore Ch. Prof. Eugenio Burgio Correlatore Ch.ma Prof.ssa María Eugenia Sainz González Laureando Andrea Aimasso Matricola 964634 Anno Accademico 2015 / 2016 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 7 CAPÍTULO I La inmigración en Argentina a finales del siglo XIX 9 1.1 Sueños de los inmigrantes 11 1.2 Perspectivas del gobierno argentino 12 1.2.1 Intervenciones sobre la alfabetización 15 1.2.2 La prensa italiana en Argentina 16 1.3 Elementos históricos 19 1.3.1 Marcada presencia femenina 21 1.3.2 Urbanización de los inmigrantes 23 1.4 Los conventillos 24 CAPÍTULO II Plurilingüismo de los inmigrantes 27 2.1 Diglosia y bilingüismo 29 2.2 Italiano y español en contacto en el Rio de la Plata 31 2.2.1 El español de Argentina 34 2.2.2 El dialecto rioplatense 37 CAPÍTULO III Literatura argentina de finales del siglo XIX 39 3.1 Folletín 41 2 3.2 Sainete 44 3.3 Grotesco criollo 46 CAPÍTULO IV El cocoliche 49 4.1 Lo que no es cocoliche 52 4.2 Principales aspectos lexicales 53 4.2.1 Interferencias dialectales 55 4.3 El plano morfosintáctico 60 4.3.1 Uso de las preposiciones 61 4.3.2 Desinencias verbales 62 4.3.3 Formación del plural 63 4.3.4 Posición de los adverbios 64 4.3.5 Uso de los verbos auxiliares 65 4.3.6 Perífrasis verbales 67 4.3.7 El “respeto” del acento tónico 69 4.3.8 Recuperación de expresiones idiomáticas 70 4.4 Aspectos sociolingüísticos 71 4.4.1 El sarcasmo 72 4.4.2 Capacidades de adaptación de los inmigrantes 73 4.5 Principales características fonéticas 74 3 4.6 Un "hermanastro": el lunfardo 75 4.6.1 Relación cocoliche/lunfardo 76 4.6.2 Música 77 CONCLUSIONES 81 APÉNDICE: Entrevista a un descendiente de inmigrantes de habla cocoliche 83 BIBLIOGRAFÍA 88 SITIOGRAFÍA 93 4 “Cogli occhi spenti, con lo guancie cave, Pallidi, in atto addolorato e grave, Sorreggendo le donne affrante e smorte, Ascendono la nave Come s’ascende il palco de la morte. -

In Search of the Chains That Hold Brazil Back Ricardo Hausmann
Faculty Research Working Papers Series In Search of the Chains that Hold Brazil Back Ricardo Hausmann John F. Kennedy School of Government - Harvard University October 2008 RWP08-061 The views expressed in the HKS Faculty Research Working Paper Series are those of the author(s) and do not necessarily reflect those of the John F. Kennedy School of Government or of Harvard University. Faculty Research Working Papers have not undergone formal review and approval. Such papers are included in this series to elicit feedback and to encourage debate on important public policy challenges. Copyright belongs to the author(s). Papers may be downloaded for personal use only. In search of the chains that hold Brazil back Ricardo Hausmann CID Working Paper No. 180 September 2008 © Copyright 2008 Ricardo Hausmann and the President and Fellows of Harvard College Working Papers Center for International Development at Harvard University In search of the chains that hold Brazil back Ricardo Hausmann September 2008 Abstract: This paper performs a Growth Diagnostic for Brazil. It shows that many aspects of the Brazilian economy have been improving including the macro picture, educational progress and the external front. Moreover, Brazil has many productive possibilities and high-return investments. Yet growth is hampered because of a relatively old-fashioned problem that has been solved in many other countries in the region: creating a financially viable state that does not over-borrow, over-tax or under-invest. We show that domestic saving is the binding constraint on growth and that it has a fiscal cause. Although things are trending in the right direction, the challenge is to exploit the current good times to create the fiscal basis for a sustained growth acceleration. -

The Role of Football in Spain
THE PHENOMENON OF FÚTBOL IN SPAIN: A STUDY OF FÚTBOL IN SPANISH POLITICS, LITERATURE AND FILM Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Timothy Joseph Ashton, M.A. Graduate Program in Spanish & Portuguese The Ohio State University 2009 Dissertation Committee: Samuel Amell, Advisor Ignacio Corona Dionisio Viscarri Copyright by Timothy J. Ashton 2009 Abstract This investigation serves to demonstrate the multifaceted connection that the sport of fútbol has with certain aspects of Spanish society, namely, this cultural phenomenon’s long relationship with Spanish politics, literature and film. Since the formation of Spain’s very first club teams, the sport of fútbol has always demonstrated a strong connection with Spain’s historical socio-political disputes. These disputes have become essential elements in making up the very fabric of Spain and range from questions of nationhood, to questions of identity, culture, politics, ideologies and economy. Throughout this study, I address the dispute that has been taking place between the intellectual classes and the fútboling community and defend that although the relationship between intellectuals and fútbol has not been as public as fútbol’s relationship to politics, it has however existed throughout the entire history of the sport. Many intellectuals have deemed the sport of fútbol as an unsuitable topic for intellectual areas such as literature and artistic mediums like film. In this study, I uncover that some of Spain’s most highly praised literary figures had a passion for the sport which they alluded to, sometimes on numerous occasions, as central themes in their work. -

L'argentina Degli Italiani: Viaggio Tra Cocoliche E Lunfardo
Corso di Laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE STRANIERE L’Argentina degli italiani: viaggio tra cocoliche e lunfardo Relatrice: Prof.ssa Giulia Giorgi Correlatore: Prof. Matteo Mancinelli Laureanda: Desiree Fedele ___________________________________ Anno Accademico 2019-2020 INDICE Introduzione p. 3 Cap. 1 Gli italiani in Argentina p. 5 1.1 Storia delle migrazioni italiane in Argentina p. 5 1.2 Partire…perché? p. 9 1.3 La traversata p. 11 1.4 Gli italiani in terra argentina p. 13 1.4.1 El Hotel de los Inmigrantes p. 13 1.4.2 La Boca p. 14 Cap. 2 Storie e “leggende” sulla nascita del cocoliche p. 16 2.1 Il cocoliche linguistico, verso una definizione p. 20 2.2 Il cocoliche letterario p. 25 2.3 Caratteristiche fonetiche e morfo-sintattiche del cocoliche p. 32 2.4 Il lessico p. 40 Cap. 3 La parlata dei porteños: il lunfardo p. 42 3.1 Il lunfardo nella letteratura p. 47 3.2 L’Accademia Porteña del Lunfardo p. 50 3.3 Caratteristiche fonetiche e morfo-sintattiche del lunfardo p. 51 3.3.1 Il vesre p. 54 3.4 Il lessico p. 55 1 Cap. 4 Cocoliche e lunfardo nella letteratura p. 60 4.1 Il cocoliche in ambito letterario p. 60 4.2 Il lunfardo in ambito letterario p. 71 Conclusioni p. 80 Bibliografia e sitografia p. 82 Appendice p. 86 2 Introduzione L’elaborato si propone di studiare il tema dell’emigrazione italiana in Argentina soprattutto dal punto di vista linguistico, trattando i fenomeni del cocoliche e del lunfardo. Il motivo che mi ha spinto a considerare questo argomento è stato il Programma Atlante, proposto dall’Università di Ferrara, che mi ha permesso di soggiornare in Argentina nella città di Santa Fe.