DA PARABITA a MATINO, TIRITỪPPITI a CASARANO (2 Giugno 2014)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
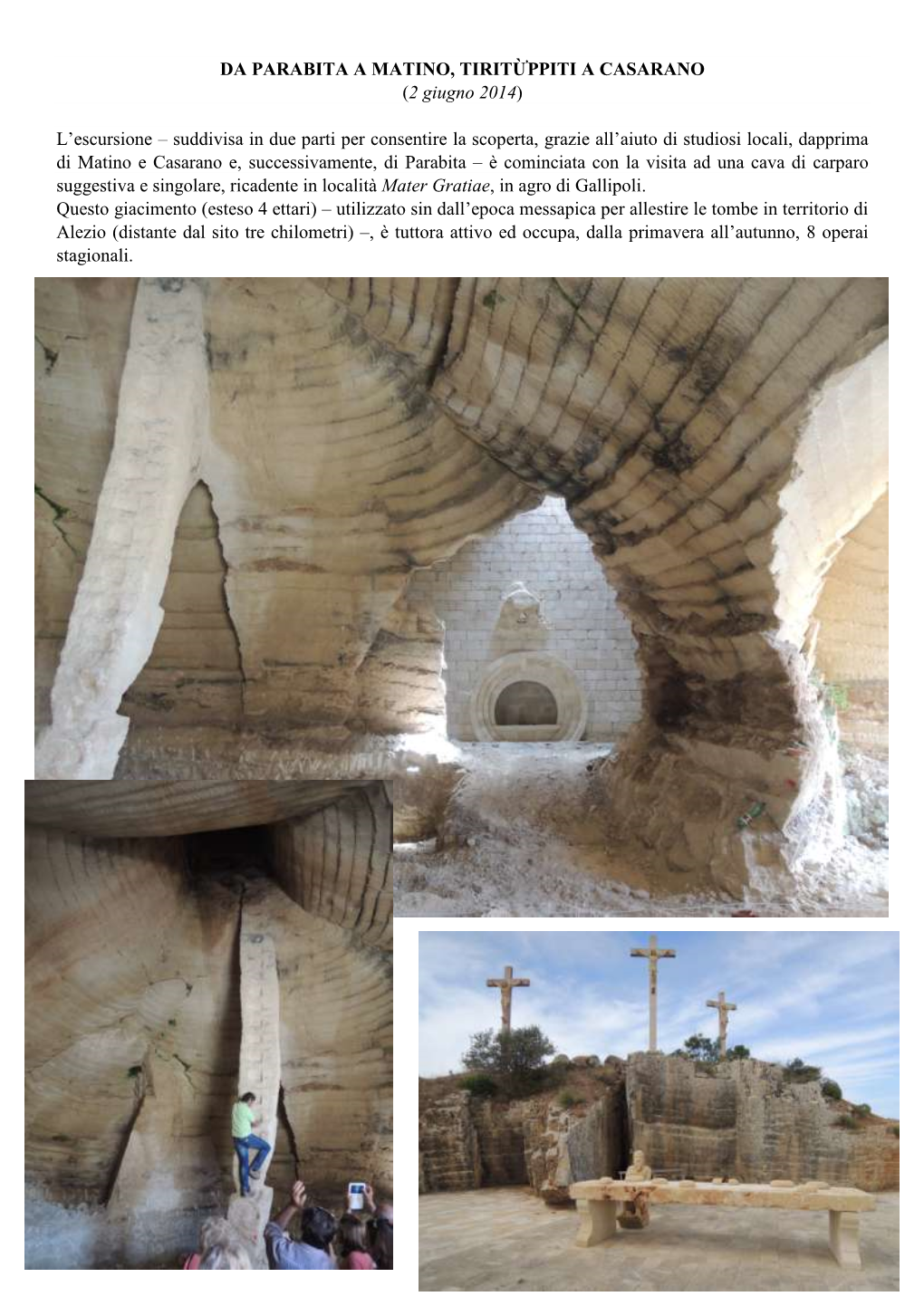
Load more
Recommended publications
-

Distretto Militare Di Lecce, Ruoli Matricolari
Autore GiangrecoC DISTRETTO MILITARE - RUOLI MATRICOLARI del 1917 LECCE Cognome Nome Paternità Maternità Luogo di nascita data Matricole Vol. Abate Antonio Adolfo Rizzo Domenica Maglie 13 novembre 47136 3 Abate Giuseppe // // Vernole 2 marzo 1913 49109 + 9 32 514 classe 1913 Abate Ippazio Francesco Pedaci Pasqualina Gallipoli 12 febbraio 48867 8 Abaterusso Arcangelo Giovanni Brigante Rosa Patù 14 maggio 48866 8 Abissinese Cosimo Cosimo Bocco Addolorata Ugento 16 agosto 48055 6 Acampora Dante Vincenzo Buccoliero Anna Lecce 25 dicembre 46377 + 1 + 48779 8 Accogli Andrea // // Andrano 25 ottobre 49105 9 Accogli Carmine Angelo Bisanti Cesaria Andrano 21 dicembre 48831 8 Accogli Rocco Salvatore Cazzato Maria Andrano 16 agosto 47216 3 Accogli Vito Cirino Fachechi Addolorata Andrano 23 settembre 48186 6 Accoto Celso Giuseppe Pantaleo Maria Andrano 3 maggio 47217 3 Afrune Paolo Giorgio Cesario Brunetta Giuseppa Serrano 3 aprile 47284 3 Agostinello Salvatore Salvatore Coppola Donata Specchia 24 agosto 47201 3 Agrini Fioravante Vito De Luce Maria Novoli 27 maggio 46810 2 Agrosi Aniello Roberto Rizzo Maria Diso 13 marzo 47125 3 Agrosì Aniello Vittorio Filippo Rini Virginia Diso 13 dicembre 47226 3 Aiello Antonio Vincenzo Stefanelli Emilia Gallipoli 6 gennaio 48939 8 Aiello Mario Salvatore Sansebastiano Maria Gallipoli 19 febbraio 47881 5 Albanese Enrico Gervasio Genova Elvira Lecce 30 novembre 46615 2 Albanese Luigi Oronzo Lezzi Giulia Lecce 10 marzo 48424 7 Albano Antonio Cosimo Stefanizzi Natalizia Veglie 16 marzo 46832 2 Albano Carlo Francesco -

Preselezioni Elenco Degli Ammessi 2013 No
COMUNE DI POGGIARDO Provincia di Lecce COMANDO POLIZIA LOCALE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - A TEMPO INDETRMINATO E PARZIALE A 12 ORE SETTIMANALI ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PRESELEZIONE - GRUPPO A. PROVA: MERCOLEDI' 23.10.2013 ORE 9:00 TEATRO ILLIRIA (VIA ARMANDO DIAZ N. 220) - POGGIARDO N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA PR DATA DI NASCITA CITTA' DI RESIDENZA 1 ACCOGLI TIZIANA GAGLIANO DEL CAPO LE 06/03/1983 ANDRANO 2 ACQUAVIVA ANDREA PUTIGNANO BA 30/11/1972 MONOPOLI 3 AFRUNE ROBERTO POGGIARDO LE 22/08/1988 POGGIARDO 4 AGROSI' SANDRA SCORRANO LE 26/02/1984 MAGLIE 5 AGRUSTI ANTONELLA MOTTOLA TA 29/07/1981 LEQUILE 6 ALBENZIO MARIANGELA VENOSA PZ 05/01/1980 PAL. SAN GERVASIO 7 ALFIERI L. STEFANO BARI BA 07/10/1978 BARI 8 AMATI ELIGIO PUTIGNANO BA 28/07/1984 MARTINA FRANCA 9 AMATO DANIELA SCORRANO LE 26/08/1979 SCORRANO 10 APOLLONIO MARCO GALATINA LE 13/09/1978 ARADEO 11 AQUILINO MODESTO PUTIGNANO BA 03/12/1987 ALBEROBELLO 12 ARETANO MICHELE TRICASE LE 22/09/1987 TRICASE 13 ARGENTIERI FRANCESCA GALATINA LE 07/06/1982 GALATINA 14 ARRIGHI PAOLO EMILIO POGGIARDO LE 27/04/1976 SAN CESARIO DI ECCE 15 ASTORE GIUSEPPE POGGIARDO LE 09/10/1986 POGGIARDO 16 ASTORE VALENTINA POGGIARDO LE 19/11/1987 POGGIARDO N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA PR DATA DI NASCITA CITTA' DI RESIDENZA 17 BANDELLO ANGELO GALATINA LE 27/11/1984 CUTROFIANO 18 BANDELLO ANTONIO GALATINA LE 27/05/1983 CUTROFIANO 19 BATTIPAGLIA MARIA LECCE LE 11/06/1978 LECCE 20 BELLO DANIELA POGGIARDO LE 28/09/1980 OTRANTO 21 BELLO LUIGI MOLA DI BARI BA 07/05/1988 MASSAFRA 22 BERTI ADELE CAVA DE' TIRRENI SA 28/06/1980 CAVA DE TIRRENI 23 BEVILACQUA SERENA POGGIARDO LE 24/06/1992 POGGIARDO 24 BIANCO ALESSIO CANTU' CO 15/12/1989 CURSI 25 BIANCO PIERLUIGI LECCE LE 08/04/1976 LECCE 26 BIONDOLILLO DANIELA TARANTO TA 26/01/1980 TARANTO 27 BLEVE MARIA ELISABETTA POGGIARDO LE 11/09/1985 SANTA CESAREA T. -

Candidati Per L'elezione Diretta Del Presidente Della Giunta Regionale
COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0032901 - Ingresso - 11/09/2020 - 17:03 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI LECCE CANDIDATI PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE PER L’ELEZIONE DI N. 5 CONSIGLIERI REGIONALI (Artt. 2, 3, 4 e 8 della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni) CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE 1. BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO 2. EMILIANO MICHELE 3. LARICCHIA ANTONELLA 4. FITTO RAFFAELE 5. CESARIA NICOLA 6. D’AGOSTO ANDREA 7. CONCA MARIO 8. SCALFAROTTO IVAN detto PIERFRANCO Bari 23-07-1959 Bari 01-05-1986 Maglie 28-08-1969 Milano 02-07-1959 Salerno 03-09-1964 Esslingen (Germania) 03-05-1971 Pescara 16-08-1965 San Lorenzo del Vallo 18-01-1955 LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE LISTA CIRCOSCRIZIONALE -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento
Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. The occurrence of calamitous meteoric events rep- ing and emergency states to the population and economic ac- resents a current problem of the Salento peninsula (Southern tivity. Italy). In fact, flash floods, generated by very intense rainfall, occur not only in autumn and winter, but at the end of sum- 1.2 Geological and geomorphological settings mer as well. These calamities are amplified by peculiar geo- logical and geomorphological characteristics of Salento and The Salento peninsula, the southeast portion of the Apulia by the pollution of sinkholes. Floodings affect often large region (southern Italy), covers 7000 km2 of area and stretches areas, especially in the impermeable lowering zones. These over 150 km between the Ionian and Adriatic seas (Fig. 1). events cause warnings and emergency states, involving peo- The peninsula includes two extreme geographical points: the ple as well as socio-economic goods. -

Citta' Di Parabita
CITTA’ DI PARABITA C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE COPIA DETERMINAZIONE SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ALLA CITTA', ASSETTO DEL TERRITORIO REG. GEN.LE N. 477______ DEL 07/06/2016 REG. SERVIZIO N. 90_ DEL 27/05/2016 OGGETTO: Associazione tra i Comuni di:Sannicola, Alezio,Gallipoli, Racale, Parabita, Melissano, Taviano, Alliste, Matino, Aradeo, Seclì,Tuglie. Documento Programmatico Preliminare per la rigenerazione urbana del sistema territoriale Città Policentrica(L.R. 21/2008). Liquidazione somme al Comune di Sannicola (Comune Capofila). Per copia conforme. IL RESPONSABILE SETTORE Data 27/05/2016 DOTT. GEOM. SEBASTIANO NICOLETTI SETTORE FINANZIARIO Si attesta la regolarità contabile e la copertura della spesa Assunto impegno di spesa N° 626 / 2016 - SUB 1 prevista sul presente atto Effettuata prenotazione impegno N°_______ Emesso mandato N°______ in data _______ Data Data 07/06/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to F.to DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, dalla data odierna e per i giorni 15 consecutivi Parabita, 07/06/2016 IL MESSO F.to Raffaele Dimo OGGETTO: Associazione tra i Comuni di:Sannicola, Alezio,Gallipoli, Racale, Parabita, Melissano, Taviano, Alliste, Matino, Aradeo, Seclì,Tuglie. Documento Programmatico Preliminare per la rigenerazione urbana del sistema territoriale Città Policentrica(L.R. 21/2008). Liquidazione somme al Comune di Sannicola (Comune Capofila). IL RESPONSABILE DEL SETTORE Visti gli artt. 107, c. 2,3 e 109 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore; Visto il Decreto Sindacale n. -

Sanarica Lecce
COMUNE DI SANARICA PROVINCIA DI LECCE SERVIZIO TECNICO DETERMINA NR 100 D EL 03 SETTEMBRE 2014 P.O. FESE 2007/2013 – Asse II – Linea d’Intervento 2.3 – Azione 2.3.2 “Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile” - € 70.000,00 1. Affidamento della “Fornitura di attrezzature di emergenza per attività di Protezione Civile” – CIG: ZA2101A69E ; 2. Affidamento della “Fornitura di dispositivi di protezione individuale, abbigliamento e dispositivi per il pronto intervento per attività di protezione civile” – CIG: Z1E101A656 ; OGGETTO 3. Affidamento della “Fornitura di un sistema radio digitale di telecomunicazione per la gestione degli interventi e la localizzazione delle risorse in movimento sul territorio comunale” – CIG: ZF4101A62B ; 4. Affidamento della “Fornitura di n.1 motocarro “QUARGO” con pianale ribaltabile rinforzato per attività di protezione civile” – CIG: ZF8101D940 ; Determinazione a Contrarre ai sensi dell’art. 11 – comma 2 - del D. Lgs. 163/2006 ed Approvazione Lettera Invito e relativi Allegati. CUP: D49G13000030002 RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Ing. Angelo CHIRILLI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Angelo CHIRILLI I L R E S P O N S A B I L E D I S E R V I Z I O VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; VISTO l’art. 3 del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29; VISTO l’art 183 del D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; DATO ATTO CHE questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale; CONSIDERATO CHE l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, dispone che per questo Ente le funzioni di cui all’art. -
Guida Turistica Salento
GUIDA TURISTICA SALENTO I POSTI PIÚ BELLI DA VISITARE DEL SALENTO Musei - Chiese - Monumenti - Castelli - Grotte Centri Storici - Spiagge - Scogliere - Parchi e Riserve naturali THE MOST BEAUTIFUL PLACES TO VISIT IN SALENTO Museums - Churches - Monuments - Castles - Caves Historical Centres - Beaches - Cliffs - Parks and natural reserves Via Cristoforo Colombo - Leuca Marina di Leuca Lecce [email protected] +39 388 65 34 361 Indicazioni Stradali / Directions Chiamaci / Call Us Sito Web / Web Site San Cataldo Riserva Naturale Le Cesine Castello di Acaya Grotta della Poesia Le Sorelle Sant’Andrea Museo di Isola dei Biologia Marina Conigli Laghi Alimini Otranto Cava di Bauxite Porto Selvaggio Torre dell’Alto La Cutura Punta Giardino Botanico Palascia Torre Sant’Emiliano Sorgente di Porto Badisco Gallipoli Le Stanzie Agriturismo Grotta Zinzulusa Castro Castello di Andrano Grotta Verde Piscina Naturale i Contadini Torre San Giovanni Castello di Ugento Grotte Cipolliane CAMPEGGIO RIVA DI UGENTO Torre Mozza Ciolo Lido Marini Torre Pali Pescoluse Torre Vado Grotte Santa Maria di Leuca MAPPA SALENTO / SALENT MAP INDICE INDEX Numeri utili 4 Useful numbers 4 Il Salento 5 The Salento 5 Lecce 6 Lecce 6 Lecce Anfiteatro Romano 7 Lecce Amphitheater 7 Lecce Cattedrale 8 Lecce Catthedral 8 Lecce Basilica Santa Croce 9 Lecce Basilica of Santa Croce 9 Castello Carlo V 10 Carlo V Castle 10 Punta Prosciutto 11 Punta Prosciutto 11 Torre Lapillo 12 Torre Lapillo 12 Porto Cesareo 13 Porto Cesareo 13 Porto Selvaggio 14 Porto Selvaggio 14 Nardò 15 Nardò 15 Copertino -

A. Maurizio Bortone Ingegnere
A. Maurizio Bortone Ingegnere VIA DON STURZO 8 - 73040 ACQUARICA DEL CAPO (LECCE) ITALIA – TELEFONO E FAX 0833 727399 – WWW.STUDIOBORTONE.EU - [email protected] CODICE FISCALE BRT NNM 71D10 AO42J – PARTITA I.V.A. 0 325 061 0 759 - P.E.C. [email protected] F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome BORTONE ANTONIO MAURIZIO Indirizzo studio VIA DON STURZO, 8, 73040, ACQUARICA DEL CAPO (LE) Telefono 0833 72 73 99 Fax 0833-72 73 99 E-mail e-mail [email protected] e-mail [email protected] pec. [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 10-04-1971 ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date • Nome e tipo di istituto di istruzione LAUREATO PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO IL 21 OTTOBRE 1997 o formazione • Principali materie / abilità LAUREA IN INGEGNERIA EDILE professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione LIBERO PROFESSIONISTA, ISCRITTO PRESSO L' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA nazionale (se pertinente) PROVINCIA DI LECCE IN DATA 23 APRILE 1998, CON IL NUMERO 1872 ________________________________________________________________________________ STUDIO ARCHITETTO E INGEGNERE BORTONE, PROGETTAZIONE COORDINATA – ACQUARICA DEL CAPO (LECCE) – [email protected] pagina 1/40 Comune di Matino Prot. n. 0001135 del 18-01-2019 arrivo Cat. 6 Cl. 1 A) TITOLI - ATTESTATI – ABILITAZIONI 1- Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza (art. 10 comma 2 D.Lgs 14/08/1996 n°494) “CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE“ (di 150 ore dal 28 maggio all’11 ottobre 1999) rilasciato il 25 ottobre 1999 dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE; 2- Attestato di partecipazione al III° corso di specializzazione in prevenzione incendi (D.M. -

Lecce, September 3, 2015 BITUME PHOTOFEST Serre Salentine August 21
Lecce, September 3, 2015 BITUME PHOTOFEST Serre Salentine August 21 - 30, Serre Salentine | September 19 - 27, Gallipoli Bitume Photofest 2015 inaugurated its first artist residency at the end of August in collaboration with Gal Serre Salentine. During the last week of summer, photographic exhibitions and educational activities will take place among the seafront ramparts and laneways of Gallipoli; one of the most evocative historical centres of the Mediterranean. Gianpaolo Arena, Lucas Foglia, Robert Herman, Eugenia Maximova, Thomas Sauvin and Gregg Segal are just some of the international artists taking part in this year’s Bitume Photofest, the first urban festival of international photography in South Italy, created and organised by Postivo Diretto, a Lecce based Cultural Association. Now in its second year and co-produced by Gal Serre Salentine, the festival will take place in the last week of summer (September 19-27) and offers a fascinating opportunity to discover the area and inaugurate new cultural experiences. Following on from the first edition which took place in Lecce in 2014, Bitume chose the city of Gallipoli to host this year’s calendar of events which is brimming with experimentation and international artists. Photographic installations and festival events have been specifically created with the beachfront location in mind. Bitume Photofest Serre Salentine August 21 – 30 | Artist Residency The festival program has already been brought to life by the Bitume Photofest Serre Salentine which took place from August 21 to August 30, 2015. Bitume Photofest Serre Salentine was an artist residency organized by Positivo Diretto and Gal Serre Salentine as part of the second edition of the festival and which saw the involvement of fourteen of the area’s municipalities. -

Bando Olimpiadi Amicizia 2019
Alezio Carpignano S. Castrignano dei Greci Copertino Città di Galatone - Prot. n. 0005610 del 04/03/2019 13:20 ARRIVO Galatone Gallipoli Lecce Martano Matino Otranto Ruffano Salice Salentino Soleto Taviano Tricase Tuglie Vernole OLIMPIADI DELL’AMICIZIA 2019 BANDO DI PARTECIPAZIONE 1 Soggetti Promotori Le Olimpiadi dell’Amicizia sono state promosse dai 70 Consigli Comunali dei Ragazzi/e (CCRR) che hanno partecipato al 10° Raduno Provinciale dei CCRR, dall’UNICEF (Comitato Provinciale di Lecce) e dalla Provincia di Lecce. Soggetti Organizzatori Le Olimpiadi 2018 sono organizzate dai Consigli Comunali dei Ragazzi/e (CCRR) e dai Consigli Comunali degli Adulti di Alezio, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Copertino, Galatone, Gallipoli, Lecce, Martano, Matino, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, Soleto, Taviano, Tricase, Tuglie, Vernole, dall’UNICEF – Comitato Provinciale di Lecce- e dalla PROVINCIA DI LECCE. Principi ispiratori delle Olimpiadi Città di Galatone - Prot. n. 0005610 del 04/03/2019 13:20 ARRIVO Le Olimpiadi dell’Amicizia vengono immaginate dai Promotori e dagli Organizzatori come una grande occasione per far incontrare Ragazze e Ragazzi di 70 Comuni del Salento in diciassette diversi paesi della Provincia. E in tali luoghi consentire loro di esercitare sani momenti di partecipazione attiva e creativa senza alcuna forma di competizione fra di essi. L’obiettivo principale che si vuole perseguire è quello di alimentare in ogni partecipante il sentimento dell’Amicizia, dell’accoglienza, dell’inclusione, in tutte le declinazioni -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento Peninsula (Southern Italy) F
Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl To cite this version: F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2005, 5 (6), pp.833-844. hal-00301659 HAL Id: hal-00301659 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301659 Submitted on 2 Nov 2005 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. -

Rubrica Del Ruolo Matricolare - Distretto Militare Di Lecce - Anno 1921
Rubrica del Ruolo Matricolare - Distretto Militare di Lecce - anno 1921 Cognome Nome COMUNE Num. Matricola Abaterusso Giovanni PATU' 14262 Abaterusso Ernesto PATU' 17632 Abaterusso Cosimo PATU' 18666 Abatianni Giuseppe SAN CESARIO 18529 Abbadessa Giovanni LECCE 16183 Abrace Giacomo GAGLIANO 18039 Abruzzese Ugo GALLIPOLI 18667 Accogli Donato ANDRANO 14678 Accogli Gaetano ANDRANO 14679 Accogli Giovanni ANDRANO 14680 Accogli Donato TRICASE 18168 Accogli Luigi CAPRARICA 18668 Accoto Rocco NOCIGLIA v. anche 18604 14939 Accoto Salvatore GIURDIGNANO 15045 Acerno Francesco MAGLIE 14972 Acerno Otello MAGLIE 14973 Afrune Giovanni POGGIARDO 14757 Afruni Rigoletto GIUGGIANELLO 14796 Aggioli Alessandro ARADEO 17256 Agrimi Narduccio TREPUZZI 15997 Agrimi Salvatore TREPUZZI 15998 Agrimi Oronzo LECCE 16184 Albanese Antonio SOGLIANO CAVOUR 15130 Albanese Giovanni SAN CESARIO 16680 Albano Salvatore COPERTINO 15366 Albano Antonio LEVERANO 15453 Albertini Angelo SPECCHIA 14636 Albini Achille SQUINZANO 16088 Alemanni Salvatore CUTROFIANO 17303 Alemanno Guglielmo ALEZIO 14891 Alemanno Vittorio COPERTINO 15362 Alemanno Giuseppe COPERTINO 15363 Alemanno Cosimo COPERTINO 15364 Alemanno Angelo COPERTINO 15365 Alemanno Angelo SANNICOLA 15631 Alemanno Mario SANNICOLA 15632 Alemanno Giovanni VEGLIE 15827 Alemanno Cosimo SALICE SALENTINO 15873 Alemanno Raffaele SALICE SALENTINO 15874 Alemanno Francesco LECCE 16185 Alemanno Andrea Giuseppe Salv. GALATONE 17886 Alemanno Luigi Sebastiano GALLIPOLI 17928 Alessandrelli Santo ALEZIO 15587 Alfarano Salvatore CASARANO 14292