S. Lorenzo 1 CAPITOLO 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
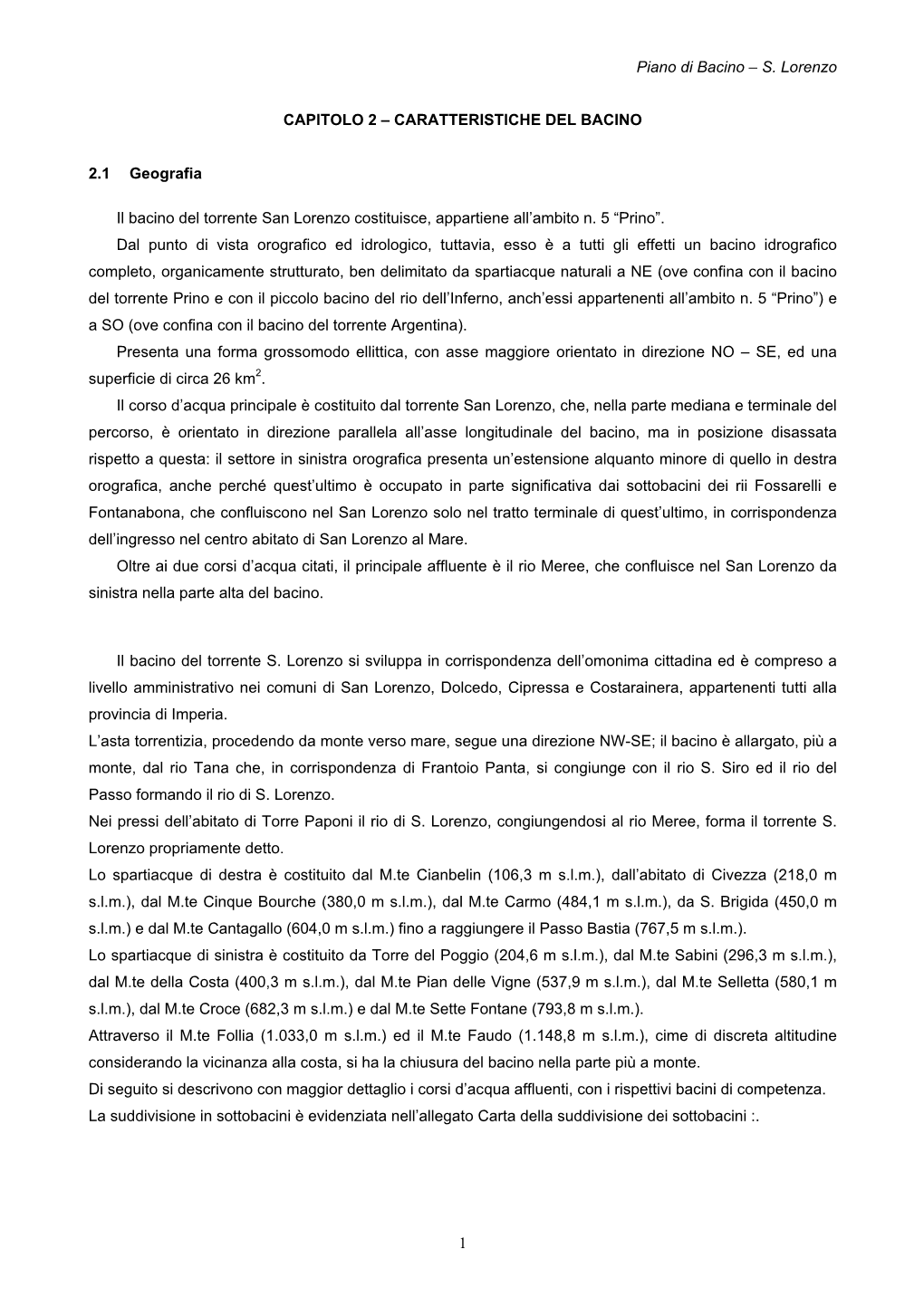
Load more
Recommended publications
-

Storia E Storie Di Emigrazione Dal Ponente Ligure. Alcuni Percorsi Di Ricerca
Storia e storie di emigrazione dal Ponente ligure. Alcuni percorsi di ricerca Augusta Molinari Antichi percorsi Una delle prime iniziative dell'Istituto Nazionale, denominazione sotto la quale si era riorganizzata nel 1798 la Società Genovese di Storia Patria, fu quella di procedere ad un'Inchiesta sulle condizioni economiche e sociali della regione(l). Le risposte fornite dai sindaci e dai parroci al questionario, inviato l'anno seguente dall'Istituto, documentano una forte mobilità delle popolazioni sia della costa che dell'entratemi e la presenza di flussi migratori di antica data diretti verso la Francia, l'Europa Settentrionale e la Spagna. L'insieme della documentazione prodotta in occasione àe\Y Inchiestaci) fornisce informazioni utili per lo studio dei movimenti migratori del Ponente ligure, in particolare per l'area compresa tra Albenga e il confine francese. In molti casi l'emigrazione è presentata come una delle cause del progressivo spopolamento delle comunità contadine. Scrive, ad esempio, il parroco di Tovo San Giacomo: "una moltitudine di cittadini et anche delle famiglie intere a motivo de' gran debiti e miserie sono andati per il mondo(3) ». Alla fine del Settecento, la comunità contadina del Ponente ligure sembra interessata da una forte mobilità sia in ambito locale (dalla montagna al litorale), sia verso altre regioni (Piemonte, Lombardia), sia verso l'estero (riviera francese, Spagna). Accanto ai fattori "espulsivi", che i compilatori del questionario individuano nella generale crisi dell'economia di sussistenza della montagna, un ruolo importante , come volano della mobilità , viene attribuito anche ai fattori cosiddetti "attrattivi" : il commercio e la maggiore vivacità economica dei centri rivieraschi, le attività legate alla pesca e alla navigazione per le mete estere. -

CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: Scheda 05 IMP ______A
CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 05_IMP _______________________________________________________________________ a. IDENTIFICAZIONE DEL TRATTO DI COSTA Lunghezza Denominazione Codice inizio fine (Km) Imperia 0700800805 Foce Rio San Lorenzo Capo Berta 21,4 * Il codice è costruito con i seguenti campi: Codice Istat Regione Liguria Codice Istat Provincia in cui ricade il confine ovest del tratto Codice Istat Provincia in cui ricade il confine est del tratto Numero progressivo all’interno della Regione, da ovest ad est Coordinate (Gauss Boaga – fuso ovest) latitudine longitudine Inizio (ovest) 4855984 1416887 Fine (est) 4860953 1426362 Considerabile come corpo idrico di riferimento : NO Specifica destinazione : Balneazione: SI vita molluschi: NO acquacoltura: NO altro:NO Imperia 1 M05 CARATTERISTICHE ACQUE COSTIERE: scheda 05_IMP _______________________________________________________________________ b. CARATTERISTICHE DEL TRATTO COSTIERO Tipizzazione idrologica - geomorfologica (DM 131/08): rilievi montuosi - bassa stabilità. Descrizione geomorfologica Il tratto costiero, caratterizzato da un’alternanza di tratti rocciosi e di spiagge a prevalenza di ciottoli, ha subito numerosi interventi di opere a mare per cui per gran parte risulta artificiale. Il litorale comprende inoltre i due porti di Porto Maurizio e Oneglia, che racchiudono uno specchio acqueo, rispettivamente, di circa 75.000 mq e 90.000 mq. Il fondale è prevalentemente alto, tranne nel tratto centrale, lungo circa 4 km, antistante Imperia Porto Maurizio-Borgo Prino, che digrada più dolcemente verso il largo. Il fondo è sabbioso /sabbioso-pelitico. Biocenosi marine costiere ed aspetti naturalistici Nei fondali antistanti il tratto in questione sono presenti due siti di interesse comunitario: - “Fondali di Porto Maurizio S.Lorenzo al mare-Torre dei Marmi” (SIC marino IT 1315971), una parte dei quali ricadono nel tratto omogeneo a ponente “Santo Stefano”. -

Badalucco Bajardo Bordighera Borgomaro Camporosso Castellaro
Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 1 Alassio 40,541.92 2 Albenga 24,135.18 3 Albisola Superiore 43,863.12 4 Albissola Marina 16,557.54 5 Altare 5,828.47 6 Ameglia 6,851.26 7 Andora 24,830.85 8 Arcola 7,790.42 9 Arenzano 12,204.19 10 Avegno 4,260.20 11 Badalucco 1,639.64 12 Bajardo 1,108.81 13 Bargagli 9,256.73 14 Bogliasco 9,043.38 15 Boissano 2,689.69 16 Bolano 10,815.32 17 Bonassola 2,353.76 18 Bordighera 10,535.78 19 Borghetto Santo Spirito 19,081.22 20 Borgio Verezzi 5,843.83 21 Borgomaro 1,329.87 22 Bormida 1,333.11 23 Borzonasca 5,402.46 24 Busalla 8,785.86 25 Cairo Montenotte 11,077.47 26 Calice al Cornoviglio 1,697.98 27 Camogli 8,637.26 28 Campo Ligure 6,806.81 29 Campomorone 23,211.64 30 Camporosso 3,253.90 31 Carasco 7,696.77 32 Carcare 14,967.49 33 Casanova Lerrone 2,264.44 34 Casarza Ligure 11,676.99 35 Casella 4,951.43 36 Castellaro 1,297.34 37 Castelnuovo Magra 15,238.75 38 Castiglione Chiavarese 2,537.17 39 Celle Ligure 9,151.19 40 Cengio 6,647.44 41 Ceranesi 5,072.80 42 Ceriale 20,594.14 43 Ceriana 3,878.34 44 Cervo 4,549.89 45 Chiavari 21,748.58 Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 46 Chiusanico 1,725.70 47 Chiusavecchia 916.26 48 Cicagna 5,832.09 49 Cisano sul Neva 4,624.95 50 Cogoleto 15,522.07 51 Cogorno 14,717.94 52 Cosseria 3,180.16 53 Davagna 3,406.12 54 Deiva Marina 3,210.82 55 Diano Castello 3,311.33 56 Diano Marina 6,292.25 57 Dolceacqua 2,137.06 58 Dolcedo 2,577.13 59 Finale Ligure 57,918.04 60 Follo 7,416.98 61 Framura 1,989.84 62 Garlenda 3,449.93 63 Genova 446,099.43 64 Giustenice 2,902.96 65 Imperia -

Il Raddoppio Del Tratto Andora-San Lorenzo Le Nuove Stazioni Di Imperia, Diano E Andora
La linea Genova-Ventimiglia IL RADDOPPIO DEL TRATTO ANDORA-SAN LORENZO LE NUOVE STAZIONI DI IMPERIA, DIANO E ANDORA La linea Genova-Ventimiglia IL RADDOPPIO DEL TRATTO ANDORA-SAN LORENZO LE NUOVE STAZIONI DI IMPERIA, DIANO E ANDORA Andora-San Lorenzo Il nuovo tracciato Attualmente la linea Genova-Ventimiglia, lunga circa 144 km, presenta tratte a doppio binario per 101 km e a semplice binario per 43 km. Genova-Finale Ligure 59 km a doppio binario Finale Ligure-Loano 9 km a semplice binario Loano-Albenga 9 km a doppio binario Albenga-San Lorenzo 34 km a semplice binario San Lorenzo-Ventimiglia 33 km a doppio binario G. Voltri Arenzano G. Pegli G. Pra G. Cornigliano Varazze G. Sestri Albissola G. Sampierdarena G. P. Principe G. Brignole Savona Quiliano - Vado Spotorno Finale Ligure Pietra Ligure Borgo Verezzi Pietra Ligure Borghetto S. Spirito Loano Borghetto S. Spirito Ceriale Albenga Albenga Alassio Alassio Laigueglia Andora Andora Diano Cervo - San Bartolomeo Imperia Diano Marina Imperia On. Imperia P. M. Taggia Arma Ventimiglia San Lorenzo Sanremo Linea a doppio binario Bordighera Linea a semplice binario Raddoppio in progettazione Raddoppio in esecuzione Stazioni La tratta Andora-San Lorenzo si collega, lato ponente, alla tratta contigua a doppio binario San Lorenzo- Ospedaletti, attivata all’esercizio Il completamento ferroviario del raddoppio nel settembre 2001 della tratta e, a levante, alla linea Finale-San Lorenzo, esistente in prossimità che si svilupperà della stazione interamente di Andora a monte verso Genova, dell’attuale tracciato, in corrispondenza verrà realizzato L’attenzione di RFI all’ambiente dell’attuale ponte mediante sul torrente Merula. -

Indagine Su Beni E Strutture Culturali in Provincia Di Imperia
P.T.C della Provincia di Imperia – TEMA : BENI CULTURALI INDAGINE SU BENI E STRUTTURE CULTURALI IN PROVINCIA DI IMPERIA 1. - MAPPATURA EDIFICI VINCOLATI EX 1089 (D. LGS. n° 490 /1999) Sulla base dell’elenco gentilmente fornito, su supporto Excell, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria1 e grazie alla collaborazione della competente struttura della Regione Liguria, si è sviluppato un lavoro di reperimento dell’indirizzario dei Beni e quindi la mappatura informatica degli edifici interessati dal vincolo, operando in parte tramite conoscenza diretta, in parte previa ricerca presso gli uffici Tecnici Comunali. Contestualmente si è proceduto ad una elementare codifica degli edifici (o parti di edifici) suddividendoli in base alle seguenti voci (riferite alla funzione d’origine degli edifici stessi): A - BENI RELIGIOSI: cattedrale, chiesa, santuario, cappella, convento, cimitero, sepolcro. B - BENI CIVILI: palazzo, casa, casa con parco, villa, teatro, mercato, prigione, ponte, fontana, porta, giardino. C - BENI MILITARI: castello, torre, opera fortificata. E - EDIFICI INDUSTRIALI: oleifici, frantoi, mulini, fornaci. F - AFFRESCHI, BASSORILIEVI, ARCHITRAVI, colonne sovrapporte, piccole opere in esterno. G - BENI ARCHEOLOGICI (beni di palese tipologia archeologica). Il risultato del lavoro, comunque molto oneroso ed ancora perfezionabile, è espresso nella Carta di Mappatura Beni Culturali prodotta su base informatica georeferenziata, di contenuto molto elementare, pur tuttavia molto efficace nel consentire una prima identificazione delle Emergenze Monumentali in Provincia di Imperia, che devono essere considerate anche anche ai fini delle previsioni di interventi sul territorio. A partire da questa prima base cartografica è possibile procedere con celerità ad ulteriori verifiche di dettaglio delle localizzazioni, alla integrazione degli attributi assegnati ai Beni mediante acquisizione di informazioni anche di merito in relazione ai pregi architettonici ed artistici, all’accessibilità per la visita, ecc. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2013
Ufficio del territorio di IMPERIA - TERRITORIO Data: 29/04/2015 Ora: 12.37.20 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2013 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1-ALTE VALLI ARROSCIA REGIONE AGRARIA N.2 ALTE VALLI AEGENTINA E NERVIA Comuni di: AQUILA D`ARROSCIA, ARMO, BORGHETTO D`ARROSCIA, Comuni di: AIROLE, APRICALE, BADALUCCO, BAIARDO, CARPASIO, COSIO D`ARROSCIA, MENDATICA, MONTEGROSSO PIAN LATTE, CASTEL VITTORIO, CERIANA, DOLCEACQUA, ISOLABONA, MOLINI PIEVE DI TECO, PORNASSIO, RANZO, REZZO, VESSALICO DI TRIORA, MONTALTO LIGURE, OLIVETTA SAN MICHELE, PERINALDO, PIGNA, ROCCHETTA NERVINA, TRIORA COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 3833,76 3833,76 BOSCO D`ALTO FUSTO 4600,50 4600,50 BOSCO MISTO 4370,48 4370,48 CANNETO 23615,94 CASTAGNETO 2836,98 2683,63 INCOLTO PRODUTTIVO 996,78 920,10 INCOLTO STERILE 651,74 651,74 ORTO IRRIGUO FIORI 164698,14 PASCOLO 1533,50 1533,50 PASCOLO ARBORATO 1533,50 PASCOLO CESPUGLIATO 996,78 996,78 PRATO 5367,26 6042,00 PRATO IRRIGUO 21239,01 18839,08 Pagina: 1 di 6 Ufficio del territorio di IMPERIA - TERRITORIO Data: 29/04/2015 Ora: 12.37.20 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2013 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE AGRARIA N.1-ALTE VALLI ARROSCIA REGIONE AGRARIA N.2 ALTE VALLI AEGENTINA E NERVIA Comuni di: AQUILA D`ARROSCIA, ARMO, BORGHETTO D`ARROSCIA, Comuni di: AIROLE, APRICALE, BADALUCCO, BAIARDO, CARPASIO, COSIO D`ARROSCIA, MENDATICA, MONTEGROSSO PIAN LATTE, CASTEL VITTORIO, CERIANA, DOLCEACQUA, ISOLABONA, MOLINI PIEVE DI TECO, PORNASSIO, RANZO, REZZO, VESSALICO DI TRIORA, MONTALTO LIGURE, OLIVETTA SAN MICHELE, PERINALDO, PIGNA, ROCCHETTA NERVINA, TRIORA COLTURA Valore Sup. -

Allegato 5 : Elenco Scarichi Da Pubbliche Fognature E Produttivi (2002)
Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – ALLEGATO N. 5 ALLEGATO 5 : ELENCO SCARICHI DA PUBBLICHE FOGNATURE E PRODUTTIVI (2002) 843 Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – ALLEGATO N. 5 N° ID classe scarico (tipo di COMUNE Denominazione scarico - Località Corpo ricettore bacino idrografico sulla carta depuratore) AIROLE Fognatura Com.le Airole 6 F. Roja Roja 8 AIROLE Fognatura Com.le Collabassa 7 T. Bevera Roja 7 AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 8 F. Roja Roja AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 9 F. Roja Roja AIROLE Scarico centrale ENEL -Ponte Giauma (Airole) 10 F. Roja Roja APRICALE Fognatura Com.le Apricale 38 Rio Merdanzo Nervia 8 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Aquila d'Arroscia 264 Rio Galli Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Montà 265 Rio Grande Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Mugno 266 Rio Antica Arroscia 7 AQUILA DI ARROSCIA Fognatura Com.le Salino 267 Rio Bernarda Arroscia 7 ARMO Fognatura Com.le Armo 298 Rio della Pissa Arroscia 8 AURIGO Fognatura Com.le Aurigo 230 Rio Banco Impero 8 AURIGO Fognatura Com.le Poggialto 232 Rio Garbi Impero 7 diretto BADALUCCO Fognatura Com.le Badalucco 115 T. Argentina Argentina (in progetto collegamento con dep.Riva Ligure) BADALUCCO Fognatura Com.le Ciabaudo 337 Terreno Argentina 7 BAIARDO Fognatura Com.le Baiardo 32 Terreno Nervia 7 BAIARDO Fognatura Com.le Baiardo 35 Rio Marin Nervia 8 BAIARDO Fognatura Com.le Vignai 34 Nervia diretto Mare a 1000 mt. dalla BORDIGHERA Fognatura Com.le al largo di Bordighera 57 1 costa BORGHETTO D'ARROSCIA Fognatura Com.le Borghetto d'Arroscia 268 T. -

Il Terremoto Del 23 Febbraio 1887 in Liguria Occidentale
Il terremoto del 23 Febbraio 1887 in Liguria Occidentale Descrizioni, considerazioni e prevenzione 120 anni dopo il grande evento Memoria in occasione della mostra “Terremoti: conoscerli per difendersi”, Genova, 19 Marzo – 27 Maggio 2007 Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” Stefano Solarino Stefano Solarino Primo Ricercatore Centro Nazionale Terremoti, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia [email protected]; [email protected] http://www.dipteris.unige.it/geofisica/solarino.html 120 anni sprecati? Ogni libro che si rispetti e che si definisca tale è sempre accompagnato da una introduzione. Una delle caratteristiche che la contraddistingue, è che essa è spesso affidata a persona diversa dall’autore; di solito si tratta di un nome altisonante, così altisonante da non riuscire a capire se è necessaria tanta fama perché l’argomento e le caratteristiche del libro lo richiedano o più semplicemente perché essendo questi ultimi di basso livello occorra conferir loro una maggiore dignità servendosi di persone molto blasonate. Nel caso di questo libro sarebbe stato molto difficile trovare una persona disposta a scrivere una introduzione e ciò per tutta una serie di motivi. Il commento di un collega sarebbe infatti stato considerato di parte e quindi non avrebbe né aggiunto né tolto niente al contenuto del libro; con i giornalisti ho un rapporto di odio-amore come sarà chiaro nelle prossime pagine; calciatori, veline e cantanti sono impegnati con tutt’altra attività e quindi certamente non avrebbero dedicato parte del loro tempo al mio scritto; ed infine i politici considerano l’argomento del terremoto come un argomento molto scomodo, quindi se possibile ne stanno lontani. -

Registro REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale Copertina Tipo Atto
REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale Copertina Registro Tipo Atto Decreto del Dirigente Numero Protocollo NP/2020/1360911 Anno Registro 2020 Numero Registro 2100 Dipartimento Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Struttura Settore Ispettorato agrario regionale Oggetto PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 4.1. BANDO DGR 388/2018. Bando 4.1 - QUARTA FASCIA - SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLA AZIENDE AGRICOLE- DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 388/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE AMMESSE AL SOSTEGNO. Data sottoscrizione 30/03/2020 Responsabile procedimento Maurizio Rezzano Dirigente responsabile Maurizio Rezzano Soggetto emanante Maurizio Rezzano La regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto è garantita dal Dirigente/Direttore Generale della struttura proponente. Il decreto rientra nei provvedimenti dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale 254/2017 Il decreto è costituito dal testo e da 2 allegati allegati: A01_2020-AM-2455_Domande finanziate 4_1.pdf A02_2020-AM-2455_Domande non finanziate 4_1.pdf Comunicazioni Non pubblicazione (sottratto integralmente all’accesso ai sensi della l. 241/1990 e NO ss.mm.ii). Soggetto a Privacy: NO Pubblicabile sul BURL: SI Modalità di pubblicazione sul BURL: per estratto Pubblicabile sul Web: SI REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Struttura Settore Ispettorato agrario regionale Decreto del Dirigente codice AM-2455 anno 2020 OGGETTO: PSR 2014-2020. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

SANREMO. 100% RIVIERA the Most Exclusive Sites of the Italian and French Riviera in One Port of Call
SANREMO. 100% RIVIERA The most exclusive sites of the Italian and French Riviera in one port of call Presenta(on by Hugo Trumpy & Trumpy Tours Contents • Sanremo – The Port – Locaon and Connecons page 3 – Port Facili=es and Services 4 – Berthing Facili=es 5 – Technical Informaon 6 • Sanremo – The City SANREMO – History 7 Genoa – Climate 9 • What to See in Sanremo – The Old Town 10 – The Capital of La Belle Epoque 11 • What to See in the sorroundings of Sanremo – Bussana Vecchia 14 – Triora 15 Rome – Dolceacqua and Apricale 16 – The Best Beaches: from Diano to Balzi Rossi 17 – Many opons for those who love the outdoors 18 – Two Beau=ful Golf Courses 19 • What to See in the French Riviera – Montecarlo 20 – Nice and Eze Village 21 – Cannes and Grasse 22 • Typical Products – Food and Wine 23 • Contacts and References 24 HUGO TRUMPY & TRUMPY TOURS 2 Sanremo – The Port Strategically located on the Italian Riviera • Sanremo is a city with about 57,000 inhabitants on the Mediterranean coast of western Liguria in north-western Italy. Founded in Roman mes, the city is best known as a tourist des=naon on the Italian Riviera. • Sanremo is situated in a privileged locaon, in the centre of an important road: the European highway E80, which includes the A10 Genoa-Ven=miglia and the A8 Menton-Aix-en- Provence, connects the city to France and to the Italian motorway SANREMO network. MONACO • The nearest internaonal airports are Nice, only 50 km from Sanremo, Albenga and Genoa (70 and 150 km) • Sanremo Railway Staon is located along the line that connects -

2020-2021 Orario Invernale Generale 15ªver
RIVIERA TRASPORTI S.p.A. ORARIO GENERALE INVERNALE In vigore dal 14 settembre 2020 al 9 giugno 2021 Aggiornato al 14 maggio 2021 LINEA 17 : SANREMO - ARMA DI TAGGIA - CASTELLARO (solo Feriale) Pagina 35 LINEA 18 : SANREMO - ARMA DI TAGGIA - POMPEIANA (solo Feriale) " " 35 INDICE DELLE LINEE LINEA 19 : SANREMO - RIVA LIGURE - TERZORIO ( solo scolastico ) " " 35 ( NATALE E 1° MAGGIO "nessun servizio" ) LINEA 20 : IMPERIA - SAN LORENZO - CIPRESSA - LINGUEGLIETTA (solo Feriale) " " 36 LINEA 21 : IMPERIA - SAN LORENZO - PIETRABRUNA - BOSCOMARE (solo Feriale) " " 36 LINEA 1 : VENTIMIGLIA - PONTE SAN LUIGI (solo Feriale) Pagina 3 LINEA 22 : IMPERIA - SAN LORENZO - CIVEZZA (solo Feriale) " " 36 LINEA 1/1 : SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA (solo Feriale) " " 4 LINEA 23 : IMPERIA - DOLCEDO - LECCHIORE (solo Feriale) " " 37 LINEA 2 : VENTIMIGLIA - BORDIGHERA - OSPEDALETTI - SANREMO (Feriale) " " 5 LINEA 24 : IMPERIA - DOLCEDO - PRELA' - VILLATALLA (solo Feriale) " " 37 SANREMO - OSPEDALETTI - BORDIGHERA - VENTIMIGLIA (Feriale) " " 6 LINEA 25 : IMPERIA - VASIA - PIANAVIA - PANTASINA (solo Feriale) " " 38 VENTIMIGLIA - BORDIGHERA - OSPEDALETTI - SANREMO (Festivo) " " 7 LINEA 26 : IMPERIA - PONTEDASSIO - BESTAGNO - VILLA VIANI (solo Feriale) " " 38 SANREMO - OSPEDALETTI - BORDIGHERA - VENTIMIGLIA (Festivo) " " 8 LINEA 27 : IMPERIA - PONTEDASSIO - GAZZELLI - TORRIA - CESIO (solo Feriale) " " 38 LINEA 3 : VENTIMIGLIA - TRUCCO - AIROLE - OLIVETTA SAN MICHELE (solo Feriale) " " 9 LINEA 28 : IMPERIA - PONTEDASSIO - LUCINASCO - CARAVONICA (solo