It1110051 – Peschiere E Laghi Di Pralormo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
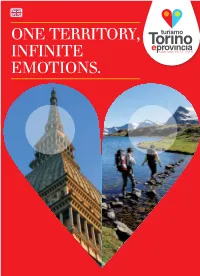
One Territory, Infinite Emotions
www.turismotorino.org ONE TERRITORY, TORINO • Piazza Castello/Via Garibaldi INFINITE • Piazza Carlo Felice • International Airport (interactive totem) Contact centre +39.011.535181 [email protected] EMOTIONS. BARDONECCHIA Piazza De Gasperi 1 +39.0122.99032 [email protected] CESANA TORINESE Piazza Vittorio Amedeo 3 +39.0122.89202 [email protected] CLAVIÈRE Via Nazionale 30 +39.0122.878856 [email protected] IVREA Piazza Ottinetti +39.0125.618131 [email protected] PINEROLO Viale Giolitti 7/9 +39.0121.795589 [email protected] PRAGELATO Piazza Lantelme 2 +39.0122.741728 [email protected] SAuze d’OULX Viale Genevris 7 +39.0122.858009 [email protected] SESTRIERE Via Louset +39.0122.755444 [email protected] SUSA Corso Inghilterra 39 +39.0122.622447 [email protected] A CITY YOU City Sightseeing Torino is a valuable ally in your time spent WOULDN’T EXPECT in Torino. By means of this “panoramic” double-decker bus you will be able to discover the city’s many souls, travelling on two lines: “Torino City Centre” and If you decide to stay in Torino “Unexpected Torino”. You can’t get more or the surrounding areas for your convenient than that… holiday, our Hotel & Co. service lets www.turismotorino.org/en/citysightseeing you reserve your stay at any time directly online. Book now! ot www.turismotorino.org/en/book .turism orino.o ww rg/ w en Lively and elegant, always in movement, nonetheless Torino is incredibly a city set in the heart of verdant areas: gently resting on the hillside and enclosed by the winding course of the River Po, it owes much of its charm to its enchanting location at the foot of the western Alps, watched over by snowy peaks. -

Exhibitions Food&Wine
APRIL 2016 TORINO METROPOLI 18/09/2015 - 26/09/2016 NOT TO BE MISSED EXHIBITIONS IN THE GREAT MUSEUMS 18/09/2015-22/05/2016 Torino and the Great War - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 At the crime scene. The image’s 05/03 - 04/09 evidence from the Shroud to the drones - Camera Centro Italiano per THE NILE AT POMPEI. la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. The cinema in the Cuban VISIONS OF EGYPT IN THE ROMAN WORLD graphic - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Sprites, cupids, The exhibition focuses on the meeting of two cultures, Egyptian genies and cherubs. Allegories and decoration of putti from the and Roman-Hellenistic, starting from Alexandria through to the Baroque to Neoclassic - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; Pompei’s homes and places of worship. 27/02-10/04 Olympic Museum. The passion relives; 18/03-05/06 Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 Simply. Rural family; 15/04-11/09 A prince on the cover. Lous Amadeus T. (+39) 011.4406903 - www.museoegizio.it of Savoy, Duke of Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 07/03- 10/04 Aesop, Phaedrus & C. The classic fairy tales among art and 11/03 - 04/07 children’s books - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; FROM POUSSIN TO THE IMPRESSIONISTS. 09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione THREE CENTURIES OF FRENCH Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Photographs and paintings 1920- 1960; 10/03-26/06 Renato Birolli. -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza
TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Allegato 4 Accordo Con Firme
Comune di riferimento DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE RELATIVA ALL’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DI “COLLINAPO MAN AND BIOSPHERE RESERVE” PREMESSO CHE E’ sempre più urgente lavorare sull’integrazione tra tutela delle risorse naturali e sviluppo socio- economico di un territorio, nella convinzione che solo così si possano perseguire gli obiettivi di sostenibilità; Il Programma MAB è un riconoscimento internazionale avviato dall'UNESCO negli anni '70 allo scopo di migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca; Il provvedimento istitutivo delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese è la Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”; il Parco attribuisce alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale un valore strategico allo sviluppo e alla qualificazione del proprio territorio; il Parco è interessato a supportare attività di ricerca finalizzate alla individuazione di modelli gestionali e di governance per il territorio protetto e per i territori di CollinaPo e ha individuato tra i suoi obiettivi strategici quello di candidarsi a Riserva MAB – Man and Biosphere - dell’UNESCO; il marchio CollinaPo registrato come marchio collettivo nel 2012 costituisce il primo step per la messa in atto di un nuovo modello territoriale; Il processo di candidatura a Riserva MAB rappresenta una delle azioni strategiche avviate dall’ente Parco al fine di migliorare il modello gestionale -

Il Tramway Torino – Poirino
1 STORIA DEI POIRINESI IL TRAMWAY TORINO – POIRINO 1881 - 1949 ASSOCIAZIONE PER IL MUSEO STORICO DELLA COMUNITA’ POIRINESE Ricerca di Luciano Baravalle 2 IL TRAMWAY TORINO - POIRINO 1881 – 1949 Progetto (abortito) per la costruzione di una Linea ferrata da Cambiano ad Alba Nel 1872 fu costituito Un Comitato Promotore della ferrovia da Cambiano ad Alba. I Delegati dei Comuni di Poirino e Pralormo: Mazzucchi Notajo Agostino Sindaco di Poirino e Ferreri cav. Alberto Sindaco di Pralormo, l’8 di luglio, invitarono i maggiorenti delle due comunità ad intervenire all’adunanza generale di tutti i Comuni aventi interessi nella costruenda linea ferrata; adunanza programmata per le 9 del 21 corrente, nella sala Municipale di Canale, con lo scopo di addivenire alla Costituzione definitiva del Comitato direttivo cui affidarne il Mandato. 3 4 La costruenda ferrovia avrebbe avuto il precipuo scopo di movimentare le merci ed i prodotti tipici delle zone attraversate. I Sindaci infatti invitarono le unità produttive locali a quantificare i volumi di merci che avrebbero potuto spedire e ricevere dal nuovo mezzo di trasporto. Il Sindaco di Poirino interpellò soprattutto la Teleria dei fratelli Melano che così prontamente rispose: 1° Movimento settimanale fra Poirino e Torino e viceversa, in media dai 220 ai 250 miriagrammi. 2° Fra Poirino e la stazione di Cambiano e viceversa una media settimanale di 600 Miriagrammi, compresi i grossi colli non trasportabili a braccio d’uomo che ascendono alla metà circa. 5 6 Anche gli altri Comuni interessati interpellarono le unità operative locali. Il Comune di Montà comunicò le esportazioni locali: 1° Uva miriagrammi 3.000 2° Vino ettolitri 700 3° Legna miriagrammi 200 4° Castagne primaticce miriagrammi 200 5° Passeggieri giornalieri, in media, 15. -

I Percorsi Cicloescursionistici Delle Strade Di Colori
Albugnano I percorsi Torino Baldissero Torinese Moncucco Torinese cicloescursionistici delle Bivio 10 45° 3'35.21"N Strade di colori e sapori 7°52'48.05"E Palazzo del Bivio Bici consigliata: MTB, cicloturismo. Periodo consigliato: Apr-Ott 45° 3'34.83"N Gli itinerari sono descritti nel retro di copertina Municipio 45° 3'28.56"N 7°53'30.31"E 7°52'24.36"E Bivio 45° 3'13.91"N Marentino 7°53'15.18"E Lago di Arignano 45° 2'42.17"N 7°53'34.33"E Inizio strada della Serra Mombello di Torino Pino Torinese 45° 2'23.28"N Castelnuovo Don Bosco 7°48'56.58"E 10 Moriondo Torinese Cappella del Rosero Andezeno 45° 1'52.85"N Cappella di S.Irene Bivio strada Rio 7°45'19.97"E 45° 1'59.23"N Arignano Martello Inc con via Rosero Cappella del Podio 8 7°49'22.40"E 45° 1'56.04"N 45° 1'55.78"N 45° 1'40.61"N Villa Cipresso 7°44'49.18"E 7°45'35.48"E 7°46'46.93"E 45° 1'53.84"N 7°48'40.78"E 8 6 Via Pistarino Cappella 45° 1'29.93"N di S.Grato 7°47'56.00"E Inc via Ribore Imbiancheria 45° 1'12.08"N (Cascina Albera) 7°44'54.02"E del Vajro 45° 1'24.47"N Strada Ciattalina 45° 1'0.67"N Buttigliera 7°45'12.72"E S.Maria della Neve 45° 0'55.52"N 7°48'45.13"E Bivio 45° 1'0.37"N 7°46'5.97"E Bivio Bonafus 45° 1'7.23"N 7°44'59.30"E Chiesa di 45° 1'2.44"N Chiesa di S.Giorgio 7°53'56.36"E S.Sebastiano Cappella S.Felice 7°47'42.02"E 7 Duomo 45° 0'46.67"N Moncalieri Pecetto Torinese 45° 0'49.59"N 45° 0'49.62"N 7°49'33.72"E Chieri 7°45'10.08"E 7°46'56.86"E Collegamento 45° 0'41.81"N Chiesa di S.Domenico sentieri Le Vallere Castello di Villa Ronco 7°49'21.23"E 45° 0'35.14"N 45° 0'7.04"N -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)
Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Official Journal C 435 of the European Union
Official Journal C 435 of the European Union Volume 61 English edition Information and Notices 3 December 2018 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2018/C 435/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) (1) 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2018/C 435/02 Notice for the attention of a person subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2014/119/CFSP and in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine ........................ 2 2018/C 435/03 Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Regulation (EU) No 208/2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine apply ..................................................................... 3 European Commission 2018/C 435/04 Euro exchange rates .............................................................................................................. 4 EN (1) Text with EEA relevance. 2018/C 435/05 Commission Implementing Decision of 21 November 2018 on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a geographical indication in the spirit drinks sector referred to in Article 17 of Regulation -

Un Tour Estivo Intorno Alla Riserva Di Biosfera “Urban Mab Unesco”
UN TOUR ESTIVO INTORNO ALLA RISERVA DI BIOSFERA “URBAN MAB UNESCO” COLLINAPO ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI TORINESI TRA AGRICOLTURA, NATURA, STORIA, FLORA, FAUNA, PAESAGGIO, BENI ARTISTICO CULTURALI E TRADIZIONI Nel 2012 nasce il geomarchio di territorio CollinaPo, una iniziativa del Parco regionale del Po e Collina torinese che muove i suoi passi da una semplice constatazione: i singoli beni, i singoli monumenti e paesaggi che distinguono il territorio fra Po e collina torinese intorno a Torino, possono diventare una opportunità di richiamo turistico e marketing territoriale se inanellati in un unico palcoscenico unitario, somma di tante locali eccellenze e possono ambire complessivamente a un riconoscimento mondiale UNESCO come quello proposto dal Programma MAB Man and Biosphere. E’ nato quindi, grazie a varie expertise un progetto di promozione integrata, che comprende un vasto comprensorio, che ha un valore di scala regionale e non solo, e per tale ragione nel 2014 viene candidato nella lista delle Riserve della Biosfera del MAB UNESCO e portato poi con successo a Nomina nel 2016 con il supporto di Istituto SiTI e Gruppo IREN a cui si sono poi aggiunti Smat e GTT, insieme a un centinaio di Soggetti Partner. In questa prima estate, dopo il riconoscimento ricevuto il 19 marzo 2016 in occasione del congresso Mondiale delle Riserve UNESCO a Lima, ecco una prima proposta per un “Un Tour in CollinaPo” che lanciamo in occasione dell’appuntamento finale con il Superga Park Tour - domenica 11 settembre ore 13,30 presso la Stazione Dentera Gtt a Superga - al quale vi aspettiamo per approfondire con tanti Ospiti prestigiosi il tema “Uomo, Natura e Creatività” con l’apertura lavori a cura di Valter Giuliano, Presidente Parco del Po e Collina Torinese. -

Guida Turistica
USD Pralormo Comune di Pralormo Pralormo: di più! Festa Pallavolo UISP 2014 01-02 giugno USD Pralormo Comune di Pralormo XIII e XIV, che coincidono con la pianificazione Storia territoriale portata a compimento dall’allora potentissimo comune di Asti al fine di rendere Il paese di Pralormo si adagia su di una sempre più sicure le vie del commercio dei collina situata in un area di transizione tra le mercanti astigiani verso l’Europa. estreme propaggini del Pianalto e l’inizio del Infatti, all’inizio del ‘200 Pralormo sembra Roero. essere suddiviso tra due importanti famiglie: i signori di Anterisio e i Desaya da un lato, che Il toponimo è la sintesi di due parole controllavano il settore da Ceresole a Stuerda fino “pratum ad ulmum”, nome invalso al torrente Rio Verde, e i Gorzano dall’altro, che probabilmente dalla tradizione longobarda di estendevano loro influenza verso ovest fino al piantare piante (principalmente olmi e querce) in margine dei rilievi che si affacciano al torrente Rio punti simbolici dell’abitato. Verde. L’ultimo esemplare di olmo monumentale, che occupava l’angolo posto tra via Carlo Morbelli Dagli scarsi documenti rinvenuti si desume e piazza Vittorio Emanuele II, è caduto all’inizio che il primo insediamento di Pralormo fosse del ‘900 a causa di fulmine: due fotografie localizzato a sud-est del paese, nella località dove dell’epoca, che ritraggono l’esemplare prima e oggi sorge il pilone votivo dedicato a San Donato, dopo il disastro, sono conservate nella Sala patrono della comunità. A testimonianza di ciò vi Consigliare e sono incorniciate con la corteccia sono numerosi resti, anche umani, che attestano recuperata dal tronco. -

1. Individuazione Delle Zone Sismiche Su Base Comunale 1.1
1. Individuazione delle zone sismiche su base comunale 1.1. Zona sismica 3S Comprende 44 comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. PROVINCIA DI TORINO 1. Angrogna 11. Garzigliana 21. Pinasca 31. Salza di Pinerolo 2. Bibiana 12. Giaveno 22. Pinerolo 32. San Germano Chisone 3. Bobbio Pellice 13. Inverso Pinasca 23. Pomaretto 33. San Pietro Val Lemina 4. Bricherasio 14. Luserna S. Giovanni 24. Porte 34. San Secondo di Pinerolo 5. Campiglione-Fenile 15. Lusernetta 25. Prali 35. Sant'Antonino di Susa 6. Cantalupa 16. Macello 26. Pramollo 36. Torre Pellice 7. Coazze 17. Massello 27. Prarostino 37. Usseaux 8. Cumiana 18. Osasco 28. Roletto 38. Villar Focchiardo 9. Fenestrelle 19. Perosa Argentina 29. Rora' 39. Villar Pellice 10. Frossasco 20. Perrero 30. Roure 40. Villar Perosa PROVINCIA DI CUNEO PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 1. Bagnolo Piemonte 1. Baceno 2. Limone Piemonte 2. Crodo 1.2. Zona sismica 3 Comprende 365 comuni, di cui 115 in provincia di Alessandria, 3 in provincia di Asti, 133 in provincia di Cuneo, 86 in provincia di Torino, 27 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 1 in provincia di Vercelli. PROVINCIA DI ALESSANDRIA 1. Acqui Terme 31. Cassinelle 61. Momperone 91. Rocchetta Ligure 2. Albera Ligure 32. Castellania 62. Mongiardino Ligure 92. Sale 3. ALESSANDRIA 33. Castellar Guidobono 63. Monleale 93. San Cristoforo 4. Alice Bel Colle 34. Castellazzo Bormida 64. Montacuto 94. San Sebastiano Curone 5. Alluvioni Cambio' 35. Castelletto d'Orba 65. Montaldeo 95. Sant'Agata Fossili 6. -
Cave E Miniere Attive Della Provincia Di TORINO (In Giallo Sono Evidenziate Le Attività Estrattive Con Autorizzazione Scaduta Da Meno Di 3 Anni)
Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere Cave e miniere attive della provincia di TORINO (in giallo sono evidenziate le attività estrattive con autorizzazione scaduta da meno di 3 anni) COMUNE LOCALITA' LITOTIPO IMPRESA CODICE ALPETTE BISDONIO DETRITO DI FALDA C.E.V.I.G. SRL V7T ALPETTE CASE BISDONIO GNEISS TIBOLDO GRANITI S.R.L. G265T BALME BALME METALLI STRATEGIC MINERALS ITALIA S.R.L. P46T BORGOFRANCO D'IVREA RIO SAN GERMANO-PESCATORI MATERIALE ALLUVIONALE COGEIS SPA M1921T BRUZOLO ALPE CRUVINO METALLI AGE EV MINERALE S.R.L. P45T BRUZOLO VERNETTI MATERIALE ALLUVIONALE ESLO*SILOS S.R.L. M437T CAMBIANO CASCINA TALPONE ARGILLA FORNACE LATERIZI CARENA S.R.L. A90T CARAVINO Grivellino MATERIALE MORENICO IVIES SPA O3T UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE CARIGNANO CERETTO MATERIALE ALLUVIONALE M40T UNICAL S.P.A. CARIGNANO GERMAIRE MATERIALE ALLUVIONALE CAVE GERMAIRE S.P.A. M47T UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE CARIGNANO LA GORRA 2 MATERIALE ALLUVIONALE M757T UNICAL S.P.A. CARIGNANO MADONNA DEGLI OLMI MATERIALE ALLUVIONALE CAVA DEGLI OLMI S.R.L. M43T CARIGNANO Po Morto - Tetti Faule MATERIALE ALLUVIONALE CALCESTRUZZI S.P.A. M49T CARIGNANO PROVANA MATERIALE ALLUVIONALE CAVE PROVANA - S.P.A. M42T CARIGNANO S. MICHELE MATERIALE ALLUVIONALE CALCESTRUZZI S.P.A. M48T CASELETTE C.na Baldon MATERIALE ALLUVIONALE GEOSERVIZI srl M1837T CASELETTE C.na La Grangetta MATERIALE ALLUVIONALE ALLARA S.P.A. M1883T CAVOUR C.na Teppa MATERIALE ALLUVIONALE MERLO S.R.L. M1835T CAVOUR MEZZA LUNA MATERIALE ALLUVIONALE CAVE GALLO S.R.L. M1894T CHIVASSO BOSCHETTO MATERIALE ALLUVIONALE ALLARA S.P.A. M497T COLLEGNO C.na Provvidenza MATERIALE ALLUVIONALE CAVE DRUENTO - S.R.L.