La Grande Guerra E Il Cinema Italiano E Francese
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Faro Film E Rai Cinema
Compagnia Italiana Faro Film Rai Cinema presentano un film di MAURIZIO SCAPARRO con MASSIMO RANIERI L’ULTIMO PULCINELLA ADRIANA ASTI JEAN SOREL VALERIA CAVALLI DOMENICO BALSAMO CARLA FERRARO MARGOT DUFRENE e con GEORGES CORRAFACE con la partecipazione straordinaria di ANTONIO CASAGRANDE Soggetto e Sceneggiatura Rafael Azcona, Diego De Silva, Maurizio Scaparro Musiche Mauro Pagani Distribuzione Bolero Film Distribuzione Internazionale Rai Trade Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per il Cinema Progetti Speciali 2007 Durata: 89’ Uscita nelle sale: venerdi 13 marzo 2009 Crediti non contrattuali CAST TECNICO Regia Maurizio Scaparro Soggetto e Sceneggiatura Rafael Azcona, Diego De Silva, Maurizio Scaparro. Scenografia Giantito Burchiellaro Arredo Stefania Maggio Costumi Gianni Addante Aiuti Regia Ferdinando Ceriani, Luca Pedrini Suono Mario Iaquone Fotografia Roberto Meddi (A.I.C. Imago) Montaggio Luca Gianfrancesco Musiche Mauro Pagani Edizioni Musicali MACU’ Organizzatore Generale Antonella Viscardi Prodotto da Maria Bellini e Giorgio Magliulo Una Produzione Compagnia Italiana - Faro Film - Rai Cinema Distribuzione Bolero Film Distribuzione Internazionale Rai Trade CAST ARTISTICO Michelangelo Massimo Ranieri Marie Adriana Asti Jean Paul Jean Sorel Paola Valeria Cavalli Francesco Domenico Balsamo Cecilia Carla Ferraro Faiza Margot Dufrene Commissario di Polizia Georges Corraface Proprietario teatro Antonio Casagrande I materiali stampa sono disponibili sul sito: http://www.saverioferragina.com/lultimopulcinella.htm -

Maccio Capatonda
LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group e MEDUSA FILM presentano OMICIDIO ALL’ITALIANA un film di MACCIO CAPATONDA con MACCIO CAPATONDA (Marcello Macchia) HERBERT BALLERINA (Luigi Luciano) IVO AVIDO (Enrico Venti) SABRINA FERILLI ANTONIA TRUPPO FABRIZIO BIGGIO prodotto da MARCO BELARDI una produzione LOTUS PRODUCTION con MEDUSA FILM distribuzione www.medusa.it Ufficio stampa Ufficio stampa web Maria Rosaria Giampaglia [email protected] Valentina Guidi tel. 335 6887778 Marcello Bisceglie – [email protected] Mario Locurcio tel. 335 8383364 tel. 06 98968055 [email protected] - www.guidilocurcio.it OMICIDIO ALL’ITALIANA CAST ARTISTICO Piero Peluria, Filippo Bello, Eugenio Normale MARCELLO MACCHIA (Maccio Capatonda) Marino Peluria LUIGI LUCIANO (Herbert Ballerina) Agente Farina ENRICO VENTI (Ivo Avido) Commissario Fiutozzi GIGIO MORRA Donatella Spruzzone SABRINA FERILLI Fabiola Normale ANTONIA TRUPPO Gianna Pertinente ROBERTA MATTEI Antonello FABRIZIO BIGGIO Contessa Ugalda Martirio In Cazzati LORENZA GUERRIERI CAST TECNICO Regia MARCELLO MACCHIA (Maccio Capatonda) Soggetto MARCELLO MACCHIA GIANLUCA ANSANELLI SERGIO SPACCAVENTO Sceneggiatura MARCELLO MACCHIA GIANLUCA ANSANELLI LUIGI LUCIANO DANIELE GRIGOLO DANILO CARLANI SERGIO SPACCAVENTO Montaggio GIOGIO’ FRANCHINI MARCELLO MACCHIA Fotografia MASSIMO SCHIAVON Suono ROBERTO REMORINO Scenografie PAOLO SANSONI Costumi CHIARA MASSA Trucco PAOLO BREDA Produttore Esecutivo per ENRICO VENTI Lotus Production 2 OMICIDIO ALL’ITALIANA LOTUS PRODUCTION società di Leone Film Una produzione Group con MEDUSA FILM LOTUS PRODUCTION società di Leone Film Realizzata da Group Prodotta da MARCO BELARDI Una distribuzione MEDUSA FILM Durata: XXXXX materiali stampa disponibili sui siti www.guidilocurcio.it e www.medusa.it - crediti non contrattuali - SINOSSI Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese. -

«In Una Baracca Rivedo Emanuela Ora Ha 5 Anni»
Anno 62* N. 266 Quotidiano LIRE 650 Sped. abb. post, gruppo 1/70 SABATO 23 NOVEMBRE 1985 Arretrati L. 1.300 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 23 novembre y80 - 23 novembre '85 Il giorno dopo dei due protagonisti del vertice di Ginevra Con relazione Viaggio nelVIrpinia terremotata di Bufai ini La Ccc «In una baracca A Mosca e a Washington discute sul rivedo Emanuela soddisfazione e fiducia partito Il Congresso ha accolto trionfalmente Reagan che va al Nel suo discorso ai parlamentari e alla nazione il presidente Usa parla di «incontro costruttivo» e di «nuovo Ora ha 5 anni» realismo» - Resta centrale il nodo delle «guerre stellari» - Più vasta la base d'appoggio della Casa Bianca Congresso Gorbaciov ha portato a Mosca, Dal nostro corrispondente gersi ad una Intesa con l'an ROMA — Il partito che va al dalla riunione del Patto di NEW YORK — Forse è la tagonista per risolvere 1 pro Nell'interno congresso, la vitalità delle Varsavia, un giudizio sostan prima volta che un «coman- blemi che egli stesso aveva sue organizzazioni, la demo zialmente soddisfatto: le posi dante supremo», rientrando In parte contribuito ad esa crazia Interna, l'autofinan zioni restano distanti, i prò* da una spedizione all'estero sperare. ziamento, le procedure con bJemi sono tutti aperti, ma «il riceve, all'arrivo in patria, Il senso del suo discorso al gressuali. Questi temi sono dialogo è cominciato» e ci sono un'accoglienza da trionfato arlamentari e alla nazione stati affrontati dalla Com dunque condizioni «più favo re non per aver battuto 11 S espresso In alcune frasi missione centrale di control revoli per ritornare alla di principale avversario ma per chiave che riassumono il lo, sulla base di una relazio stensione». -
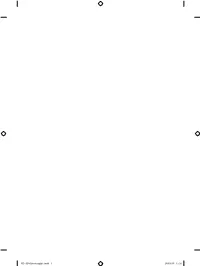
M3 0010.Frontespizio.Indd 1 03/04/13 15:37
M3_0010.frontespizio.indd 1 03/04/13 15:37 M3_0010.frontespizio.indd 2 03/04/13 15:37 M3_0010.frontespizio.indd 3 03/04/13 15:37 © 2013 RCS Libri S.p.A., Milan All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior consent of the publisher. Special Edition printed for Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. Translation by Aaron Maines Images courtesy © Barilla Historical Archives The publisher has made every effort to locate and contact all the holders of copyright to material reproduced in this book. The publisher remains available to address any rights that have not been fully identified. M3_0020.copy_PS.indd 4 03/04/13 15:37 M3_0030.occhiello.indd 5 03/04/13 15:38 M3_0030.occhiello.indd 6 03/04/13 15:38 For my friend Pietro. Francesco Alberoni M3_0040.dedica.indd 7 03/04/13 15:38 M3_0040.dedica.indd 8 03/04/13 15:38 INTRODUction I first met Pietro Barilla in the 1970s, worked as his consultant throughout his life, and was with him during his final days. When his children Guido, Luca, Paolo and Emanuela asked me to write their father’s biography, I thought it over for a long time. A biog- raphy is usually the work of a historian, someone who tells the sto- ry of a famous person’s life by rebuilding it as precisely as possi- ble, making the subject seem as close as possible, present in such a way that whoever reads the biography feels like a participant in his or her life. -

RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Numero 2 - Anno 86 16 Gennaio 2017 Reg
RADIOCORRIERE TV SETTIMANALE DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA numero 2 - anno 86 16 gennaio 2017 Reg. Trib. n. 673 del 16 dicembre 1997 2 TV RADIOCORRIERE 3 Che Carlo Conti avesse l'idea di avere al suo fianco Maria De Filippi lo avevamo intuito già da tempo. In alcune riunioni dello scorso anno, mentre si lavorava al piano di comunicazione dell'edizione 2016, il presentatore toscano aveva ventilato questa ipotesi tra un sorriso e una battuta. Ma quando Carlo parla bisogna interpretarlo. Non sai mai se le sue affermazioni siano semplici battute o se dietro quelle parole si nasconda una mezza verità, quasi a stuzzicare i presenti, cercando risposte immediate alle idee che “butta là”. Una sorta di sondaggio dal quale trarre indicazioni operative. da strada Vita Ricordo che mentre si fantasticava sugli ospiti stranieri e ognuno avanzava proposte (io facevo ancora il tifo per i Pink Floyd), l'occhio si posava immancabilmente su un manifesto di Elton John che campeggiava nella stanza del capostruttura. Fummo in molti a commentare: “Certo che vederlo sul palco dell'Ariston sarebbe una gran cosa”. Non ci sfuggì un guizzo sul viso di Carlo, che aveva già in serbo il colpo. Il suo sorriso sembrava una conferma, anche se la risposta fu: “Magari!” In questi anni ho avuto la fortuna di collaborare spesso con Carlo e di apprezzarne la grandissima professionalità, la forte personalità, l'umanità, ma soprattutto la sua immensa disponibilità verso tutti. Quando parlammo la prima volta del Festival, mi disse che il suo obiettivo era quello di riportare la musica sanremese nell'etere. -

De Ferraro Domenico
BALLATE DELLA MESTA ESTATE BALLATE DYLANIANE POST COVID DI DOMENICO DE FERRARO PRESENTAZIONE Le ballate della mesta estate nascono dal fondo della mia coscienza inquieta, fatta di sale e di sole che si specchia nel mare dell’amore. Una serie di prose poetiche che vorrei definire come ballate Dylaniane , dedicate segretamente a Claudio Lolli , mitico cantautore che ha accompagnato la mia adolescenza ed i miei passi nel mondo della poesia musicale . I suoi versi , quelli di vecchia piccola borghesia risuonano ancora in me nel fumo aspirato di uno spinello fumato di nascosto . Ballate Dylaniane , beltà nate nella profonda periferia di una metropoli decadente perduta nel canto d’ un amore che imita la morte, un andare , un venire, una serie di versi chiusi in un cassetto . Tanti versi esultanti che tutto ad un tratto ho udito gridare all’improvviso da quel mio cassetto, chiedere di voler essere rappresentate , pubblicati , nel bel mondo delle lettere. Ed io assolvo il mio compito di poeta , le pubblico con l’animo mesto con passione di chi beve ogni giorno l’amaro calice della realtà di periferia , nello scrivere e nel sognare , le lego al carro delle lettere e le lascio andare , danzanti per dimensioni sconosciute per paesi , città , metropoli , nazioni, in ogni luogo ove splende l’eterno desiderio dell’ estate della sua estetica, intrisa di gaie immagini , raminghe nell’immaginare amori e mondi infiniti. DOMENICO DE FERRARO Scrittore Espressionista . Poeta Futurista . Apprendista Filosofo. Rapper in Podcast. Autore di audio libri. .Membro dell’accademia degli oziosi e dell’accademia poesia nel Mondo appassionato fin dalla tenera età all'arte della narrativa e della poesia. -

La Poesia Di E. A. Mario
• LA POESIA DI E. A. MARIO by Maria Trani Department of Italian McGiII University, Montreal August, 1992 A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements of the degree of Masfer of Arts This thesis was directed and supervised by Prof. Sergio Maria Gilardino Ali rights reserved in ail countries Maria Trani • 1992 t ~(Jrne [),sscrt(Jt/~n-Ab-;tracts Inte--;natlon~~a~ge~tbybroad, generolsublect categories Please select the one sublect wh,ch mos! nûorll df)'><:rlb(~~ tlllJ content of your d,'"ertCJ!lon Enter the corres,!)ondmg four digit code ln the spaces provlded Ir-0 r---111-1Ir--To 1---',] U· M· 1 SUBJECT TE~M SUBJECT CODE Subject Categories THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES {f)MMUNICATIONS AND THE ARTS p"t'!'"I",!! 0'>75 PHILOSOPHY, RELIGION AND Anclpnf 0579 Ilf 1III! (!tif' 'J/ ;'1 ~( Odlliq 0515 THEOLOGY Mcdlc;ol 05fl1 /.,1 , 1, ,l'II 1 IJ l// ~(II j!fill OS7! Modern 0582 PfphlOfJh f 047L (J'l'JI; l'I('lfl J 0714 r 1','rI"l RLIIt,0fl Bloek 0328 fJIIfI'. ((l','!'lf/ U533 Afncon 0331 " Ve >, :I( Ilel(ll Ull8 IIIU j.r! rJI''; j,,(l(ll JI ,Pn,_(.) 0514 k,bl",,1 St "1",, 0121 A;,o Aust'ol,u and Ocean la 0332 1II'I,/tfl/l!",! (!l/l ')'Jr''-JII)<JI (Jf 0l4U { Ip((l! 1]319 (u,",od'un 0334 JI.')/IIIII'III (J l') 1 'JP"( 101 0',;9 European H Jlo',! (II OJ20 0335 1 rLrfH 1"/ !I/,r, () ~9fl rf'ortui TrtJllllr'q (J'JJO lotln Arnf>r •({Hl 0336 Phdv,nphl r)t 03:2 t (j/lJ!l 01,1) fll."',II,'"""lIllI llll,1I 1. -

Il Mito Di Giulio Cesare E Il Culto Della Romanità Nel Teatro Musicale Dell’Era Fascista: I Casi Di Gian Francesco E Riccardo Malipiero (L-ART 07)
Humanae Litterae Corso di dottorato in Scienze dei Beni culturali e ambientali XXVIII ciclo Il mito di Giulio Cesare e il culto della romanità nel teatro musicale dell’Era Fascista: i casi di Gian Francesco e Riccardo Malipiero (L-ART 07) Dissertazione dottorale di ALESSANDRO TURBA Tutor: Chiar.mo Prof. EMILIO SALA Coordinatore del dottorato: Chiar.mo Prof. GIAN PIERO PIRETTO Anno Accademico 2015-2016 SOMMARIO INTRODUZIONE p. V SIGLE E ABBREVIAZIONI p. IX 1. Dalla Favola al Mito: chiose alla Favola del figlio ‘proibito’. p. 1 2. Dall’‘Ur-Giulio Cesare’ al Giulio Cesare. p. 17 2.1. Malipiero a Canossa. p. 18 2.2. Il libretto. p. 20 § 2.2.1. Il trattamento della fonte shakespeariana. p. 22 § 2.2.2. L’‘Ur-Giulio Cesare’ p. 24 § 2.2.3. La gestazione della partitura. p. 27 2.3. “A.A.A. Cercasi teatro disperatamente”. p. 28 2.4. L’iter (auto)censorio del libretto. p. 33 3. La drammaturgia musicale del Giulio Cesare. p. 37 3.1. Il recitativo “parlato”. p. 39 3.2. Una virtuale scena multipla: il coro «Gentis humanae pater p. 44 atque custos». 3.3. «Tutto dipende dal saper dominare la massa come un artista»: p. 48 la retorica (musicale) dei discorsi di Bruto e di Antonio. § 3.3.1. «Bruto è un uomo rispettabile»? p. 51 § 3.3.2. Lex orandi, lex credendi: il ‘rito del sangue’ officiato p. 58 da Antonio. 3.3. «O falsa invidia, inimica di pace», ovvero la ‘Nona canzone’ p. 71 di Malipiero 3.4. Il tessuto leitmotivico. -

Iprogrammi Di Oggi
01SPE04A0112 ZALLCALL 12 20:01:55 11/30/97 Lunedì 1 dicembre 1997 6 l’Unità2 IPROGRAMMI DI OGGI DA VEDERE 24 ORE DA VEDERE SCEGLI IL TUO FILM CANDIDO TELEMONTECARLO. 12.00 8.30 L’ANNIVERSARIO Il programma di Lubrano ospita l’esperta in Regia di Roy Ward Baker, con Bette Davis, Sheila Hancock. Gb problemi condominiali Renata Balzani, che (1968). 95 minuti. spiegherà cosa succede se i condomini anticipano Una grande Bette Davis nel ruolo della terribile le spese di un solo inquilino che si rifiuta di pagare. vedova Taggart, cieca da un occhio, sul quale Altro argomento in scaletta, l’impotenza: porta una misteriosa benda nera. La sua cecità interviste a medici ed esperti. In studio anche comunque non le impedisce di tiranneggiare Walter Passerini, che parlerà di occasioni di lavoro sui tre poveri figli, costretti a riunirsi ogni anno da non perdere, e Elio Lanutti che spiegherà per l’anniversario della morte del padre. Scatta 01SPE04AF01 quanto costa un conto corrente bancario. 01SPE04AF02 inevitabile lo psicodramma... RAITRE UN GIORNO IN PRETURARAITRE. 20.40 20.45 DEMOLITION MAN A proposito di sequestri di persona, Regia di M. Brambilla, con Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra drammaticamente tornati alla ribalta, «Un giorno Bullock. Usa (1993). 114 minuti. in pretura» ripropone il processo ai sequestratori di Stallone contro Snipes, un sergente di polizia Carlo Celadon, il 20enne rapito nel gennaio dell’88 contro un pericoloso psicopatico; entrambi e liberato il 5 maggio del ‘90. Il primo processo fu condannati - così vuole il copione e il destino - celebrato quando Celadon era ancora prigioniero. -

Compagnia Teatrale Anno Di Fondazione: 2014 PADOVA
Fitainscena32 illustrazione cover DEF.pdf 1 24/09/18 09:57 3 FITAINSCENAREPERTORIO DELLE COMPAGNIE PER LA STAGIONE ARTISTICA 2018-20192 discussione ricerca intimo passione sogno servizio vita spazio commedia libertà esercizio studio sensazioni divertimento cura spettacolo TEATRO dramma realtà musical terapia suoni mito passione educazione tristezza correlazione sentimento apprendimento condividisione incontri AMATORIALE cabaret tragedia mimo fantasia bisogno gioia socialità creatività innovazione emozione bellezza formazione rito VENETO movimento commozione paura identità disciplina aggregazione piacere colori tradizione percezioni finzione comunicazione relazione Strutturazione del testo con il contributo delle informazioni pervenute dalle singole Associazioni Artistiche Redazione a cura di Cristina Cavriani, Valerio Dalla Pozza, Roberta Fanchin, Maria Pia Lenzi, Virgilio Mattiello, Germano Nenzi, Annarita Scaramella Supplemento a “Fitainforma” Direzione: 36100 Vicenza - stradella Barche, 7 - tel. e fax (0444) 324907 Autorizzazione Tribunale di Vicenza n. 570 del 13.11.1987 Direttore Responsabile: Andrea Mason Impaginazione grafica: Guido Zovico Stampa: Mediagraf Spa - Noventa Padovana (PD) FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI Regione Veneto 36100 Vicenza stradella Barche, 7 tel. (0444) 32 49 07 fax (0444) 32 49 07 e-mail: [email protected] sito internet: www.fitaveneto.org facebook.com/fitaveneto facebook.com/fitainforma twitter.com/fitaveneto giunta regionale Un patrimonio fondamentale È sempre con piacere che salutiamo una nuova -

The Austrian Enemy in Interwar Italian Cinema
University of New Orleans ScholarWorks@UNO Habsburg's Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present) University of New Orleans Press 6-2018 Without a Name and a Face: The Austrian Enemy in Interwar Italian Cinema Francesco Bono University of Perugia Follow this and additional works at: https://scholarworks.uno.edu/hlw Part of the European History Commons, and the Film and Media Studies Commons Recommended Citation Bono, Francesco. “Without a Name and a Face: The Austrian Enemy in Interwar Italian Cinema.” In Habsburg’s Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present), edited by Hannes Leidinger, 175-201. New Orleans: University of New Orleans Press, 2018. This Chapter is brought to you for free and open access by the University of New Orleans Press at ScholarWorks@UNO. It has been accepted for inclusion in Habsburg's Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present) by an authorized administrator of ScholarWorks@UNO. For more information, please contact [email protected]. WITHOUT A NAME AND A FACE: THE AUSTRIAN ENEMY IN INTERWAR ITALIAN CINEMA Francesco Bono Introduction In the years since the war’s end until today, approximately 100 feature films were produced inItaly with references to WWI.1 However, it must be noted that the number of films in which the Grande Guerra, (the “Great War”), as WWI is commonly referred to in Italy, represents the actual focus of attention is relatively rare. As has been widely remarked by scholars, there has been a sort of reticence in Italian cinema about WWI. Discussing the reasons for that would go beyond the scope of this essay, but I shall, in the course of it, provide some explanations for the phenomenon with 1 Warmest thanks go to Adriano Aprà, Umberta Brazzini, Alessandro Faccioli, Giuseppe Ghigi, Angela Margaritelli, and Alberto Scandola, as well as Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea (Rome), Centro Studi del Teatro Stabile dell’Umbria (Perugia), La Cineteca del Friuli (Gemona), and Mediateca Toscana for supporting my research.