Modelli Antropologici E Realtà Identitarie a Ferentino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Adesione Plessi
Elenco Istituzioni scolastiche aderenti regione LAZIO provincia di FROSINONE Cod.Istituto Denominazione istituto Cod.Plesso Denominazione plesso Indirizzo CAP Comune Provincia Classi Richieste 1 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80302Q ESPERIA MONTICELLI PIAZZA A. CAPRARELLI ESPERIA 03045 Esperia Frosinone *U 2 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80303R ESPERIA S.PIETRO VIA SAN ROCCO, 5 ESPERIA 03045 Esperia Frosinone 4U,5U 3 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80304T AUSONIA CAPOLUOGO VIA ALIGHIERI AUSONIA 03040 Ausonia Frosinone 4A,4B,5U 4 FRIC80300L IC ESPERIA FREE80306X CASTELNUOVO P. CAPOLUOGO VIA CAMPO PALOMBO 03040 Castelnuovo Parano Frosinone *U 5 FRIC80300L IC ESPERIA FREE803071 CORENO AUSONIO CAPOLUOGO VIA IV NOVEMBRE CORENO AUSONIO 03040 Coreno Ausonio Frosinone 4U,5U 6 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80401E GUARCINO CAPOLUOGO VIA SAN FRANCESCO N. 9 03016 Guarcino Frosinone 4A,5A 7 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80402G TORRE CAJETANI CAPOLUOGO VIA SPIUGHE 03010 Torre Cajetani Frosinone 4A,5A 8 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80403L TRIVIGLIANO CERRETA VIA CANAPINE N. 10 03010 Trivigliano Frosinone 4A,5A 9 FRIC80400C IC GUARCINO FREE80404N VICO NEL LAZIO CONTADA COLLI 03010 Vico nel Lazio Frosinone 4A 10 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807012 PIGLIO CAPOLUOGO VIA PIAGGE PIGLIO 03010 Piglio Frosinone 4A,5A,4B,5B 11 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807023 FILETTINO CAPOLUOGO VIA DELLA VARIOLA FILETTINO 03010 Filettino Frosinone 4A,5A 12 FRIC80700X IC PIGLIO FREE807034 TREVI NEL LAZIO CAPOLUOGO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 03010 Trevi nel Lazio Frosinone 4A,5A 13 FRIC80800Q IC E. DANTI ALATRI FREE80801T ALATRI MOLE BISLETI VIA MOLE BISLETI ALATRI 03011 Alatri Frosinone 4A,5A,4B,5B,5C 14 FRIC80800Q IC E. DANTI ALATRI FREE80803X FELICE CATALDI ALATRI VIALE DANIMARCA ALATRI 03011 Alatri Frosinone 4A,5A,4B,5B,4C,5C 15 FRIC81100G IC RIPI FREE81101N RIPI CAPOLUOGO P.ZZA G. -

Scuola Primaria A.S.2009-10 - RETTIFICHE
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone VI^ UNITA’ OPERATIVA - UFFICIO II° Via Verdi n° 29 0775/296264 - tel./ fax 0775/200724 - 0775/296260 prot. n° AOOUSPFR17710 Frosinone, 21/08/2009 Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali insegnanti di Scuola Primaria a.s.2009-10 - RETTIFICHE il DIRIGENTE VISTO il contratto collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 26.06.2009 concernente le operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico del personale docente ed educativo per l'a.s. 2009-10; VISTO il proprio provvedimento n. 17432 del 14.8.09 con cui sono state disposte le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2009/2010; ESAMINATI i reclami prodotti da alcuni insegnanti; CONSIDERATO che nel frattempo si sono resi liberi ulteriori posti per effetto di assegnazioni ed utilizzazioni in altre classi di concorso e per distacco sindacale; ATTESA la necessità di apportare le necessarie modifiche; TENUTO CONTO delle richieste di conferma nelle precedenti sedi di titolarità; VISTA la graduatoria degli insegnanti di Scuola Primaria richiedenti l'utilizzazione e/o l'assegnazione provvisoria per l'a.s.2009-10; VISTE le sedi disponibili e le preferenze espresse dagli interessati; DECRETA ART.1 per l'a.s. 2009-10 sono disposte le seguenti utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali degli insegnanti di Scuola Primaria di ruolo: ART.2 il presente decreto annulla e sostituisce -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

CV Filonardi Antonio.Pdf
Curriculum Vitae Nome Antonio Filonardi Luogo e data di nascita: Ferentno (FR) 16/5/1959 Residenza: Ferentino (FR) E.MAIL: [email protected] Cittadinanza: italiana ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE Collaborazione segreteria On.Giorgio Santuz (sottosegretario di stato Lavori Pubblici) 1982 Collaboratore con diverse segreterie politiche (1983/84) Collaboratore Fondazione Città dei ragazzi “Don Salvatore d’Angelo” Maddaloni (CE) 1983 Collaboratore con “Agenzia” del Ministero degli Interni (1984) Dipendente ENEL (Ente nazionale Energia elettrica) Area Amministrativa Zona Frosinone 1984/1998 1 Dipendente ENEL S.p.A. Responsabile Area Amministrativa rapporti Enti Pubblici e grandi utenti 1998/2002 Zona Frosinone Dipendente ENEL Distribuzione S.p.A Direzione Lazio Abruzzo Molise (Roma) Responsabile Rapporti Enti Pubblici e grandi utenti 2002/2005 Incaricato alla promozione progetti infrastrutturali con P.A., conto FIAT IMPRESIT SpA, BREDA Costruzioni SpA, COOPSETTE. 1987/89, per opere finanziabili L.64/86-67/88 in collaborazione con la Venturelli &Co, s.n.c. di Scandiano (RE). Presidente ed amministratore C.A.F. Cooperativa agricola forestale Ferentino 1982/86 (Interventi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile in materia ambientale e progetti di riutilizzo terreni dismessi per impianti di elicicoltura e lombricoltura. Presidente ed Amministratore Cooperativa sociale Athena onlus Ferentino 1997/05. (interventi di natura socio assistenziale e di sviluppo occupazionale) Presidente ed amministratore Gruppo Athena SCARL 2002/05. (Interventi di promozione territoriale, supporto e logistica aziendale, progetti occupazionali e ricollocazione lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, catalizzatore finanziamenti ) Amministratore Perseo srl 2002/05 Frosinone (progettazione ricerca su nuove tecnologie, sviluppo interventi di riqualificazione ambientale,progetti e realizzazione di interventi sulle energie rinnovabili, sviluppo di software gestionali per servizi ad aziende, formazione professionale). -
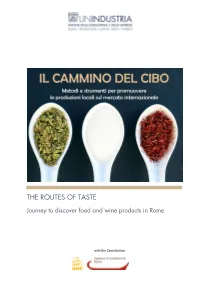
The Routes of Taste
THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution THE ROUTES OF TASTE Journey to discover food and wine products in Rome with the Contribution The routes of taste ______________________________________ The project “Il Camino del Cibo” was realized with the contribution of the Rome Chamber of Commerce A special thanks for the collaboration to: Hotel Eden Hotel Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel Hotel St. Regis Rome Hotel Hassler This guide was completed in December 2020 The routes of taste Index Introduction 7 Typical traditional food products and quality marks 9 A. Fruit and vegetables, legumes and cereals 10 B. Fish, seafood and derivatives 18 C. Meat and cold cuts 19 D. Dairy products and cheeses 27 E. Fresh pasta, pastry and bakery products 32 F. Olive oil 46 G. Animal products 48 H. Soft drinks, spirits and liqueurs 48 I. Wine 49 Selection of the best traditional food producers 59 Food itineraries and recipes 71 Food itineraries 72 Recipes 78 Glossary 84 Sources 86 with the Contribution The routes of taste The routes of taste - Introduction Introduction Strengthening the ability to promote local production abroad from a system and network point of view can constitute the backbone of a territorial marketing plan that starts from its production potential, involving all the players in the supply chain. It is therefore a question of developing an "ecosystem" made up of hospitality, services, products, experiences, a “unicum” in which the global market can express great interest, increasingly adding to the paradigms of the past the new ones made possible by digitization. -

GUADAGNOLO Il Borgo Di Guadagnolo È Una Frazione Del Comune Di Capranica Prenestina
INFORMAZIONI SU GUADAGNOLO Il borgo di Guadagnolo è una frazione del Comune di Capranica Prenestina. È il centro abitato più alto della Provincia di Roma ed è posto al limite occidentale dei monti Prenestini cHe si trovano quasi al centro del Lazio, a circa 20 cHilometri a Est di Roma. Da qui si gode una vista sublime sulle valli dell’Aniene e del Sacco, verso i monti Simbruini, Ernici e Lepini. La montagna è caratterizzata da varietà botaniche così uniche da essere inserite nella carta regionale del Lazio fra gli ecosistemi da salvaguardare. La sua storia è strettamente collegata con il Santuario della Mentorella, situato su una rupe a picco sulla valle del Giovenzano, che risale al IV sec. d.C., che è ritenuto il più antico Santuario mariano d'Italia e forse d'Europa, meta abituale di fedeli che salgono a deporre le loro preghiere ai piedi della Vergine, oltre che a S. EustacHio (un martire locale) e San Benedetto. Il villaggio si dice nato all'epoca delle incursioni barbaricHe, quando i romani, fuggiascHi, si sarebbero stanziati nei pressi di un antichissimo fortilizio, del quale restano solo i ruderi di una torre precedente il V secolo. Secondo altri il nucleo originario sarebbe stato costruito dai contadini che lavoravano le terre di appartenenza dei Monaci del Santuario, come avvenne negli antichissimi Monasteri di Cassino, di Subiaco e vari altri luoghi. Secondo lo studioso Padre Atanasio Kircher, un insigne monaco del XVII sec., il nome Guadagnolo deriverebbe dai piccoli guadagni cHe locandieri e osti ricavavano dai pellegrini cHe si recavano a visitare il Santuario. -

La Sedimentazione Di Rampa Carbonatica Dei Monti Prenestini (Miocene Inferiore, Appennino Centrale): Sedimentologia, Stratigrafi
Geologica Romana 37 (2003-2004), 79-96 LA SEDIMENTAZIONE DI RAMPA CARBONATICA DEI MONTI PRENESTINI (MIOCENE INFERIORE, APPENNINO CENTRALE): SEDIMENTOLOGIA, STRATIGRAFIA SEQUENZIALE E STRATIGRAFIA DEGLI ISOTOPI DELLO STRONZIO Mario Barbieri*°, Francesca Castorina*°, Giacomo Civitelli*°, Laura Corda*, Sergio Madonna**, Goffredo Mariotti*°, Salvatore Milli*° (*) Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma ° CNR, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Sezione di Roma “La Sapienza” (**) Dipartimento di Geologia e Ingegneria Meccanica, Naturalistica e Idraulica per il Territorio, Università degli Studi della Tuscia, Via S. Camillo de Lellis - 01100 Viterbo *° e-mail: [email protected] RIASSUNTO - La successione calcareo-marnosa e calcarea d’età Aquitaniano-Serravalliano che affiora sui Monti Prenestini (Italia centrale) è riferibile alla Formazione di Guadagnolo che, nell’area considerata, presenta spessori variabili da 30 fino a 600 metri. Sulla sua porzione mediana (Aquitaniano superiore-Burdigaliano), è stata condotta una dettagliata analisi di facies e stratigrafico-sequenziale e sono stati inoltre utilizzati 48 campioni per la misura delle variazioni del rapporto isotopico 87Sr/86Sr. Queste misure hanno consentito una più precisa definizio- ne cronostratigrafica dell’intera successione sedimentaria e allo stesso tempo hanno permesso di definire l’età delle principali superfici di discontinuità che sono state individuate al suo interno. La successione esaminata è caratterizzata da una ripetizione ciclica di unità deposizionali shallowing e coarse- ning-upward che danno luogo a corpi sedimentari di spessore da metrico a decametrico estesi lateralmente anche diversi chilometri. Queste unità sono costituite da un numero limitato di litofacies rappresentate da marne e marne calcaree spongolitiche, calcari marnosi finemente detritici e calcari bioclastici. -

Cognome Nome Paternita' Maternita' Data Nascita Luogo Nascita Mandamento Circondario Matricol Estero/Data Note Professione a Ura A
REGISTRO 1_1911 N. ARTE E LETTUR SCRITT COGNOME NOME PATERNITA' MATERNITA' DATA NASCITA LUOGO NASCITA MANDAMENTO CIRCONDARIO MATRICOL ESTERO/DATA NOTE PROFESSIONE A URA A Ciavaglia Gustavo Luigi Scrivani Giulia 17/11/1911 Giuliano Di Roma Frosinone 34457 Contadino si si Rossi Luigi Adelina 04/06/1911 Villa Santo Stefano Frosinone 34478 Contadino si si Trapani Davide Michele Cipolla Maria Enrica 09/02/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34479 Contadino si si Tranelli Giuseppe Giovanni N.N. 24/10/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34480 Contadino no no Tucciarelli Vincenzo Cataldo Paggiosi Antonia 08/08/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34481 Contadino si si Zomparelli Luigi Michele Paggiosi Abicaille 23/02/1911 Villa Santo Stefano Frosinone Frosinone 34482 Mugnaio si si Arcese Eleuterio Antonio Pelillo Maria 20/09/1911 Arce Frosinone Frosinone 34483 Muratore si si Barlecchini Giuseppe Alfredo Di Ruzza Serafina 10/06/1911 Arce Frosinone Frosinone 34484 Sarto si si Battista Gennaro Zaccaria D'aversa Maria 02/01/1911 Arce Frosinone Frosinone 34485 Contadino si si Battista Renato Domenico Pellagalli Rosa 26/06/1911 Arce Frosinone Frosinone 34486 Stagnino idraulico si si Conducente Bove Luigi Gerardo Corsetti Giovanna 19/04/1911 Arce Frosinone Frosinone 34487 autoveicoli si si Ciolfi Salvatore Luigi Germani Filomena 11/10/1911 Arce Frosinone Frosinone 34488 Motorista si si Colella Donato Giovanni Santopadre Angela 20/02/1911 Arce Frosinone Frosinone 34489 Carpentiere si si Compagnone Nicola Eleuterio Carducci Concetta -

Presentazione Idea Open Srl.Pages
! Presentation Idea Open was founded by a group of professionals who have gained over the last twenty years, knowledge and expertise, know-how and experience to support public and private institutions in the formulation, implementation and development of strategies, in the search of solid and innovative solutions, to achieve the overall purpose and objectives identified by the customer, by leading and developing coherent solutions to respond the needs and produce measurable and significant results thanks to the team of experts. Idea Open is able to guarantee a multidisciplinary approach to problem solving. By offering different forms of intervention, Idea Open provides its customers with the most appropriate solution, to meet their requirements and needs. Is able to give answers to their client in several areas, information and computer technology, communications, energy, business services, it is structured in independent divisions but have direct attention to the customer problems and needs. The company has being able to achieved remarkable results by automating their own experiences with its various divisions engaged, optimizing the available resources and giving appropriate and immediate responses to the client. Collaborates with specialized partners for the realization of complex projects that may require specific professional figures in order to achieve the objectives. Consulting The rapid development within the market of Informatics and computer Technology, if on one hand allows us to offer products always more powerful and efficient, from the other, makes more difficult the guidance for those who have to manage the informatics system. A successful solution is to turn to a company such as Idea Open capable to offer a comprehensive qualified advice and constant and prompt assistance, focused to the customer satisfaction and prevention of potential inefficiencies of the system. -

Curriculum Vitae Et Studiorum
Curriculum Vitae et Studiorum PICA ANNA RITA Nata ad Alatri (FR) il 9.9.1963 Residente in Vico nel Lazio (FR) via Fontana la Macchia, n. 50 LAUREA 26 Novembre 1986: presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha conseguito la laurea di dottore in Psicologia, indirizzo applicativo, con votazione 110/110, discutendo la tesi dal titolo: “Ansia e memoria incidentale: una ricerca sperimentale”. ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI - E’ iscritta all'albo degli Psicologi (n. 4361). - E’ iscritta all'albo degli Psicoterapeuti (n. 4362 ), art. 35 legge n. 56 del 18/02/1989 con delibera del 29/01/1995. TIROCINI - Nell’anno scolastico 1986/87 ha effettuato tirocinio volontario presso l'equipe socio-psico- pedagogica del Comune di Alatri (FR). - Dal 5 dicembre 1986 al 15 febbraio 1988 ha effettuato tirocinio volontario presso I’UTR della ex USL FR/3 Ferentino. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE - Diploma “Corso quadriennale di formazione alla Psicodiagnostica e alla Psicologia Clinica” conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il giorno 14 dicembre 1991. - Diploma corso di formazione quadriennale in “Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale”, conseguito presso l’istituto Walden di Roma il giorno 11 luglio 1993. - Diploma corso di formazione quadriennale in “Sessuologia clinica per la diagnosi, la consulenza e la terapia delle disfunzioni sessuali”, presso il Centro Italiano di Sessuologia di Roma conseguito il 19 Maggio 1996. CORSI DI FORMAZIONE - Corso a carattere teorico-pratico su “Trattamento cognitivo-comportamentale dell’handicappato grave” dal 6 al 10 aprile 1987 per un totale di 30 ore. - Corso di formazione teorica e pratica di “Psicosomatica e Psicoprofilassi ostetrica secondo il metodo R.A.T.” nel maggio 1987. -

First Sauropod Bones from Italy Offer New Insights on the Radiation of Titanosauria Between Africa and Europe
Cretaceous Research 64 (2016) 88e109 Contents lists available at ScienceDirect Cretaceous Research journal homepage: www.elsevier.com/locate/CretRes First sauropod bones from Italy offer new insights on the radiation of Titanosauria between Africa and Europe * Cristiano Dal Sasso a, , Gustavo Pierangelini b, Federico Famiani c, Andrea Cau d, e, Umberto Nicosia f a Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55, Milano 20121 Italy b 160 rue Pierre Valdo, Lyon 69005, France c Mostra Permanente di Geo-Paleontologia, Parco Regionale del Monte Subasio, Ca Piombino, Assisi 06081, Italy d Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Universita di Bologna, Via Zamboni 67, Bologna 40126, Italy e Museo Geologico e Paleontologico “Giovanni Capellini”, Via Zamboni 63, Bologna 40126, Italy f Dipartimento di Scienze della Terra, “Sapienza” Universita di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Roma 00185, Italy article info abstract Article history: Here we describe the first sauropod skeletal remains from the Italian peninsula that also represent the Received 22 November 2015 earliest record of titanosaurs in Southern Europe. Scattered bones, including an almost complete anterior Received in revised form caudal vertebra, were found in Cretaceous (AptianeAlbian) marine deposits, some 50 km East of Rome. 20 February 2016 The vertebra shows a bizarre and perhaps unique orientation of the zygapophyseal articular facets that Accepted in revised form 14 March 2016 renders their interpretation problematic. Phylogenetic retrofitting tests support the placement of the Available online 17 March 2016 Italian titanosaur among basal lithostrotians. Palaeobiogeographic analysis based on the resulting phyletic relationships suggests an Afro-Eurasian route for the ancestors of the Italian titanosaur, a sce- Keywords: Sauropoda nario compatible with the palaeogeographic evolution of the Italian microplates during the Cretaceous. -

In His Classification of Complementiser Systems in Southern Italian Dialects, Rohlfs (1969: 190) Differentiates the Varieties Spoken in the Extreme South (I.E
ON FACTIVITY: SPECULATIONS ON THE SPLIT-CP IN UPPER SOUTHERN ITALIAN DIALECTS ⁎ Valentina Colasanti ([email protected]) 1. INTRODUCTION In his classification of complementiser systems in southern Italian dialects, Rohlfs (1969: 190) differentiates the varieties spoken in the extreme South (i.e. extreme southern Italian dialects, henceforth ESIDs) from the ones spoken in the upper South (i.e. upper southern Italian dialects, henceforth USIDs). In the ESIDs, we see dual complementiser systems: ca (< Lat. QUIA; cf. 1a) and mu/ma/mi (< Lat. MODO; cf. 1b) or cu (< Lat. QUOD; cf. 1c). While ca introduces declarative complements (traditionally marked with the indicative), mu/ma/mi (Calabria and Sicilia regions) and cu (Salento) introduce irrealis complements (usually marked with the subjunctive). (1) a. pensu ca vèni1 I-think that s/he-come.3SG.IND 'I think that s/he will come' southern Calabria (Rohlfs 1969: 190) b. ògghiu mi mancia I-want that s/he-eat.3SG.SUBJ 'I want that s/he should eat' Messina (Rohlfs 1969: 190) c. tie comu faci cu lu sai? You how do that SCL you-know.2SG.IND 'How do you know that? ' Lecce (Rohlfs 1969: 190) On the other hand, the USIDs are said to exhibit only dual complementiser systems, in which ca (< Lat. QUIA; cf. 2a) introduces indicative complements in realis/declarative contexts and chə/che/chi (< Lat. QUID; cf. 2b) selects subjunctive complements in irrealis/volitive contexts (cf. Rohlfs 1969, 1983; Ledgeway 2000, 2003 inter alia). (2) a. chəsta sə nə pəntì ca i era pətutə chəllə this-one self CL repented that CL she-was asked that 'She regretted having asked her for it' b.