SAGGIO DI ONOMASTICA TEXIANA Nel Quadro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

List of Western-Themed Games
List of Western-Themed Games Key action (A) adventure (ADV) card game (C) duel (D) first-person shooter (FPS) laser disc/multimedia (LD) other (O) pinball (PB) platform (PL) puzzle (PUZ) real-time strategy/manager (RTS) role-playing game (RPG) strategy/wargame (S) target shooting/reaction (TS) Year Games 1939 Buckaroo (PB), Ride “M” Cowboy (PB) 1941 Texas Mustang (PB) 1945 Wagon Wheels (PB) 1946 Dynamite (PB) 1947 Broncho (PB), Ranger (PB) 1948 Round Up (PB) 1949 Oklahoma (PB), Tumbleweed (PB), Utah (PB) 1950 Buffalo Bill (PB), Six Shooter (TS) 1954 Stage Coach (PB) 1955 Smoke Signal (PB), Southern Belle (PB), Wild West Gallery (TS) 1957 Arrow Head (PB) 1959 Gunsmoke (TS) 1960 Pony Express (TS), Texan (PB), Wagon Train (PB) 1961 Double Barrel (PB), Indian Scout (TS), Mr. Quick Draw (TS), Mr. Top Gun (TS), Wild West (TS) 1962 Arrowhead (PB), Flipper Cowboy (PB) 1963 Bronco (PB), Texas Ranger Gatling Gun (TS) WiderScreen 1/2015: Villin lännen uudet visiot – New Visions of the Wild West 1964 Bonanza (PB), Championship Fast Draw (TS) 1965 Buckaroo (PB) 1966 Six Shooter (PB) 1967 Rifleman (TS), Wild West Rifle Gallery (TS) 1968 Civil War (S), Dogies (PB), Gun Smoke (PB), Stage Coach (PB) 1969 Lariat (PB) 1970 Bonanza (TS), Cowboy (PB), Gun Fight (D), White Lightning (TS) 1971 Gold Rush (PB), Lawman (PB) 1972 Rodeo Shooting Gallery (TS), Texas Ranger (PB) 1974 Big Indian (PB), Cowboy (A), Wild Gunman (TS) 1975 El Dorado (PB), Fast Draw (PB), Gun Fight [Western Gun] (D) 1976 Cherokee (PB), Outlaw (TS), Plinker’s Canyon (TS), Top -

Southwest Texas Science Fiction and Fantasy: Films, TV, and Literature As Popular Culture
Annual Meeting st 31 Hyatt Regency Albuquerque Albuquerque, New Mexico Texas Popular Culture and American Culture Association American Culture and Culture Texas Popular February 10-13, 2010 / www.swtxpca.org Southwest Southwest st 31 Annual Meeting of the SWTX PCA/ACA To All SWTX PCA/ACA Participants This past year the Popular/American Culture movement was saddened with the passing of Dr. Ray Browne. As the founder of the National PCA/ACA, its regional organizations, the inspiration behind the Journal of Popular Culture and the Journal of American Culture, a prolific author and advocate for Popular /American Culture scholars Ray’s influence was felt worldwide. st Join us in dedicating our 31 Annual SWTX PCA/ACA Conference in his honor. CONTENTS PROGRAM Ray Browne (1922 – 2009): Mentor to Many and Friend to All Ray Browne was a mentor to thousands of us and we celebrate his influence as we mourn. At the age of 87, he was still editing book reviews for the Journal of American Culture and, pretty much till the end of his life, making the daily trek to his office in Bowling Green State University’s Jerome Library. Ray believed that there was both a need and an opportunity to study popular culture. For someone trained in folklore (as Ray had been), this was not a radical notion, but “traditionalist” professors in English and history departments deplored such slumming. A 1969 Toledo, Ohio, meeting of the American Studies Association focusing on popular culture became the occasion for crystallizing random experiments into a new movement. With cohorts Russell Nye, Tom Towers, Marshall Fishwick, and Daniel Walden—and with indispensable help from Ms. -

Cinq Maisons D'éditions Différentes Se Sont Succédé Pour Traduire En France Les Aventures De
Rarissime affichette de kiosque 4 TEX EN FRANCE : la SAGE TEX EN FRANCE Cinq maisons d’éditions différentes se sont succédé pour traduire en France les aventures de Tex : 1 - La S.A.G.E. (Société Anonyme Générale d’Éditions) : 1948-1950 Les éditions LUG n’ont pas été les premières à traduire Tex . Le numéro 1 italien sort en septembre 1948 et le personnage apparaît dans les kiosques français dès le mois de novembre de la même année, sous le nom de Texas Boy , dans une présentation quasi-identique : même format en « bande » (17 x 8,5 cm) appelé « striscia » en Italie, même nombre de pages (32 + la couverture). Seule différence notable (à part évidemment la transformation du nom), la couverture italienne d’origine, due à Galleppini, est redessinée presque à l’identique, voire décalquée, par deux auteurs maison : Georges-Bernard Baray et un dessinateur anonyme. Par contre, la pagination diminuera à partir du numéro 10, occasionnant un léger décalage avec les numéros italiens. La maison d’édition est la Librairie Moderne, autre nom sous lequel la S.A.G.E. éditait ses publications. La collection TEXAS BOY a eu le privilège de publier les toutes premières aventures de Tex . Mais elle possède d’autres qualités : les planches n’ont subi quasiment aucune censure (la loi de juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse n’avait pas encore été votée). De plus, certains de ces récits (aventures T-3, T-4, T-7) n’ont jamais été repris en France par la suite. Deux d’entre eux notamment présentent un réel intérêt : l’aventure T-3 (El Diablo) comporte la scène où Tex intègre le corps des rangers, et T-7 (Hors-la-loi) contient la première apparition de Méphisto ! Certaines aventures ont été reprises par les éditions LUG dans leur petit format SUPPLÉMENT À PLUTOS (T-1, T-2, T-5, T-6 : voir notre chronologie) et il est instructif de comparer les deux versions : on peut découvrir l’étendue des méfaits dus aux ciseaux et à la gouache, conséquences de l’autocensure que LUG était contrainte de pratiquer sous la menace perpétuelle de la Commission de Surveillance. -
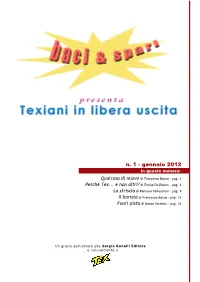
Texiani in Libera Uscita 1
n. 1 - gennaio 2012 in questo numero: Qualcosa di nuovo di Francesco Bosco – pag. 2 Perché Tex... e non altri? di Emilio De Rensis – pag. 3 La striscia di Romano Vallasciani – pag. 9 Il barista di Francesco Bosco – pag. 13 Fuori pista di Mauro Scremin – pag. 23 Un grazie particolare alla Sergio Bonelli Editore … e naturalmente a Qualcosa di nuovo di Francesco Bosco QUALCOSA DI NUOVO Cari amici, quando nel 2001 decisi di scrivere un nuovo libro su Tex, sapevo che dovevo trovare argomenti nuovi rispetto a quelli che mi avevano portato alla pubblicazione dei primi due e cioè “Tex cronologia completa” (1992) e “Tex disegni e disegnatori” (1994), testi infarciti di schede, numeri, date etc. etc. Scelsi allora la materia dalla quale mi ero sempre tenuto alla larga: la “letteratura texiana” (chiamiamola così). Pur considerandomi un tecnico passionale e romantico, ero consapevole del fatto che messo lì a scrivere cose del tipo “fenomenologia del Tex nel contesto sociale” oppure “architettura strutturale della narrazione texiana” sarei risultato fastidioso e maldestro, tenuto anche conto dell’estraneità del sottoscritto verso una certa forma espositiva squisitamente letteraria. Ma qualcosa ho pur fatto! Ho raccolto quattro volumi di materiale vario; tre dei quali, circa 80 pagine, di mostruosi incroci tra nostalgia e filosofia spicciola tirata di qua e di là. Il quarto dedicato alle cronologie, ai personaggi, agli autori etc... “Ma lascia stare”, fu il consiglio spassionato degli amici del sito (allora Baci & Spari si occupava di fumetto in generale annoverando tra le sue fila commentatori di tutto rispetto), “di Tex non c’è da spiegare nulla”. -

O Western Entre As Histórias Em Quadrinhos E As Novelas
CAMPUS BAGÉ LICENCIATURA EM LETRAS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II ÉZIO SAUCO SOCCA O WESTERN ENTRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E AS NOVELAS GRÁFICAS: A TRANSPOSIÇÃO CULTURAL DA TEMÁTICA DA CONQUISTA DO OESTE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DO PERSONAGEM TEX WILLER BAGÉ 2015 ÉZIO SAUCO SOCCA O WESTERN ENTRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E AS NOVELAS GRÁFICAS: A TRANSPOSIÇÃO CULTURAL DA TEMÁTICA DA CONQUISTA DO OESTE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DO PERSONAGEM TEX WILLER Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para a obtenção do títulode Licenciado em Letras. Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Borges de Faveri BAGÉ 2015 ÉZIO SAUCO SOCCA O WESTERN ENTRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E AS NOVELAS GRÁFICAS: A TRANSPOSIÇÃO CULTURAL DA TEMÁTICA DA CONQUISTA DO OESTE NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DO PERSONAGEM TEX WILLER Trabalho de Conclusão deCurso apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciado em Letras . Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em: 03 de fevereiro de 2015. Banca examinadora: ______________________________________________________ Prof. Dr. Rodrigo Borges de Faveri - Orientador (UNIPAMPA/ Bagé) ______________________________________________________ Profa. Dra. Kátia Vieira Morais – (UNIPAMPA/ Bagé) ______________________________________________________ Prof. Dr. Luis Fernando da Rosa Marozo - (UNIPAMPA/ Jaguarão) Para Jeniffer eternamente . AGRADECIMENTOS Ao camarada Lucas Freitas da Rosa, pela paciência enorme que teve ao trabalhar e participar das mais diversas atividades comigo. Incluindo viagens intermináveis, passeatas, assembleias, debates, discussões, manifestações, campanhas, criação de revistas e sites, brigas, gestões conflituosas e acompanhar nos momentos pessoais mais difíceis. Única pessoa que conheço capaz de falar desde alta literatura, passando por os mais diversos cineastas, quadrinistas, escritores até chegar à história da dublagem no Brasil. -

Conference Program 2008
W ESTERN L ITERATURE A SSOCIATION E XECUTIVE C OUNCIL Karen Ramirez, Co-President University of Colorado at Boulder Nicolas S. Witschi, Co-President Western Michigan University David Cremean, President-Elect Black Hills State University Gioia Woods, Vice President Northern Arizona University Ann Putnam, Past President University of Puget Sound Robert Thacker, Executive Secretary/Treasurer St. Lawrence University Anne L. Kaufman (2008) Drucilla Wall (2009) Bridgewater State College University of Missouri-St. Louis Bonney MacDonald (2008) Christine Bold (2010) West Texas A&M University University of Guelph Kyoko Matsunaga (2008) Evelyn Funda (2010) Hiroshima University Utah State University Sara Spurgeon (2008) David Peterson (2010) Texas Tech University University of Nebraska at Omaha José Aranda (2009) Judy Nolte Temple (2010) Rice University University of Arizona Michael K. Johnson (2009) Angela Waldie (2008) University of Maine – Farmington Grad. Student rep, University of Calgary Pierre Lagayette (2009) Joyce Kinkead Université Paris-Sorbonne Utah State University To nominate a WLA member for the Executive Council: Find out if your nominee is willing to serve. Write the name and affiliation of your candidate on the flipchart in the registration area. Council members must be WLA members and must attend the next three WLA meetings. All nominees are advised to attend the Business Meeting. 2008 WLA and Western Literature Week Sponsors and Partners: The Center of the American West, University of Colorado at Boulder * Department of English, -

La Filosofia Di Tex E Altri Saggi. Dal Fumetto Alla Scienza Di Giulio Giorello
numero 21 | aprile-dicembre 2020 Luisa Bertolini La filosofia di Tex e altri saggi. Dal fumetto alla scienza di Giulio Giorello Prefazione di Roberto Festi, Postfazione di Gianfranco Manfredi Milano – Udine, Mimesis, 2020 Ai filosofi, agli studiosi di filosofia, piacciono i fumetti: le scritte nelle nuvolette, lo spazio bianco, l’ingrandimento a sorpresa di un particolare, che costringono lo sguardo a rimbalzare tra lettere e immagini, i personaggi che sfuggono al suo primo autore e diventano autonomi, le storie rinnovate da altri e disegnate da una schiera di diversi illustratori che impongono di riconoscere il personaggio originario, la presenza di elementi magici che si intrecciano al rea- lismo della storia, attraggono la loro attenzione. Talvolta li deludono, ma più spesso li affa- scinano. Giulio Giorello era uno di questi e questo libro, pubblicato nella collana “Il caffè dei filosofi” della casa editrice Mimesis, è un omaggio al professore che da poco è venuto a mancare. Successore di Ludovico Geymonat sulla cattedra di Filosofia della scienza all’Uni- versità Statale di Milano, Giorello ha continuato l’attività del maestro, che aveva introdotto nella filosofia italiana, in forte polemica con la tradizione crociana, i temi della scienza, con la riflessione sulla relatività e sulla fisica quantistica, spostando l’analisi dal materialismo dia- lettico alla linea Carnap-Popper-Feyerabend e mettendo in rilievo, nella storia del pensiero politico, la corrente liberale e libertaria. La prima parte del libro è dedicata a Tex con cinque saggi (alcuni già pubblicati) che cercano di enucleare il modo di pensare e di agire del personaggio; la raccolta non è però conclusa: Giorello stava lavorando a un altro testo che avrebbe dovuto analizzare il fumetto La valle della luna del 1962, scritto da Gianluigi Bonelli e illustrato da Aurelio Galleppini, sostituito dall’editore con alcuni saggi di storia e filosofia della scienza, che hanno un rapporto un po’ esile con la trattazione precedente. -

Il Gazzettino December 2016
Il Gazzettino December 2016 Message from the Board We hope you had a wonderful Thanksgiving. We are grateful to have so many active members in our club, and we look forward to celebrating with each of you at our upcoming Christmas Party! Abbracci, Friends of Italy Society of Hawaii Board [email protected] In this issue: Upcoming Events 1 Message from the Board Christmas Party We are delighted to invite all of 1 Upcoming Events you to join us for our Friends of Christmas Party Italy Society of Hawaii Annual 3 Past Events Christmas Party! Pasta Making Party Where: Cafe Julia at YWCA 4 Feature Story Laniakea in downtown Honolulu The Myth of the (Italian) West (across from Iolani Palace) 8 Announcements When: Sunday, December 18, Book Presentation: Storie 5:30-9:30pm Straordinarie di Italiani nel Pacifico (continued on next page) Christmas Party (continued) What: We’ll enjoy music from Na Hoku Hanohano Award winning artist Pierre Grill as well as a visit from Babbo Natale. Attendees can also look forward to a silent auction featuring items from local businesses as well as member donations. Tickets: We are offering a discount for those who register early, so get your tickets today! Early registration (before December 1st): $45 After December 1st: $50 Children under 12: free of charge Parking: Street parking is available along South King Street in front of Iolani Palace. Ali`i Place offers municipal parking for $3. Entrance to Ali`i Place parking is on Alakea Street, just past the Mandalay Restaurant on the right hand side. -

TEX WILLER Quegli Anni Nel Far West
Happyend ANNIVERSARIO Con il titolo “Il Totem misterioso” Tex arriva in edicola il 30 settembre 1948 nel formato striscia. Tex first adventure was “The Mysterious Totem” and landed in the newsstands on September 30 1948 in the typical horizontal comic strip. TEXWILLER Quegli anni nel Far West Il fumetto italiano più famoso al mondo compie 70 anni. Storie e suggestioni sempre in bilico tra letteratura e cinema SERGIO BONELLI EDITORE 2018 EDITORE BONELLI SERGIO di Filippo Nassetti 124 _ ULISSE _ luglio 2018 ULISSE _ luglio 2018 _ 125 PENNA E CAPPELLO Giovanni Luigi Bonelli nel suo studio in Via Mac Mahon. Il padre di Tex Happyend si è sempre definito “romanziere prestato al fumetto e mai più restituito”. Giovanni Luigi Bonelli in his studio in Via Mac Mahon. Tex’s creator has always defined himself as “a novelist lent to comics but then never made it back.” er i Navajos non si chiama Tex, ma “Aquila della notte”. Nome scelto dopo averlo visto celarsi il volto prima di affrontare il re- sponsabile del rapimento dell’amata Lilyth, la sua sposa indiana. Quando settant’anni fa Tex approda in edicola segna una scelta di campo non convenzionale. In un’epoca caratterizzata dai we- stern stile Ombre rosse, che tendevano a descrivere i nativi d’A- P merica come selvaggi in cerca dello scalpo dei “visi pallidi”, non era comune prendere le difese dei “pellerossa”. Una scelta anticipatrice di vent’anni di pellicole risarcitorie come Piccolo grande uomo e Soldato blu. Sì, perché Tex Willer è un irregolare, un ranger, difensore degli indiani e re- sponsabile della riserva Navajo per conto del governo degli Stati Uniti. -

The American West and the World
THE AMERICAN WEST AND THE WORLD The American West and the World provides a synthetic introduction to the trans- national history of the American West. Drawing from the insights of recent scholarship, Janne Lahti recenters the history of the U.S. West in the global contexts of empires and settler colonialism, discussing exploration, expansion, migration, violence, intimacies, and ideas. Lahti examines established subfields of Western scholarship, such as borderlands studies and transnational histories of empire, as well as relatively unexplored connections between the West and geographically nonadjacent spaces. Lucid and incisive, The American West and the World firmly situates the historical West in its proper global context. Janne Lahti is Adjunct Professor of History at the University of Helsinki and the editor of American Studies in Scandinavia. THE AMERICAN WEST AND THE WORLD Transnational and Comparative Perspectives Janne Lahti NEW YORK AND LONDON First published 2019 by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017 and by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2019 Taylor & Francis The right of Janne Lahti to be identified as author of this work has been asserted by him in accordance with sections 77 and 78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. -

FUMETTI E CAVALLI © Sergio Bonelli Editore/Disegno Di Roberto De Angelis
FUMETTI E CAVALLI © Sergio Bonelli Editore/Disegno di Roberto de Angelis. Colori GfB Comics 54 - CAVALLO MAGAZINE MAGGIO TEX L’EPOPEA DEL WEST Possente e leale, intelligente e fiero. E naturalmente bellissimo, come tutti gli eroi. Un viaggio nella storia dei cavalli nei fumetti fa tappa obbligata tra le pagine di Tex Willer, per raccontare le prodezze di Dinamite, il destriero del pistolero più amato dagli italiani di Silvia Allegri Foto Sergio Bonelli Editore © Sergio Bonelli Editore/ Disegno di Roberto de Angelis. ono passati 72 anni, ma Tex Colori GfB Comics e Dinamite non sentono il peso degli anni, anzi. Nuo- vi lettori si sono aggiunti a quelli storici, e il fumetto Spiù longevo d’Italia entra nelle case e, tra sparatorie e lunghe galoppate, passa di mano in mano, dai nonni ai nipoti e viceversa. È Mauro Boselli, oggi, il cura- tore e sceneggiatore di Tex Willer, perso- naggio ideato da Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini, edito dalla Sergio Bonelli Editore a raccontarci la storia di questo fumetto, ripercorrendone le tap- pe e curiosando alla ricerca di uno dei cavalli più famosi di sempre, è oggi An- tonio Serra, redattore della Sergio Bo- nelli Editore, assistente di redazione di Tex insieme a Giorgio Giusfredi. E così si torna indietro negli anni, per scoprire come è nato il sodalizio tra Dinamite e Tex, che ha fatto appassionare milioni di lettori. «Gianluigi Bonelli era un ge- nio», afferma senza esitazione Antonio Serra, e dalla sua voce trapela la grande simpatia per il cowboy e il suo insepara- bile cavallo. «Nel 1948 ha inventato un western dove gli indiani sono buoni, il protagonista difende le differenze etni- CAVALLO MAGAZINE MAGGIO - 55 FUMETTI E CAVALLI che e sociali, cavallo e cavaliere sono alla pari. -

The American West and the World
THE AMERICAN WEST AND THE WORLD The American West and the World provides a synthetic introduction to the trans- national history of the American West. Drawing from the insights of recent scholarship, Janne Lahti recenters the history of the U.S. West in the global contexts of empires and settler colonialism, discussing exploration, expansion, migration, violence, intimacies, and ideas. Lahti examines established subfields of Western scholarship, such as borderlands studies and transnational histories of empire, as well as relatively unexplored connections between the West and geographically nonadjacent spaces. Lucid and incisive, The American West and the World firmly situates the historical West in its proper global context. Janne Lahti is Adjunct Professor of History at the University of Helsinki and the editor of American Studies in Scandinavia. THE AMERICAN WEST AND THE WORLD Transnational and Comparative Perspectives Janne Lahti NEW YORK AND LONDON First published 2019 by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017 and by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2019 Taylor & Francis The right of Janne Lahti to be identified as author of this work has been asserted by him in accordance with sections 77 and 78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.