L'area Cimiteriale Al Dossello Di Offanengo':'
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
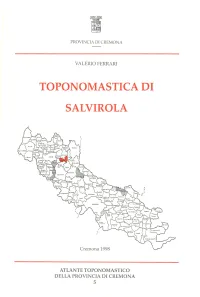
Toponomastica Di Salvirola
PROVINCIA DI CREMONA VALERIO FERRARI TOPONOMASTICA DI SALVIROLA Cremona 1998 ATLANTE TOPONOMASTICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA Ai mieigenitori Eva e Amilcare, con affetto. ATLANTE TOPONOMASTICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA 5 VALERIO FERRARI TOPONOMASTICA DI SALVIROLA Cremona 1998 Presentazione Con questo quinto volume dell'Atlante toponomastico della Provincia di Cre mona prosegue lapubblicazione delle raccolte toponimiche relative ai comunidel ter ritorio provinciale: raccolte attuate nella maggior parte dei casi - vale la pena di ri cordarlo - grazie all'irrinunciabile contributo delle scuole elementari e medie supe riori locali, guidate da un corpo insegnante sempre più sensibile e attento ad unate matica tanto peculiare e stimolante, ma talora condotte a termine anche dagruppi spontanei di ricerca ovvero da singoli studiosi, come nelcaso di Salvirola. Eancora una volta appare evidente l'importante contributo che l'esame delpa trimonio toponomastico di un territorio, quantunque di piccole dimensioni, può of frireall'interpretazione delle sueparticolari vicende geografiche, economiche, sociali, religiose, analizzate in prospettiva storica. Si viene producendo, così, unostrumento di lavoro in più, che va ad aggiungersi al mosaico delle notizie locali, insostituibile riferimento perla conoscenza della storia dell'uomo. Pertanto il prodotto finale, oltre a costituire un'occasione didattica volta alla conoscenza delterritorio, riesce agettare nuova luce sulla suaevoluzione temporale, attraverso l'approfondimento dell'aspetto semantico, il -

37018 Denominazione Dell'impianto: MADIGNANO
Piano di ispezione mensile degli impianti (rif. Art.12 - comma 12.1 - lettera e) delibera AEEGSI n.574/13) Anno: 2019 Mese: SETTEMBRE Codice univoco dell'impianto: 37018 Denominazione dell'impianto: MADIGNANO Via Comune Rete/Allaccio AP/MP BP VIA ORIOLO CASTELLEONE Rete X S.P. N. 20 FIESCO Rete X S.P. N. 25 FIESCO Rete X X VIA A. MANZONI FIESCO Rete X VIA A. VESPUCCI FIESCO Rete X VIA AGNESI FIESCO Rete X VIA APORTI FIESCO Rete X VIA BREDE FIESCO Rete X VIA C. BATTISTI FIESCO Rete X VIA C. COLOMBO FIESCO Rete X VIA CANOVA FIESCO Rete X VIA CAPPONI FIESCO Rete X VIA D. ALIGHIERI FIESCO Rete X VIA DELLA VITTORIA FIESCO Rete X VIA DELLE ARTI FIESCO Rete X X VIA F. APORTI FIESCO Rete X VIA F. MAGELLANO FIESCO Rete X VIA G. CARDUCCI FIESCO Rete X VIA G. GALILEI FIESCO Rete X VIA G. LEOPARDI FIESCO Rete X VIA G. PARINI FIESCO Rete X VIA G. VERDI FIESCO Rete X VIA GENALA FIESCO Rete X VIA GIARDINI FIESCO Rete X VIA L. DA VINCI FIESCO Rete X VIA MATTEO NOLI FIESCO Rete X VIA R. SANZIO FIESCO Rete X VIA ROMA FIESCO Rete X VIA S. PELLICO FIESCO Rete X ZONA IND. GEROLA FIESCO Rete X PIAZZA G. MARCONI IZANO Rete X PIAZZALE GIOVANNI XXIII IZANO Rete X S.P. N. 16 IZANO-MADIGNANO IZANO Rete X X S.P. N. 24 IZANO Rete X SP 23 IZANO Rete X SP 23 - VIA CREMA IZANO Rete X X SP 23 - VIA ROMA IZANO Rete X SP 23 - VIALE PALLAVICINA IZANO Rete X STR COMUNALE DELLA CA' DEL FACCO IZANO Rete X VIA A. -

NAPOLEON AS a GENERAL Gbe Woleele? Series
oO% s$t?- NAPOLEON AS A GENERAL Gbe Woleele? Series The following works are now ready. 1. WITH THE ROYAL HEADQUARTERS. By General Verdy du Vernois. 2. LETTERS ON STRATEGY. By Prince Hohenlohe-Ingelfingen. 3. INDIAN FRONTIER WARFARE. By Major Younghusband, of the "Guides." 4. THE CONDUCT OF WAR. By Lieut. -General von der Goltz. 5. CROMWELL AS A SOLDIER. By Major Baldock, R.A. 6. OPERATIONS OF GENERAL GURKO'S AD- VANCE GUARD IN 1877. By Colonel Epauchin, of the Russian Staff. 7. NAPOLEON AS A GENERAL. By Count Yorck von Wartenburg. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. New York : Charles Scribner's Sons. NAPOLEON AS A GENERAL BY THE LATE ™* YORCK von WARTENBURG fUx^l fcOUNTj , COLONEL OF THE GENERAL STAFF OF THE PRUSSIAN ARMY (^~ VOL JL^ FORMING THE SEVENTH BOOK Ube Molselep Series EDITED BY Major WALTER H. JAMES 'Oii^l VOL. I. LONDON KEGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & CO. Ltd. Paternoster House, Charing Cross Road 1902 LONDON : printed by gilbert and kivington, ltd., st. John's house, clerkenwell, e.c. Gibraltar, April 19th, 1897. Dear Captain James, I have read with interest the list you have sent me of the military works to be published as "The Wolseley Series." The subjects are wisely chosen, and the authors will be generally accepted as soldiers who are competent to express valuable opinions upon them. I am much flattered by having my name associated with an undertaking that is designed to improve the professional knowledge of our officers, and I rejoice to feel that under your able editorship its success is assured. -

1 Comune Di Bagnolo Cremasco Patrimonio Storico, BIBLIOTECARI NELLE BAGNOLO ANCI LOMBARDIA 162640 Artistico E Culturale PROVINCE DI CREMONA E CREMASCO MANTOVA
N Codice N° Ente di riferimento Area Progetto Ente Comune sede posti 1. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Bagnolo Cremasco Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE BAGNOLO ANCI LOMBARDIA 162640 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E CREMASCO MANTOVA 2. PASSO DOPO PASSO: un 1 Comune di Capralba progetto a sostegno dei ASSOCIAZIONE Assistenza CAPRALBA 156690 minori in condizioni di MOSAICO disagio 3. ASSOCIAZIONE 1 Centro Primavera Assistenza 2020 #ABILITA' DIFFERENTI COMUNITA' PAPA CAMISANO 172377 GIOVANNI XXIII 4. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Casaletto Ceredano Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE CASALETTO ANCI LOMBARDIA 163233 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E CEREDANO MANTOVA 5. Educazione e 1 Comune di Castelleone promozione culturale, OLTRE I BANCHI DI paesaggistica, SCUOLA: VOLONTARI NEI ANCI LOMBARDIA CASTELLEONE 163407 ambientale, del SERVIZI EDUCATIVI turismo sostenibile e sociale e dello sport 6. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Castelleone Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE ANCI LOMBARDIA CASTELLEONE 163408 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA 7. Assistenza Area della Pianura A.N.P.AS. - CREMA 147745 6 Croce Verde Crema ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 8. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 2 Comune di Crema Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE ANCI LOMBARDIA CREMA 163872 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA 9. InSieMe: la persona con 2 Aism Crema sclerosi multipla AISM ASSOCIAZIONE protagonista del proprio Assistenza ITALIANA SCLEROSI CREMA 197209 futuro. Partecipazione, MULTIPLA ONLUS empowerment e reciprocità della relazione ASSOCIAZIONE 2 10. DIRITTI E NAZIONALE ARCI Assistenza CONSAPEVOLEZZA PER CREMA 140762 SERVIZIO CIVILE ASC Auser Crema L'INCLUSIONE SOCIALE APS Patrimonio storico, 2 Comune di Crema 11. -

Negoziacasatua
#NEGOZIACASATUA COMUNE ATTIVITÁ TIPOLOGIA NOMINATIVO RECAPITO ORARI DI PRENOTAZIONE e LUOGHI DI CONSEGNA Crema Alimentari Frutta e verdura DANIELA KERVISCHER (banco mercato di 3396335707 Tutti i giorni 8.30- 12.00. Crema) Crema e raggio 10 km Crema Alimentari Frutta e verdura CANCELLI (banco alimentare) 030 711942 / Tutti i giorni( prenotazione con 3356126302 / 48 h di anticipo). 3356120896 Crema e raggio 10 km Crema Alimentari Frutta e verdura CROTTI GIANLUCA (banco mercato di 3496712744 Tutti i giorni 8.30- 12.00. Crema) 3388548208 Solo Crema Crema Alimentari Macelleria e Salumeria BOUTIQUE DELLE CARNI (Cornalba) 0373 257615 Per ritiro in loco 8-12.30. Consegna a domicilio dalle 12.30 in poi. Solo Crema. Crema Alimentari Drogheria CAMELIA DROGHERIA 0373 86112 / 0373 Consegna ad orari da 228852 concordare di specialità www.cameliashop.it alimentari dolci, salate, prodotti per la colazione e dolci pasquali. Solo Crema Trescore Alimentari Caseificio /azienda agricola CARIONI Food&Health 3884498562 Consegna ad orari da Cremasco concordare di prodotti alimentari biologici. Trescore CR e raggio 15 km. Crema Alimentari Pane/prodotti da forno DOLCI TENTAZIONI (c/o Conad) 3453814235 Consegna ad orari da concordare di pasticceria fresca Prenotazioni per agnelli di pasta sfoglia e colombe pasquali: Solo Crema. #NEGOZIACASATUA Grumello Alimentari Bevande BBQ BEVERAGE 3475463186 Consegna ad orari da Cremonese concordare di acqua, bibite e altre bevande in genere. Tutta la provincia. Crema Alimentari Gelato GGLACE 3384986405 Consegna dalle 10 alle 20. Solo Crema Crema Pranzo/Cena Asporto /hamburger BURGER'S HOUSE 3737763436 Consegna 12-14/19-21 No a domicilio martedì cena/domenica pranzo. Crema, Offanengo, Ripalta Cremasca Crema Servizi Medicinali a casa AUTONOLEGGIO VIGANI 3485241823 Consegna/ritiro medicinali c/o farmacie, a titolo gratuito - Accompagnamento dimessi. -

Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N° 19 Del 17/10/2019
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA Via Morbasco, 3 - 26100 CREMONA Tel. 0372 27590 - Fax 0372 23943 - e-mail: [email protected] ORARIO APERTURA Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì 09:00-12:00/14:00-18:00 Giovedì – CHIUSO e-mail: [email protected] Stagione Sportiva 2019/2020 Comunicato Ufficiale N° 19 del 17/10/2019 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. 3 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D. 3 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 3 3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 3 3.2 SEGRETERIA 3 3.2.1 ESITO SORTEGGIO COPPA LOMBARDIA DI TERZA CATEGORIA 3 3.2.2 ESITO SORTEGGIO COPPA LOMBARDIA JUNIORES REGIONALE UNDER 19 B 5 3.2.3 ADDEBITI SOCIETA’ PER MANCATA ISCRIZIONE SQUADRA GIOVANILE (CFR. COM. N.1 DELL’01/07/2019 DELLA L.N.D. 6 3.2.4 VADEMECUM COMPETENZE PRATICHE DI TESSERAMENTO 7 3.2.5 ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE 8 4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L. 9 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D. 9 4.1.1 SVINCOLI PER INATTIVITA’ - ACCORDO 9 4.2 ATTIVITÀ DI BASE (S.G.S.) 10 4.2.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 10 4.2.2 INCONTRI INFORMATIVI SCUOLE CALCIO ÉLITE 10 4.2.3 CANDIDATURA TUTOR 10 5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 11 1 / 19 5.1 NOTIZIE ATTIVITA’ DILETTANTISTICA 11 5.1.1 CORSO ARBITRI – A.I.A. -

Appena Dopo La Seconda Metà Di Quel Secolo L'intera Zona Compresa Tra L
Appena dopo la seconda metà di quel secolo l'intera zona compresa tra l'Adda e l'Oglio vedeva il compiersi di spettacolari avvenimenti dal punto di vista politico e militare, i più significativi dei quali si svolsero proprio nell'alto Cremonese. Ci si riferisce alla distruzione di Castel Manfredi sulle cui rovine sorgerà poco dopo Castelleone, e di Crema, il cui assedio durò parecchi mesi e costò ai Cremaschi un alto prezzo di sangue, prima della resa definitiva all'esercito di Federico Barbarossa. Dopo quei tempi non si parlò più di importanti centri quali la "terra de Arie" nella quale Omodeo Penna e la moglie avevano parte dei loro beni. Scomparve anche il centro di Mastalegno, che si trovava nei pressi di Romanengo. La scarsità di documenti non ci permette di conoscere la funzione svolta dal piccolo centro di Fiesco in quella generale confusione, aggravata di lì a poco dal nascere delle fazioni politiche che si erano aggregate nei due partiti che andavano sotto i nomi di guelfi e ghibellini, e complicata dalle continue guerre tra città vicine. Milano soprattutto, alleata di Crema fu per molto tempo ancora in continua belligeranza con Cremona per il predominio sul territorio che principalmente interessa, e Fiesco si trovava proprio sulla linea di confine che separava le due città nemiche. Durante gli anni che vanno dal 1188 al 1228 queste campagne furono attraversate da continue guerre; memorabile fu la battaglia delle Bodesine combattuta vicino a Castelleone nel 1213 fra i Cremonesi e i Milanesi alleati dei Cremaschi. La più grave incursione attuata da questi ultimi avvenne però nell' Ottobre del 1228 quando essi entrarono nel Cremonese dai dossi del Vaer, località situata nella corte di Bressanoro e dilagarono nei territori di Fiesco, Salvirola, Trigolo e Soresina con la chiara intenzione di isolare Castelleone, che avrebbe subito dopo attaccato per devastarlo. -

Forme Di Aggregazione Dei SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Forme di aggregazione dei SERVIZI DI POLIZIA LOCALE LEGENDA AIPA SPA Con chi è aggregato AIPA SPA_Provincia di Cremona_Vaiano Cremasco_Monte Cremasco_Bagnolo Cremasco_Cheve_SCS Gestioni SRL_SICUREZZA e AMBIENTE SPA Altro Associazioni_Altro Forze dell'ordine competenti per territorio Associazione ANAI di San Bassano Comune di Sesto ed Uniti_Associazione il Nibbio Comune di Brescia_Comune di Seniga Comune di Sospiro_Comune di San Daniele Po Comune di Camisano_Comune di Offanengo Comune di Spino d'Adda CASTEL GABBIANO Comune di Camisano_Lo Sparviere di Protezione Civile Duomo GPA SRL RIVOLTA D`ADDA Comune di Casalbuttano Lo Sparviere di Protezione Civile VAILATE Comune di Cremona Pizzighettone CAMISANO AGNADELLO 2 CASALE CREMASCO - VIDOLASCO Comune di Monte Cremasco Unione dei Comuni Lombarda Municipia_Comune di Torre de' Picenardi CAPRALBA PIERANICA SERGNANO Comune di Montodine TORLINO VIMERCATI Unione dei comuni del Gerundo QUINTANO Comune di Offanengo Unione dei comuni del soresinese 1 CASALETTO DI SOPRA PANDINO CASALETTO VAPRIO RICENGO SONCINO Comune di Ostiano Unione dei comuni del soresinese_Unione dei comuni del Gerundo PIANENGO PALAZZO PIGNANOTRESCORE CREMASCOCAMPAGNOLA CREMASCA Comune di Ostiano_Comune di Torre de' Picenardi Unione dei comuni di Calvatone e Tornata_Comune di Piadena SPINO D`ADDA 4 OFFANENGO Comune di Palazzo Pignano CREMOSANO ROMANENGO Unione dei comuni lombarda Foedus Comune di Pieranica_Comune di Sergnano MONTE CREMASCOVAIANO CREMASCO TICENGO Unione dei comuni lombarda Municipia CREMA Comune di Pizzighettone_ARPA -
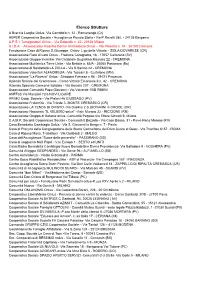
Elenco Strutture a Braccia Larghe Onlus- Via Carrobbio N
Elenco Strutture A Braccia Larghe Onlus- Via Carrobbio n. 12 - Romanengo (Cr) AEPER Cooperativa Sociale - Accoglienza Piccola Stella - Via P.Rovelli 28/L - 24125 Bergamo A.P.S. I Tetragonatuti Onlus – Via Doberdò n. 22– 20126 Milano A.I.D.A. - Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus – Via Palestro n. 34 - 26100 Cremona Fondazione Casa di Riposo S.Giuseppe Onlus- L.go della Vittoria - ISOLA DOVARESE (CR) Associazione Fiore di Loto Onlus - Frazione Caragnetta, 18 - 17057 Calizzano (SV) Associazione Gruppo Incontro- Via Cardinale Guglielmo Massaia 22 - CREMONA Associazione Mutlietnica Terre Unite - Via Bettole n. 65/A - 25050 Pasisrano (Bs) Associazione di Solidarietà LA ZOLLA - Via S.Savino 42 - CREMONA Associazione Volontari ALFAOMEGA - Via Toscani 8 - Curtatone (MN) Associazione "La Ricerca" Onlus - Stradone Farnese n.96 - 29121 Piacenza Azienda Sociale del Cremonese - Corso Vittorio Emanuele II n. 42 - CREMONA Azienda Speciale Cremona Solidale - Via Brescia 207 - CREMONA Associazione Comunità Papa Giovanni - Via Valverde 10/B RIMINI ANFFaS Via Manzoni 72/a NOVI LIGURE ARIMO Coop. Sociale - Via Platani 46 GIUSSAGO (PV) Associazione Fraternità - Via Trieste 3 -MONTE CREMASCO (CR) Associazione LA TENDA DI CRISTO -Via Oseline 2 S.GIOVANNI in CROCE (CR) Associazione Nazionale "IL VELIERO onlus" -Viale Murano 22 - RICCIONE (RN) Associazione Gruppo di Betania onlus -Comunità Pegaso-Via Ettore Ciccotti 9- Milano C.A.M.P. Società Cooperativa Sociale - Comunità Il Bozzolo - Via Case Basse, 31 - Pieve Porto Morone (PV) Casa Benedetta Cambiagio Onlus - Via S. Giovanni in Borgo n. 7 - Pavia Casa di Procura della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù - Via Trionfale 6157 - ROMA Casa di Riposo Mons. -

Comune Di Credera Rubbiano (CR)
CCaarrttaa ddeell sseerrvviizziioo ggaass Comune di Credera Rubbiano (CR) N.B.=Le parti con sfondo grigio sono migliorative rispetto a quanto richiesto della Delibera AEEG 120/08 Rev. 07 del 30/06/2013 - (conforme alle Delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in vigore) Organizzazione con sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.358 G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. Sede legale e ufficio rapporti con gli Utenti Via S.Chiara, 9 - 26013 CREMA (CR) Tel. 0373 893513 (5 linee r.a.) - Fax 0373 86931 COMUNI SERVITI: vedi allegato 1 EMERGENZA GAS: vedi allegato 2 Indice 1. Cos’è la Carta del Servizio gas ……………………………..4 2. Principi fondamentali del sistema ……………………………..5 3. Qualità del servizio ……………………………..6 3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’Utente ……………………………..6 3.2 Accessibilità al servizio ……………………………..12 3.3 Gestione del rapporto con l’Utente ……………………………..16 3.4 Sicurezza del servizio ……………………………..19 4. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a ……………………………..22 livelli specifici e generali di qualità 5. Informazioni e consulenza all’Utente ……………………………..22 6. Tutela degli Utenti ……………………………..22 7. Valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti ……………………………..22 8. Servizi post contatore-assicurazione ……………………………..23 9. Rimborso forfetario per il mancato rispetto degli standard ……………………………..24 Il vocabolario del gas ……………………………..26 Norme per l’uso del gas naturale ……………………………..27 Allegato 1: comuni serviti ……………………………..28 Allegato 2: emergenza gas ……………………………..31 Carta del servizio del Comune di Credera Rubbiano (CR) Rev. 07 del 30/06/2013 - (conforme alle Delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in vigore) 3 1. -
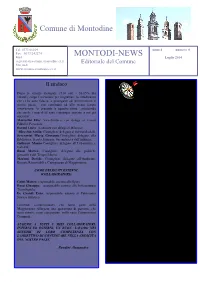
Comune Di Gombito
Comune di Montodine Tel. 0373 66104 Anno 4 numero 0 Fax 0373/242274 MONTODI-NEWS Mail Luglio 2014 [email protected] Editoriale del Comune Sito web: www.comune.montodine.cr.it Il sindaco Dopo la vittoria elettorale, (914 voti - 56.65% dei votanti), colgo l’occasione per ringraziare la cittadinanza MISSIONE COMPIUTA… che ci ha dato fiducia, a proseguire ad Amministrare il nostro paese, con continuità ed allo stesso tempo - Grande successo del centro ricreativo estivo “UN’ESTATE innovazione. Vi presento la squadra eletta, precisando PER GIOCARE” iniziato il 14 luglio con 48 iscritti, si è che anche i non eletti sono comunque insieme a noi già raggiunto il numero di 59 iscrizioni. Venerdì 25 u.s. si è tenuta operativi: la gita al Castello di Gropparello (PC) a cui hanno partecipato Marcarini Elio: Vice-Sindaco, con delega ai Lavori 37 bambini e 5 tra educatori e adulti accompagnatori. Pubblici,Personale; “Un’estate per giocare” termina il 1 agosto con una festa finale Baroni Lucia: Assessore con delega al Bilancio; in piazza dove i bambini si esibiranno in piccoli sketch. Allocchio Attilia: Consigliere delegato ai Servizi Sociali; Responsabile del Centro Estivo Samanni Lorenzo coadiuvato Severgnini Maria Giovanna:Consigliere delegato alla dai ragazzi che prestano il Servizio Civile al Comune di Biblioteca, Scuola Primaria, Secondaria e dell’infanzia; Montodine Bianchi Andrea e Ferrari Davide. Gallinari Mauro:Consigliere delegato all’Urbanistica e Il Progetto è stato organizzato dal settore Biblioteca. viabilità; Bussi Matteo: Consigliere delegato alle politiche - Obiettivo raggiunto con gli “Orti Sociali”, il progetto parte giovanili e del Tempo Libero; dal bisogno di integrazione sociale delle persone con disabilità. -

Curriculum Vitae Arrigoni
Curriculum Vitae Informazioni personali Nome(i) / Cognome(i) Pian. Roberta Arrigoni - libero professionista Indirizzo(i) Via Re Desiderio n° 2D 25024 LENO –BS- Telefono(i) 377 4166247 Fax E-mail [email protected], PEC: [email protected] Cittadinanza italiana Data di nascita 22.09.1980 eventuale iscrizione ad albi/ordini professionali e/o abilitazioni alle professioni in materie giuridiche ed economiche Ordine - Albo Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona con il numero 773 nel 2010 Istruzione e formazione titolo di studio Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento dell’esame di stato presso il politecnico di Milano nella sessione invernale dell’anno 2006. Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale, presso il Politecnico di Milano il 19 Aprile 2005 (equipollente alla laurea in ingegneria civile ed architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, come da decreto Interministeriale dell'11 maggio 2000), discutendo una tesi su un progetto di riqualificazione della fascia costiera di Rimini e Riccione in vista dell’introduzione del sistema di Trasporto Rapido Costiero (metropolitana leggera di collegamento). Diploma di disegnatrice CAD per aver conseguito un corso stanziato dalla Banca Popolare di Crema Maturità artistica, conseguita nell’anno accademico 1998/1999, presso il Liceo Artistico “Leonardo Da Vinci” di Crema. Principali tematiche/competenze Progettazione sia in ambito architettonico che urbanistico e studi di valutazione ambientale e del professionali possedute paesaggio Nome e tipo d'organizzazione Politecnico di Milano erogatrice dell'istruzione e formazione Pagina 1/7 - Curriculum vitae di Arrigoni Roberta - Corso di formazione su procedure VIA ed AIA tenute dall’ARPA di Cremona Diploma di Corsi, conferenze sostenuti e workshop disegnatrice CAD per aver conseguito un corso stanziato dalla Banca Popolare di Crema conseguiti - Diploma di disegnatrice 3D REVIT per aver conseguito un corso presso la sede di Rho della Autodesk - Corso di software 3d Blender Cremona.