Ulivo 2009 1 .Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Elettorato Attivo 16 17
ELETTORATO ATTIVO Cognome Nome Corso di studi ADAMO ELISA LINGUE E CULTURE DELL'EURASIA E DEL MEDITERRANEO ABAKAH RITA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABATE MARCO CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBAD SOUMIA ECONOMIA E COMMERCIO ABBATE ISABELLA LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI ABBATE LAURA LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI ABBATE ALESSANDRA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBIENDI MATTEO GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE ABBONIZIO JACOPO CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI ABBRUSCATO JACOPO Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABBRUZZESE SOFIA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDALLA NELLY LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABDEL RAHMAN IMAN Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDELHAMID MOHAMED NADIA SCIENZE DEL LINGUAGGIO ABDELKERIM SARA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABEBE SEYUM ASSEFA INFORMATICA - COMPUTER SCIENCE ABICCA STELLA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABINANTI SUSHMA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABOAF FEDERICO ITALIANISTICA ABOU EL SEOUD HENI LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABRAM FRANCA MARIA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABRAM JACOPO ECONOMIA AZIENDALE ACAMPORA LUIGI Informatica ACAMPORA NAOMI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ACCARDI GRETA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ACCARDI VIRGINIA Lingue, civiltà -

In This Book I Have Not Attempted to Write the Conventional Biography Of
Introduction In this book I have not attempted to write the conventional biography of a canonized saint, but a study of Italian history centered in the work and personality of one of the most wonderful women that ever lived. While devoting my attention mainly to Catherine’s own work and influence upon the politics of her age, I have endeavored at the same time to make my book a picture of certain aspects, religious and political, of the fourteenth century in Italy. In this undertaking, I have been aided greatly by the manuscripts still preserved of Catherine’s letters, manuscripts full of unpublished matter that has been unaccountably neglected, having apparently escaped the notice of all of her previous biographers and editors. This material throws light upon every aspect of the saint’s genius and has enabled me, at many points, to correct erroneously accepted ideas about the events of her life and the order of her writings. From the very beginning, the biographical and historical value of Catherine’s letters has been, to a considerable extent, impaired by copyists (and editors who followed them) omit- ting or suppressing passages that appeared to them to be of only temporary interest, or not tending immediately toward edification. A certain number appear to have been deliberately expurgated, in cases where the writer’s burning words seemed likely to startle the susceptibilities of the faithful. This process seems to date back to the generation that immediately followed that of Catherine’s original disciples. A striking instance of this editorial suppression is seen in a certain letter that Aldo Manuzio (the editor of the second 3 RoadtoSienaFormat.indd 3 6/16/09 11:54:52 AM the road to siena edition of Catherine’s letters, published in Venice in 1500) intro- duces with the rubric: “To one whose name it is better not to write, because of certain words used in the letter. -

Benedetto Xvi Per La Canonizzazione Dei Beati
CAPPELLA PAPALE PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE BENEDETTO XVI PER LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI ARCANGELO TADINI PRESBITERO FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE OPERAIE DELLA SANTA CASA DI NAZARETH BERNARDO TOLOMEI ABATE FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DI SANTA MARIA DI MONTE OLIVETO DELL’ORDINE DI SAN BENEDETTO NUNO DE SANTA MARIA ÁLVARES PEREIRA RELIGIOSO DELL’ORDINE DEI CARMELITANI GELTRUDE COMENSOLI VERGINE FONDATRICE DELL’ISTITUTO DELLE SUORE SACRAMENTINE CATERINA VOLPICELLI VERGINE FONDATRICE DELLA CONGREGAZIONE DELLE ANCELLE DEL SACRO CUORE PIAZZA SAN PIETRO, 26 APRILE 2009 IIIDOMENICADIPASQUA 1 2 I PROFILO BIOGRAFICO DEI BEATI 3 4 ARCANGELO TADINI (1846-1912) 6 ARCANGELO TADINI, sacerdote bresciano vissuto tra il 1846 e il 1912, è una figura limpida e affascinante. Uomo intraprendente, prete autentico, ha intrecciato sapientemente rischio e fede, amore per gli uomini e amore per Dio, austerità e tenerezza. Nasce a Verolanuova (Brescia) il 12 ottobre 1846. Conclusi gli studi elementari nel paese natale, frequenta il ginnasio a Lovere (Bergamo). Nel 1864 entra nel seminario di Brescia e nel 1870 è ordinato sacerdote. Dal 1871 al 1873 è nominato vicario-cooperatore a Lo- drino (Brescia), piccolo paese di montagna, e dal 1873 cappellano al santuario di Santa Maria della Noce, frazione di Brescia. Nel 1885 inizia il suo servizio a Botticino Sera (Brescia) come vicario-cooperatore; due anni dopo, è nominato Parroco e vi rimane fino al 1912, anno della sua morte. All’inizio del suo mandato, dal pulpito afferma con forza: «Starò con voi, vivrò con voi, morirò con voi». Gli anni vissuti a Botticino sono certamente i più fecondi della vita di don Tadini. -

The Pious and Political Networks of Catherine of Siena
Portland State University PDXScholar University Honors Theses University Honors College 5-23-2018 The Pious and Political Networks of Catherine of Siena Aubrie Kent Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/honorstheses Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Kent, Aubrie, "The Pious and Political Networks of Catherine of Siena" (2018). University Honors Theses. Paper 553. https://doi.org/10.15760/honors.559 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in University Honors Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. Abstract This project looks at the career of St. Catherine of Siena and argues that without the relationships she had with her closest followers, who provided social connections and knowledge of the operation of political power, she would not have been able to pursue as active or wide-ranging a career. The examination of Catherine’s relationships, the careers of her followers, and the ways she made use of this network of support, relies mainly on Catherine’s extant letters. Most prior research on St. Catherine focuses on her spirituality and work with the papacy, which leaves out the influence of her local, political environment and the activities of her associates. This work examines Catherine’s place on Siena’s political landscape and within the system of Italian politics more generally. THE PIOUS AND POLITICAL NETWORKS OF CATHERINE OF SIENA by AUBRIE KENT A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of BACHELOR OF ARTS WITH HONORS in HISTORY Portland State University 2018 Table of Contents Chronology i Introduction 1 Religious Background 7 Political Background 22 Magnate Families 32 Spiritual Family 50 Conclusion 68 Catherine’s Associates 76 Bibliography 79 Chronology 1347 Catherine is born. -

Classicacc512010.Pdf
Classica et Christiana Revista Centrului de Studii Clasice şi Creştine Fondator: Nelu ZUGRAVU 5/1, 2010 Classica et Christiana Periodico del Centro di Studi Classici e Cristiani Fondatore: Nelu ZUGRAVU 5/1, 2010 ISSN: 1842 - 3043 Comitetul ştiinţific / Comitato scientifico Ovidiu ALBERT (Würzburg) Marija BUZOV (Zagreb) Dan DANA (Rouen) Mario GIRARDI (Bari) Attila JAKAB (Budapest) Domenico LASSANDRO (Bari) Aldo LUISI, direttore del Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell’Università degli Studi di Bari Giorgio OTRANTO (Bari) Evalda PACI (Scutari) Marcin PAWLAK (Torun) Vladimir P. PETROVIĆ (Beograd) Luigi PIACENTE (Bari) Mihai POPESCU (Paris) Comitetul de redacţie / Comitato di redazione Mihaela PARASCHIV (Iaşi) Claudia TĂRNĂUCEANU (Iaşi) Nelu ZUGRAVU, direttore del Centro di Studi Classici e Cristiani della Facoltà di Storia dell’Università „Alexandru I. Cuza” di Iaşi (director responsabil / direttore responsabile) Corespondenţa / Corrispondenza: Prof. univ.dr. Nelu ZUGRAVU Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasice şi Creştine Bd. Carol I, nr 11, 700506 – Iaşi, România Tel. ++40 232 201634 / ++ 40 742119015, Fax ++ 40 232 201156 e-mail: [email protected] UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ISTORIE CENTRUL DE STUDII CLASICE ŞI CREŞTINE Classica et Christiana 5/1 2010 Tehnoredactor: Nelu ZUGRAVU Coperta: Manuela OBOROCEANU ISSN: 1842 - 3043 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 700511 - Iaşi, str. Păcurari nr. 9, tel./fax ++ 40 0232 314947 SUMAR / INDICE ABREVIERI – ABBREVIAZIONI / 7 Anton ADĂMUŢ, Note asupra pragmatismului ambrozian / 11 Neil ADKIN, More additions to Maltby’s Lexicon of Ancient Latin Etymologies and Marangoni’s Supplementum Etymologicum: The scholia to Lucan / 31 Nicola BIFFI, La rinuncia di Plauto al miles / 77 Antonella BRUZZONE, Sull’ethos militare di Aezio: congettura a Merob. -

Thriving in Broken Futures: the Paradox of Church in Historic Watersheds Christopher Lars Arney George Fox University
Digital Commons @ George Fox University Doctor of Ministry Seminary 1-1-2013 Thriving in broken futures: the paradox of church in historic watersheds Christopher Lars Arney George Fox University This research is a product of the Doctor of Ministry (DMin) program at George Fox University. Find out more about the program. Recommended Citation Arney, Christopher Lars, "Thriving in broken futures: the paradox of church in historic watersheds" (2013). Doctor of Ministry. Paper 40. http://digitalcommons.georgefox.edu/dmin/40 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Seminary at Digital Commons @ George Fox University. It has been accepted for inclusion in Doctor of Ministry by an authorized administrator of Digital Commons @ George Fox University. GEORGE FOX UNIVERSITY THRIVING IN BROKEN FUTURES: THE PARADOX OF CHURCH IN HISTORIC WATERSHEDS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GEORGE FOX EVANGELICAL SEMINARY IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MINISTRY BY CHRISTOPHER LARS ARNEY PORTLAND, OREGON MARCH 2013 George Fox Evangelical Seminary George Fox University Portland, Oregon CERTIFICATE OF APPROVAL ________________________________ DMin Dissertation ________________________________ This is to certify that the DMin Dissertation of Christopher Lars Arney has been approved by the Dissertation Committee on March 22, 2013 for the degree of Doctor of Ministry in Leadership in the Emerging Culture. Dissertation Committee: Primary Advisor: Kent Yinger, PhD Secondary Advisor: Leonard Hjalmarson, DMin Lead Mentor: Leonard I. Sweet, PhD Copyright 2013 by Christopher Lars Arney All Rights Reserved Unless otherwise indicated, all scripture references are taken from, The Holy Bible: Today's ew International Version . Colorado Springs, Colorado: International Bible Society, copyright 2005. -

Und Werkindex Zu Den Werken Von Stefan Zweig
Autoren-, Künstler- und Werkindex zu den Werken von Stefan Zweig erstellt von Frank Geuenich 8., ergänzte Version Aachen, 2020 Der Index enthält, soweit eruierbar, Autoren/Verfasser und Künstler sowie literarische, wissenschaftliche und sonstige (Kunst)werke, die in den Werken von Stefan Zweig (SZ) Erwähnung finden. Die Werke finden sich, soweit zuordenbar, unter den Einträgen ihrer jeweiligen Verfasser/Urheber und werden – je nach SZs Praxis – mit ihrem ursprünglichen oder einem übersetzten Titel aufgeführt. Werke, die keinem Verfasser zuzuordnen sind, sind in die allgemeine alphabetische Reihenfolge eingeordnet (z.B. Bibel oder Tausendundeine Nacht ). Werke/Titel von Zweig selbst sind aufgenommen, sofern er sich an anderer Stelle auf sie bezieht. Die Verweise beziehen sich auf die im S. Fischer Verlag von Knut Beck herausgegebene Ausgabe „Gesammelte Werke in Einzelbänden“: Der Amokläufer (4. Auflage 2002) Auf Reisen (2. Auflage 2004) Balzac (1990) Begegnungen mit Büchern (2. Auflage 2006) Ben Jonson`s „Volpone“ und andere Nachdichtungen und Übertragungen für das Theater (1987) Brasilien (1990) Brennendes Geheimnis (3. Auflage 2002) Buchmendel (1990) Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt (3. Auflage 2007) Clarissa (4. Auflage 1991) Drei Dichter ihres Lebens (3. Auflage 2004) Drei Meister (2. Auflage 1982) Emile Verhaeren (1984) Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens (2. Auflage 2007) Die Heilung durch den Geist (4. Auflage 2007) Joseph Fouché (6. Auflage 2002) Der Kampf mit dem Dämon (3. Auflage 2004) Das Lamm des Armen (1984) Magellan (4. Auflage 1997) Maria Stuart (6. Auflage 2004) Marie Antoinette (5. Auflage 2007) Phantastische Nacht (5. Auflage 2002) Rahel rechtet mit Gott (2. Auflage 2002) Rausch der Verwandlung (6. -

Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box Contents Box
Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box contents Box# Box contents 1 Catalogued correspondence 2 A-AB 3 AC - ADAMS, J. 4 ADAMS, K.-AG 5 AH-AI 6 AJ-ALD 7 ALE-ALLEN, E. 8 ALLEN, F.-ALLEN, W. 9 ALLEN, Y. - AMERICAN AC. 10 AMERICAN AR. - AMERICAN K. 11 AMERICAN L.-AMZ 12 ANA-ANG 13 ANH-APZ 14 AR-ARZ 15 AS-AT 16 AU-AZ 17 B-BAC 18 BAD-BAKER, G. 19 BAKER, H. - BALDWIN 20 BALE-BANG 21 BANH-BARD 22 BARD-BARNES, J. 23 BARNES, N.-BARO 24 BARR-BARS 25 BART-BAT 26 BAU-BEAM 27 BEAN-BED 28 BEE-BELL, D. 29 BELL,E.-BENED 30 BENEF-BENZ 31 BER-BERN 32 BERN-BETT 33 BETTS-BIK 34 BIL-BIR 35 BIS-BLACK, J. 36 BLACK, K.-BLAN 37 BLANK-BLOOD 38 BLOOM-BLOS 39 BLOU-BOD 40 BOE-BOL 41 BON-BOOK 42 BOOK-BOOT 43 BOR-BOT 44 BOU-BOWEN 45 BOWER-BOYD 46 BOYER-BRAL 47 BRAM-BREG 48 BREH-BRIC 49 BRID - BRIT 50 BRIT-BRO 51 BROG-BROOKS 52 BROOKS-BROWN 53 BROWN 54 BROWN-BROWNE 55 BROWNE -BRYA 56 BRYC - BUD 57 BUE-BURD 58 BURE-BURL 59 BURL-BURR 60 BURS-BUTC 61 BUTLER, A. - S. 62 BUTLER, W.-BYZ 63 C-CAI 64 CAL-CAMPA 65 CAMP - CANFIELD, JAMES H. (-1904) 66 CANFIELD, JAMES H. (1905-1910) - CANT 67 CAP-CARNA 68 CARNEGIE (1) 69 CARNEGIE (2) ENDOWMENT 70 CARN-CARR 71 CAR-CASTLE 72 CAT-CATH 73 CATL-CE 74 CH-CHAMB 75 CHAMC - CHAP 76 CHAR-CHEP 77 CHER-CHILD, K. -

Descargar Descargar
La violencia religiosa en la Historia Eclesiástica de Teodoreto de Cirro. Violencia contra los paganos. Violencia de unos cristianos contra otros José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ Universidad Complutense de Madrid – Real Academia de la Historia RESUMEN Se estudia la violencia religiosa entre el concilio de Sardica y Teodosio II en la Historia Religiosa de Teodoreto de Cirro. Este trabajo es continuación de otros sobre el mismo tema, en la Historia Ecclesiastica de Sócrates y de Sozomeno. Se estudia la lucha entre arrianos y seguidores del Concilio de Nicea, entre cristianos, contra los judíos y los paganos. Se estudia la intervención, en estas luchas, de los emperadores, desde Constancio hasta Teodosio II. Se examina la convocatoria de diferentes concilios, Sardica, Rimini, Nice, Nicea, Milán, Constantinopla. La importancia de estos concilios en la lucha entre arrianos y ortodoxos. Se menciona la actuación de personajes importantes en la lucha entre arrianos y ortodoxos: Atanasio, Osio, etc. Se intercalan las actas de los concilios y cartas de Atanasio, de los emperadores, de Dámaso, etc., sobre la lucha. Se estudia la violencia en ciudades importantes del Imperio, como Alejandría y Constantinopla contra los ortodoxos, y la violencia de los arrianos contra varios personajes importantes del momento. Ocupa un lugar destacado en esta lucha, el diálogo entre Constancio y el obispo de Roma, Liberio, y su destierro. Se estudia la política anticristiana del emperador Juliano; la política favorable a los orto- doxos de los emperadores Joviano, Valentiniano I y Graciano; la política favorable a los arrianos de Valente, y la política de Teodosio I, que suprimió dentro del Imperio el paga- nismo y el arrianismo, y la destrucción de templos paganos. -

Pilgrim's Guide
EN KRAKÓW ISBN 978-83-65529-02-2 GET THE KRAKÓW APP. MUNICIPALITY OF KRAKOW Department of City Promotion and Tourism pl. Wszystkich Świętych 3-4 Pilgrim’s GuideGuide 31-004 Kraków tel.: +48 12 616 60 52 [email protected] TO KRAKOW www.krakow.pl FREE COPY; 2016 Table of contents Introduction 6 Following the Paths of John Paul II 7 Krakow Trail of Saints 23 Retracing the Footsteps of Saint Faustina Kowalska 37 Practical Information 49 1 LEGEND Tram line Bus line Following the Paths of John Paul II Krakow Trail of Saints Retracing the Footsteps of Saint Faustina Kowalska 3 Following the Paths of John Paul II 1. The Bishop’s Palace 22. St Florian’s Basilica 3 Franciszkańska Street 1 Warszawska Street 2. Franciscan Basilica of St Francis of Assisi 23. Monument of John Paul II in Strzelecki Park 2 Franciszkańska Street Lubicz Street 3. Bernardine Franciscan Sisters’ Church 24. Grave of the parents of John Paul II of St Joseph in the Rakowicki Cemetery 21 Poselska Street The exact location is indicated on the plan 4. Dean’s Tenement House at the entrance to the military part of the 21 Kanonicza Street cemetery from the side of Prandoty Street 5. Major Seminary of the Archdiocese of Krakow 25. Church of Queen Jadwiga of Poland 8 Podzamcze Street 60 Łokietka Street 6. Archcathedral Basilica of Saints Stanislaus of 26. The John Paul II Hospital Szczepanów and Wenceslaus on the Wawel Hill 80 Prądnicka Street 3 Wawel 27. Ecce Homo Church of Albertine Sisters 7. -
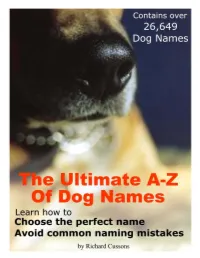
The Ultimate A-Z of Dog Names
Page 1 of 155 The ultimate A-Z of dog names To Barney For his infinite patience and perserverence in training me to be a model dog owner! And for introducing me to the joys of being a dog’s best friend. Please do not copy this book Richard Cussons has spent many many hours compiling this book. He alone is the copyright holder. He would very much appreciate it if you do not make this book available to others who have not paid for it. Thanks for your cooperation and understanding. Copywright 2004 by Richard Cussons. All rights reserved worldwide. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of Richard Cussons. Page 2 of 155 The ultimate A-Z of dog names Contents Contents The ultimate A-Z of dog names 4 How to choose the perfect name for your dog 5 All about dog names 7 The top 10 dog names 13 A-Z of 24,920 names for dogs 14 1,084 names for two dogs 131 99 names for three dogs 136 Even more doggie information 137 And finally… 138 Bonus Report – 2,514 dog names by country 139 Page 3 of 155 The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names Of all the domesticated animals around today, dogs are arguably the greatest of companions to man. -

Saint Geltrude Comensoli
Saint Geltrude Comensoli SAINT OF THE DAY 18-02-2021 The Eucharist was "Heaven on earth" to Saint Geltrude Comensoli (1847-1903), founder of the Institute of the Sacramentine Sisters which was consecrated to the perpetual adoration of the Blessed Sacrament and born from her love for Christ. Worshipping God in the Eucharistic Presence was the source of Geltrude's charity and the constant object of her meditations, which were often addressed to the mysteries of the Rosary: "The first adoration began at the cave in Bethlehem. The Holy Virgin and Saint Joseph prostrated themselves for the first time before the Most Holy Humanity of the Incarnate Word". The fifth of ten children, seven of whom died in their infancy, Saint Geltrude was born in Bienno, a small town near Brescia [Northern Italy], and was baptised, on the day of her birth, with the name of Catherine. As she wrote in her diary, when she was five Jesus instilled in her heart, "a great desire to love Him much, and He kept teaching me what I had to do to please Him and be His own". The little girl often meditated on the sacrifice of Christ ("I'm thinking", she replied when asked what she was doing) and on the sense of sin, the horror of which she could perceive through her intimate union with God. At seven years old, in fact, she was told by her mother that it was time for her first Confession: "I was astonished, and replied that I had been going to Confession every Saturday for some time".