1A Parte – Progetto Definitivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

K U B a Kuba 1 / 2011 Ölner Nd Onner Rchaeologica
K ölner u nd B onner A rchaeologica KuBA 1 / 2011 Kölner und Bonner Archaeologica KuBA 1 / 2011 Herausgeber Martin Bentz – Dietrich Boschung – Thomas Fischer – Reinhard Förtsch – Michael Heinzelmann – Frank Rumscheid Redaktion, Satz und Gestaltung Torsten Zimmer, Jan Marius Müller und Stefanie Ostendorf Umschlaggestaltung Torsten Zimmer Fotonachweis Umschlag Gisela Geng (CoDArchLab), FA-SPerg000055-02 Alle Rechte sind dem Archäologischen Institut der Unversität zu Köln und der Abteilung für Klassische Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorbehalten. Wiedergaben nur mit ausdrücklicher Genehmigung. Inhalt Vorwort der HERAUSGEBER 5 Beiträge BENJAMIN GEISSLER, Arzthäuser in Pompeji 7 PAUL SCHEDING, Der römische Stuck eines kaiserzeitlichen Großbaus. Zur Bedeutung monumentaler Stuckausstattung im römischen Karthago 37 Projektberichte JON ALBERS – MARTIN BENTZ – JAN MARIUS MÜLLER – GABRIEL ZUCHTRIEGEL, Werkstätten in Selinunt. Ein neues Forschungsprojekt 45 WOLFGANG EHRHARDT, Knidische Sakralbezirke im Hellenismus 49 MICHAEL HEINZELMANN – MANUEL BUESS, Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Oase Siwa in hellenistisch-römischer Zeit. Vorbericht zu einer ersten Forschungskampagne am Birket Zaytun 2009 65 MICHAEL HEINZELMANN – DAVID JORDAN – MANUEL BUESS, Amiternum. Eine archäologische Regionalstudie zum zentralen Abruzzenraum. Vorbericht zur Sommerkampagne 2009 77 ALEXANDRA W. BUSCH, Von der Kaiservilla zu den castra. Das Lager der legio II Parthica in Albano Laziale und seine Vorgängerbebauung. Ein Vorbericht zu den Projektarbeiten in 2009 87 GREGOR DÖHNER – MANUEL FIEDLER – CONSTANZE HÖPKEN – CHRISTOph MERZENICH – SZILAMÉR PÉTER PÁNCZÉL – VEIT STÜRMER – ZSOLT VASÁROS, Neue Forschungen im Kastell von Porolissum (Dakien, Rumänien). Bericht zur ersten Kampagne 2009 95 MARION BRÜGGLER – MANUEL BUESS – MICHAEL HEINZELMANN – MATTHIAS NIEBERLE, Ein neues Militärlager bei Steincheshof am Niederrhein (Bedburg-Hau, Kreis Kleve) 105 THOMAS FISCHER – CONSTANZE HÖPKEN, Untersuchungen im Südvicus von Sorviodurum / Straubing. -

Map 43 Latium Vetus Compiled by L
Map 43 Latium Vetus Compiled by L. Quilici and S. Quilici Gigli, 1995 Introduction The environs of Rome have undergone enormous changes from antiquity onwards, caused more by human intervention than by natural phenomena. Changes were already occurring in the archaic period as the region's population increased; these earliest phases of urbanization have been considerably illuminated by recent research. The changes intensified in Late Republican and imperial times, when urbanization reached a level unique for antiquity. Building activity connected with the city extended far enough into the countryside to link with construction centered upon surroundings towns. Thus the towns on the Tiburtine, Praenestine and Alban hills, as well as Ostia and Antium on the coast, were considered suburbs of the metropolis. After antiquity, by contrast, the region was almost deserted except in the hills. In the Late Middle Ages and subsequently, the spread of malaria and the extension of a pastoral economy reduced it to little more than a wilderness littered with the ruins remaining from an earlier era. By definition, there is some difficulty about showing settlements of different periods on a single map. We have marked those that can be located with either certainty or a fair degree of probability. At this scale no attempt is made to include every small settlement, let alone the whole complex infrastructure of the area. But we do mark cultural features notable for their size, state of preservation, or historical significance. These include large Late Republican and imperial villas, and the greatest monumental tombs. Inevitably, many estates, villas and tombs (some of them far from negligible) have had to be omitted. -

Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia Amelia Carolina Sparavigna
Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia Amelia Carolina Sparavigna To cite this version: Amelia Carolina Sparavigna. Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia. 2017. hal-01543034 HAL Id: hal-01543034 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01543034 Preprint submitted on 20 Jun 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Astronomical Orientations in the Roman Centuriation of Tunisia Amelia Carolina Sparavigna Politecnico di Torino Abstract The centuriation, also known as limitation, was the method used by the Roman surveyors for subdividing the land in a regular chessboard of fields, created by a grid made of parallel and perpendicular roads and canals. Here we discuss the limitation of Tunisia and the existence of some astronomical orientations of the grids, that is, orientations towards the direction of the sunrise on solstices or moonrise on lunar standstills. Keywords: Roman Centuriation, Archaeology, Archaeoastronomy, Modern Ephemeris, Suncalc.org, Photographer’s Ephemeris. Centuriation, also known as limitation, was the method used by the Roman surveyors for subdividing the land to create a regular chessboard of fields, separated by a grid of parallel and perpendicular roads and canals. -

Starting 2010 Adjunct Professor, “Tor Vergata” University, Rome, Department of History, Culture and Society
CURRICULUM VITAE CONSUELO MANETTA, PH.D. ACADEMIC EMPLOYMENT Starting 2010 Adjunct Professor, “Tor Vergata” University, Rome, Department of History, Culture and Society. EDUCATION 2013 Phd title of Doctor in Archaeology, obtained from the St. Kliment Ohridski University, Sofia 2010 Joint Phd (Tor Vergata University, Rome; St. Kliment Ohridski University, Sofia). Research’s project: “Le tombe dipinte della Bulgaria dall’età tardo-classica all’età tardo-antiica” (Гробници с живописна украса в Бългаpия от къснокласическaтa до късноантичната епоха). 2009 Teacher’s Certification Program for Humanities at the Secondary Education Level, grade: 42/42 10.2007-02.2008 Master in Thracian Painting, Bulgarian Academy of Sciences of Sofia National Archaeological Institut and Museum 2004 Master in Classical Archaeology (Scuola Nazionale di Specializzazione in Archeologia Classica), summa cum laude 1999 M.A., summa, Classical Archaeology 1996 Erasmus Student Exchange Program, 1996, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürberg, Germany GRANTS AND AWARDS 2014 Post-doctoral Fellowship at the Aristotle University, Thessaloniki, founded by the A. Onassis Foundation, Athens. Project: “De capite fortunisque omnibus” Late Antique and Early Christian Painted Tombs of Bulgaria. Advisor: Prof. Th. Stefanidou Tiveriou. Spring 2013 Fellow at the Harvard Center for Hellenic Studies, Washington DC. Project: Aspects of social, material and votive Thracian culture during the Late Classical and the Hellenistic periods: characteristics, local models and external influences from the funeral context. 2010 Post-doctoral Fellowship from the DAI/Abteilung Rom Project: Dalle ville repubblicane ai Castra Albana. Trasformazioni del territorio di Albano dall’età repubblicana al IV d.C. 2008-2009 Doctoral Fellowship, Erasmus Phd Exchange Program at the Saint Kliment Ohridski University, Sofia. -

Uomini E Donne Delle Nostre Terre
UOMINI, DONNE DELLE NOSTRE TERRE 2 Uomini, Donne delle nostre Terre a cura delle volontarie del Servizio Civile Nazionale Azzurra Pelli e Michela Mammola 3 PREFAZIONE Questo progetto è stato realizzato per riscoprire un’appartenenza comune, e per far conoscere tutti gli eventi che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia della città di Albano Laziale e la sua frazione, Cecchina, facendo luce sul nostro passato, in cui si intrecciano storie di uomini e donne che hanno contribuito a far crescere e sviluppare la nostra identità. Il territorio è vivo e continua a dire la sua, imponente e più autorevole delle migliaia di uomini e donne che da secoli vi trascorrono i giorni. Eppure al tempo stesso quegli uomini e quelle donne con i loro giorni, hanno condizionato in parte anche la mutazione del territorio stesso. Si cerca di cogliere il senso più profondo ripercorrendo la nostra storia, e parlando di chi erano quegli uomini e quelle donne, con la speranza di incidere in maniera ancor più indelebile sulla cittadinanza, per chi ci vive adesso e per chi ci vivrà un domani. In fondo ciò che siamo lo dobbiamo a ciò che siamo stati… 4 BREVE RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DI ALBANO LAZIALE E CECCHINA 5 La storia Albano è una delle più celebri località dei Castelli Romani, situata sulla sponda sud occidentale del Lago di Albano o di Castel Gandolfo. La presenza dell’uomo sui Colli Albani è documentata già in età antichissima a partire dal Paleolitico. Piccoli clan familiari abitarono le grotte che numerose si aprivano sulle pendici del Albano Laziale Lago di Albano iniziando così un insediamento umano che avrà il suo culmine con la nascita di Alba Longa. -

11 Parthica: Leg/0 Apud Romam
http://dx.doi.org/10.12795/Habis.2003.i34.17 11 PARTHICA: LEG/0 APUD ROMAM Adolfo Raúl Menéndez Argüín Universidad de Sevilla El presente artículo constituye sólo una primera aproximación a la historia y al papel político-militar desempeñado por la legión II Parthica a lo largo del s. 111 d.C. Desde comienzos de esa centuria por orden de Septimio Severo esta legión quedó acantonada a unos pocos kilómetros de Roma, con todo lo que ello suponía, pues su base, los Castra Albana, situada en tierras de propiedad impe rial desde época de Augusto, va a ser el primer campamento legionario que desde las guerras civiles de finales de la República se instale de forma permanente en suelo italiano. This paper is only an initial discussion of the history of the legio II Parthica during the third century A.D. From the beginning of that century, by order of Septimius Severos, this legion was stationed only a few kilometres from Rome. This was a momentous decision since its camp, the Castra Albana, located on land which had been imperial property from the time of Augustus, is the first per manent legionary camp on Italian soil since the end of the Civil Wars in the last years of the Roman Republic. La creación de la legión 11 Parthica, al igual que sus gemelas 1 y III Parthicae, se sitúa hacia el año 196 1 o 197 d.C.2, cuando el emperador Septimio Severo ( 193-211) se disponía a iniciar una campaña contra los partos en la frontera orien tal del Imperio (D.C. -

Parco Regionale Dei Castelli Romani
Parco Regionale dei Castelli Romani Sezione dei Castelli Romani Italia Nostra Il Parco Regionale dei Castelli Romani, istituito nel 1984 con la Legge della Regione Lazio n. 2 del 13 gennaio1984 e successive modificazioni, è come tutti i Parchi regionali del Lazio in una situazione di commissariamento ormai da tre anni. SIGNIFICATIVITA’ Il Parco Regionale dei Castelli Romani ha lo scopo di tutelare l’integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani. Il Parco si estende sui Colli Albani e include un’area di15.000 ettari composta dai territori di 15 comuni (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Nemi, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri). L’area dei Castelli Romani si trova a sudest di Roma e si sviluppa intorno ai complessi vulcanici dei Colli Albani e del Monte Tuscolo, in particolare i comuni sono distribuiti intorno a quest’ultimo rilievo evidenziando un continuum territoriale a forma di semicerchio. Il territorio è caratterizzato da un sistema collinare diffuso che assume carattere montano nei Comuni di Rocca Priora e Rocca di Papa. Del parco fanno parte anche il lago Albano e il lago di Nemi. 1 Caratteri ambientali Il territorio dei Castelli Romani è interessato, oltre che dal Parco Regionale, anche da altri strumenti di gestione del territorio con valenza ambientale. Sono infatti presenti all’interno del perimetro del parco quattro SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e una ZPS (Zone di Protezione Speciale) proposti per la presenza di specie animali e/o vegetali e habitat di interesse comunitario o prioritari. -
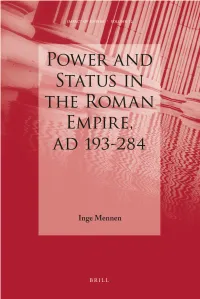
9789004211926 Webready Con
Power and Status in the Roman Empire, ad 193–284 Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands Academic Board of the International Network Impact of Empire géza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 12 Power and Status in the Roman Empire, ad 193–284 By Inge Mennen LEIDEN • BOSTON 2011 This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mennen, Inge. Power and status in the Roman Empire, AD 193-284 / by Inge Mennen. p. cm. – (Impact of empire, ISSN 1572-0500 ; v. 12) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-20359-4 (hbk. : acid-free paper) 1. Rome–Politics and government–30 B.C.-284 A.D. 2. Rome–Social conditions. 3. Rome–History–Empire, 30 B.C.-284 A.D. 4. Power (Social sciences)–Rome–History. 5. Rome–Officials and employees–Selection and appointment–History. 6. Social classes–Rome–History. 7. Social status–Rome–History. 8. Imperialism–Social aspects–Rome–History. -

Albano Laziale. Descrizione
Museo della Seconda Legione Partica. NumeroScheda: LUO0002. Comune: Albano Laziale. Descrizione: Il Museo è dedicato alla Seconda Legione Partica creata dall'imperatore Settimio Severo tra il 196 e il 197 d.C. per combattere i Parti e poi divenuta, per la sua fedeltà e il suo valore militare, Guardia del Corpo dell'Imperatore. La sede del Museo occupa alcuni ambienti delle Grandi Terme fatte costruire per i soldati della Legione dell'Imperatore Caracalla. L'esposizione museale inizia con la fedele ricostruzione dell'armamento e dell'abbigliamento delle principali figure militari della Legione. Nella stessa sala sono esposti alcuni significativi reperti archeologici: l'ara di Cassio Severiano, un altorilievo in marmo raffigurante i fasci littorii e uno stupendo schiniere in bronzo da parata con raffigurato il dio Marte.La sala II è dedicata alla documentazione dei Castra Albana e dei principali monumenti della città riferibili a questo accampamento. Alcuni elementi architettonici in marmo esposti testimoniano la ricchezza della decorazione che doveva abbellire gli edifici dei Castra. Nelle due sale successive è documentata la vita quotidiana della legione,vasi da cucina e da mensa, piatti in terra sigillata africana, anfore per il vino, l'olio e il garum, monete, punte di freccia e “ghiande missile” in piombo, usate come armi da getto e alcuni oggetti curiosi ed insoliti, come le pedine e i dadi da gioco e le tesserine in piombo che costituiscono una sorta di biglietto d'ingresso all'anfiteatro. L'ultima sala espositiva è dedicata all'aspetto funerario testimoniato dal rinvenimento sia di vaste aree necropolari che di tombe isolate. -

Scheda Stampa « Tess
Scheda TESS – http://tess.beniculturali.unipd.it/web/scheda/?recid=6087 VILLA, STAZIONE FERROVIARIA, TESSELLATO BIANCO BORDATO DI NERO – ALBANO LAZIALE ( RM) EDIFICIO RESIDENZIALE/VILLA Fra il 1913 ed il 1917, in seguito ai lavori per la costruzione di una cantina sociale, vennero alla luce alcuni resti di edifici in opera quadrata in peperino, interpretati come horrea, ed in opera reticolata, datati da Giuseppe Lugli al I secolo d.C. Fra il 1883 ed il 1884, in occasione dei lavori di allargamento della stazione ferroviaria, furono ritrovati i resti di un altro edificio con muri in opera quadrata, reticolata e laterizia (n 4). Il Lugli e il Tortorici reputarono tali resti pertinenti ad una seconda villa, mentre Giuseppe Chiarucci, in base alle analogie nella tecnica costruttiva, li considerò appartenenti ad un’unica villa la cui estensione sarebbe da ascrivere all’area compresa fra le attuali via Vascarelle, Rossini, Bellini e Miramare. Facevano parte delle strutture rinvenute nel 1884 anche alcune colonne in peperino intonacate, pertinenti ad un peristilio, ed una piccola sala termale (m 7×3) pavimentata a mosaico. La pianta della località dell’edificio è tratta da F. Severini, Via Appia – II da Bovillae a Cisterna di Latina (Antiche strade. Lazio), Roma 2001, p. 33, fig. 23. CRONOLOGIA ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I d.C. (1° q) al secolo I d.C. (4° q) MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati archeologici AMBIENTE TERMALE Ambiente termale caratterizzato da una pavimentazione a mosaico bianco bordato di nero. LUNGHEZZA: 7 m – LARGHEZZA: 3 m CRONOLOGIA Non determinata MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: non determinata Villa, Stazione ferroviaria, tessellato bianco bordato SPECIFICHE DI RINVENIMENTO di nero DATA: 1884/00/00 PARTE DELL’AMBIENTE: intero ambiente RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: non documentato TIPO DI IMPAGINAZIONE: a campo omogeneo CROMIA: bicromo Tessellato bianco bordato di nero. -

Power and Status in the Roman Empire, Ad 193–284
Power and Status in the Roman Empire, ad 193–284 Inge Mennen - 978-90-04-21192-6 Downloaded from Brill.com09/16/2019 12:16:26AM via free access Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands Academic Board of the International Network Impact of Empire géza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 12 Inge Mennen - 978-90-04-21192-6 Downloaded from Brill.com09/16/2019 12:16:26AM via free access Power and Status in the Roman Empire, ad 193–284 By Inge Mennen LEIDEN • BOSTON 2011 Inge Mennen - 978-90-04-21192-6 Downloaded from Brill.com09/16/2019 12:16:26AM via free access This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Mennen, Inge. Power and status in the Roman Empire, AD 193-284 / by Inge Mennen. p. cm. – (Impact of empire, ISSN 1572-0500 ; v. 12) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-20359-4 (hbk. : acid-free paper) 1. -

Con Vediromainbici, Visita Ad Albano Domenica 2 Dicembre
CON VEDIROMAINBICI, VISITA AD ALBANO DOMENICA 2 DICEMBRE In esclusiva (autorizzazione Musei Civici) aperti per noi Anfiteatro, “Cisternoni” e Santa Maria della Rotonda Appuntamento ore 11 Costruito su un’area demaniale flavia, cioè su un’ala della Villa di Domiziano, Albano Laziale sorge sui resti, tuttora ben conservati, dell’accampamento che Settimio Severo, autore di una riforma dell’esercito, volle per difendere Roma. Mentre il territorio di Albano, costituito di suolo vulcanico, fertilissimo, per quanto non molto provvisto d’acqua, è occupato per più di tre quarti da terreni coltivati, il centro abitato si concentra per intero sopra i Castra Albana. Si chiamano così poiché - come confermano anche le più recenti indagini archeologiche - questo è l’arco del cratere del Lago di Castel Gandolfo lungo cui sorse il centro di Alba Longa (va notato che l’etimologia del sito è “città di forma allungata le cui strutture si imbiancano all’alba”), che fu la progenitrice di Roma. Tale città dominò il territorio del Vulcano Laziale per lo meno dall’inizio dell’età del ferro (X secolo) fino a quando fu distrutta dai Romani nel VII secolo a.C., per volere di Tullo Ostilio, poi non più ricostruita. Alba Longa da un lato, secondo il mito, diede a Roma Romolo e Remo discendenti della stirpe reale sua propria, dall’altro, per certo, fu capitale della Lega Latina composta da trenta popoli federati e che veneravano quale principale luogo di culto Giove Laziare. Il santuario sorgeva sulla cima di Monte Cavo. Dell’accampamento severiano restano cospicui resti, come le mura, una delle porte (la Praetoria) e l’impianto termale.