Quaderni Dei Viandanti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Messner:"L'alpinismo Inizia Dove Finisce Il Turismo" Marta Cassin Sulle Pareti Del Nonno
montagne360° la rivista del Club Alpino Italiano settembre 2012 del Club Alpino Italiano, n. - 9/2012 Sped. – in Post. 45% abb. art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Milano. Messner:"L'alpinismo inizia dove finisce il turismo" . Rivista mensile Marta Cassin sulle pareti del nonno Speleologia: viaggio dentro le grotte vulcaniche lA montAgnA settembre 2012 unIsCe all’imbrago editoriale ggancio Calz i per a ata er orizzonti e orientamenti orzat gono rinf mica ops co lo n tir ant e a ll-a rou nd co lle ga to a l s is te m a d i a l la c c ia t u r a Il nostro mondo in edicola Il numero di Montagne 360° che avete tra le mani è l’ultimo che sarà inviato solo ai Soci CAI. Da ottobre, infatti, la rivista sarà distribuita anche nelle edicole e sarà a disposizione – al prezzo di € 3,90 - di tutti gli appassionati di montagna, di ambiente, di ar- T a rampicata, di speleologia, di cultura alpina, di sicurezza e di tanti l lo n altri temi legati alle Terre Alte. L’obiettivo è dialogare con i tanti e co n frequentatori e amanti della montagna che (per ora) non sono c us nostri Soci. Ai nuovi lettori offriremo la nostra idea, il nostro ci ne modo di guardare alla montagna. Quell’idea che è tutta nell’Arti- tt o am colo 1 dello Statuto del Club Alpino Italiano, la cui forza e mo- m ort . dernità originale non si è mai indebolita nel corso dei 150 anni izz ta an un di storia del Sodalizio. -

Wołanie 29-2001 Listopad
2 SPIS TREŒCI: 1. Historia alpinizmu czêœæ druga str. 3 Jerzy Hajdukiewicz 2. Spotkanie na szczycie str. 23 Andrzej Waligórski 3. Pusto w górach str. 25 Juliusz Wys³ouch 4. Górami pisane str. 28 Kazimierz Przerwa - Tetmajer Od maja 1987 roku ukaza³o siê 29 zeszytów Wo³ania Opracowanie: Polskie Towarzystwo Tatrzañskie, Oddzia³ Kraków, Cz³onek Wspieraj¹cy TOPR. Adres dla korespondencji: Andrzej S³ota, 30-150 Kraków, Armii Krajowej 83/131. Telefony: 012 638-01-54, e-mail: [email protected] Lokal: Dom Kultury „Podgórze” ul. Krasickiego 18/20. Dy¿ury Towarzystwa odbywaj¹ siê co dwa tygodnie we wtorki, w godzinach 18 - 19.30 Redaktor: Andrzej S³ota, zespó³ redakcyjny: Barbara Morawska-Nowak, Maciej Mischke. Wp³aty na rzecz Towarzystwa mog¹ byæ dokonywane na rachunek: PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162809-270-1-111 WO£ANIE PTT, Zarz¹d G³ówny, PKO I/O Kraków, nr. 10202892-162942-270-1-111 Emblemat na ok³adce rysowa³a Zofia Nowak Nr. 25 (29) Sk³ad komputerowy: Andrzej S³ota PL ISSN 0660-8679 Kraków, listopad 2001 Do druku oddano: 28 listopada 2001 3 4 WO£ANIE (Bernina); pierwsz¹ drogê na wschodniej œcianie Mont Blanc otwieraj¹ Moore, Walker i G. S. Matthews z M. i J. Andereggami Magazyn dla cz³onków Polskiego Towarzystwa przechodz¹c ostrogê Brenva, a w niczym nie ustêpuj¹ tym czynom Tatrzañskiego dwa œwietne zwyciêstwa Edwarda Whympera, równie¿ w masywie Mont Blanc: Aiguille Verte i Grands i cz³onków wspieraj¹cych TOPR Jorasses, z przewodnikami M. Crozem, Chr. Almerem i F. -

Italiano . English . Français
ITALIANO . ENGLISH . FRANÇAIS www.lakecomo.com UN MONDO UNICO AL MONDO Queste pagine presentano una veduta d’insieme del territorio del lago di Como, delle sue bellezze artistiche, naturali e dell’offerta turistica che essa propone. Notizie, documentazioni e informazioni più dettagliate sono disponibili presso: UN MONDE UNIQUE AU MONDE Ces pages présentent une vue d’ensemble du territoire du lac de Côme, de ses beautés artistiques, naturelles, et de ses propositions en matière de tourisme. Des documentations plus précises et des renseignements plus détaillés sont disponibles dans les agences suivantes: A WORLD WITHIN A WORLD These pages give an overall picture of lake Como, of its art treasures, natural beauty, and tourist facilities. News, documents, and more detailed information are all available from the following public bureaus: La campagna fotografica è stata realizzata da Daniela Ray Alberto Locatelli Michele Valsecchi Fotografie d’archivio: Archivio Storico, Milano Daniele Zoccola Jutta Bents IAT Como IAT Bellagio IAT Menaggio IAT Lecco IAT Barzio Paolo Ortelli Giorgio Sabbioni P.zza Cavour, 17 P.zza Mazzini P.zza Garibaldi, 8 Via Nazario Sauro, 6 Piazza Garibaldi Sandro Scarioni, Milano Progetto grafico: ATC Milano 22100 Como (imbarcadero) 22017 Menaggio 23900 Lecco 23816 Barzio Mauro Sioli Consulenza iconografica: Gerardo Mandressi Tel. + 39 031 26 97 12 22021 Bellagio Tel. + 39 0344 32 924 Tel. +39 0341 295720/721 Tel. +39 0341 996255 L. Tarragoni Traduzione in francese: Bernadette Borsato Fax +39 031 24 01 11 Tel. + 39 031 95 -

Catalogue 48: June 2013
Top of the World Books Catalogue 48: June 2013 Mountaineering Fiction. The story of the struggles of a Swiss guide in the French Alps. Neate X134. Pete Schoening Collection – Part 1 Habeler, Peter. The Lonely Victory: Mount Everest ‘78. 1979 Simon & We are most pleased to offer a number of items from the collection of American Schuster, NY, 1st, 8vo, pp.224, 23 color & 50 bw photos, map, white/blue mountaineer Pete Schoening (1927-2004). Pete is best remembered in boards; bookplate Ex Libris Pete Schoening & his name in pencil, dj w/ edge mountaineering circles for performing ‘The Belay’ during the dramatic descent wear, vg-, cloth vg+. #9709, $25.- of K2 by the Third American Karakoram Expedition in 1953. Pete’s heroics The first oxygenless ascent of Everest in 1978 with Messner. This is the US saved six men. However, Pete had many other mountain adventures, before and edition of ‘Everest: Impossible Victory’. Neate H01, SB H01, Yak H06. after K2, including: numerous climbs with Fred Beckey (1948-49), Mount Herrligkoffer, Karl. Nanga Parbat: The Killer Mountain. 1954 Knopf, NY, Saugstad (1st ascent, 1951), Mount Augusta (1st ascent) and King Peak (2nd & 1st, 8vo, pp.xx, 263, viii, 56 bw photos, 6 maps, appendices, blue cloth; book- 3rd ascents, 1952), Gasherburm I/Hidden Peak (1st ascent, 1958), McKinley plate Ex Libris Pete Schoening, dj spine faded, edge wear, vg, cloth bookplate, (1960), Mount Vinson (1st ascent, 1966), Pamirs (1974), Aconcagua (1995), vg. #9744, $35.- Kilimanjaro (1995), Everest (1996), not to mention countless climbs in the Summarizes the early attempts on Nanga Parbat from Mummery in 1895 and Pacific Northwest. -

1 Le Origini E L'esplorazione
STORIA DELL’ALPINISMO di Angelo Elli (ANAG Milano) con integrazioni di Lino Galliani (ANAG Bergamo) ANAG: Accomapagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile SOMMARIO Le origini L’esplorazione L’esplorazione delle montagne extraeuropee La ricerca di nuovi confini Montagne al femminile L’alpinismo è in crisi ? LE ORIGINI - 5000: Similaun - Ötzi - 218: Annibale attraversa le Alpi Il mondo dei Mostri L’epoca Romana Le strade La grande catena delle Alpi ha avuto certamente dall’età preistorica la doppia funzione di diga contro le ondate di popoli in emigrazione e di rifugio per le tribù abitanti le fervide pianure subalpine che scacciate da popolazioni più forti e numerose, si ritirarono verso le montagne. Nei tempi antichi le Alpi seguirono la sorte comune a tutte le montagne del mondo e vennero ritenute luoghi abitati da mostri oppure dimora degli dei. Il fenomeno è facilmente spiegabile: dalle montagne scendono le acque, apportatrici di fertilità, sulle montagne si scatenano le più terribili tempeste, cadono le valanghe e le frane: montagna come simbolo di sacralità, ostacolo, pericolo, orco. Nella fascia alpina i Romani organizzarono un’ammirevole rete stradale. Nei secoli bui della decadenza dell’impero e del medioevo le grandi strade romane, rovinate e per lo più abbandonate. Le montagne, con il trionfo del cristianesimo, sono credute dimora di Satana e di tutti gli spiriti infernali. Cime e ghiacciai vennero spesso esorcizzati e benedetti per scacciare i demoni. Per oltre due millenni di storia, fino alla fine del 1400 non si hanno notizie di una vera e propria ascensione a carattere esplorativo o alpinistico. Le Alpi vengono percorse alla ricerca di vallate accoglienti o fertili o di passi che colleghino una regione all’altra. -

Mercoledì 14 Agosto 2019 Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc Presentazione Del Libro Gasherbrum IV
Mercoledì 14 agosto 2019 Sala Fondazione Courmayeur Mont Blanc Presentazione del libro Gasherbrum IV. La montagna lucente negli scatti di Fosco Maraini. La Presentazione del libro “Gasherbrum IV. La montagna lucente negli scatti di Fosco Maraini” si inserisce nel ciclo culturale estivo della Fondazione Courmayeur Mont Blanc “La montagna in divenire”. L’Incontro è organizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano e la Società delle guide alpine di Courmayeur. Roberto Ruffier di Fondazione Courmayeur Mont Blanc ha presentato i protagonisti dell’Incontro: Alessandro Giorgetta, curatore del volume e direttore editoriale Club Alpino Italiano, Gioachino Gobbi, presidente Courmayeur Mont Blanc Funivie e presidente Grivel e Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo che ha moderato il dibattito. Hanno partecipato anche Marco Farina e Marco Majori della sezione Alta Montagna del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur che hanno raccontato - nel ricordo del loro compagno di spedizione Maurizio Giordano deceduto durante la missione che è stata interrotta - il loro tentativo, nel 2018, di completare l’ascesa al Gasherbrum IV sulla stessa via di Bonatti e Mauri. Marco Farina e Marco Majori il 18 settembre saranno impegnati in una nuova spedizione in Nepal per raggiungere i 7040 metri dello Nemjung, tentando la cresta inviolata dello sperone Nord. La presentazione del libro, edito dal Centro Operativo Editoriale del Club Alpino Italiano, ha offerto l’occasione per ripercorrere una spedizione storica ricordando uomini straordinari che hanno scritto la storia dell’alpinismo. I relatori hanno illustrato le tappe della spedizione guidata da Riccardo Cassin e composta dagli alpinisti Walter Bonatti, Carlo Mauri, Giuseppe de Francesch, Toni Gobbi, vice capo spedizione, Giuseppe Oberto, dal medico Donato Zeni e da Fosco Maraini nel ruolo di documentarista. -

Największy Alpinista Wszechczasów? Jakub Radziejowski Cassin
Riccardo największy alpinista wszechczasów? Jakub Radziejowski Cassin cassin.indd 50 2010-01-28 15:46:31 Czy aby na pewno największy? Już samo posta- skie, jednakże jak sam wspomina, praw- wienie takiego pytania jest nieco wbrew logice (jak to dziwą wspinaczkę zaczął uprawiać dwa zmierzyć?) i tak zwanej tradycji alpinistycznej, kulty- lata później. W tym samym roku wraz wowanej jeszcze miejscami to tu, to tam. Wszak, jak z kolegami założył klub wspinaczko- powszechnie wiadomo, we wspinaniu (szczególnie wy, który nazwali „Grupą Wspinaczkową górskim) chodzi o przygodę, romantyzm, walkę z wła- Nowe Włochy”. Pracując po dwanaście godzin na snymi słabościami i nieokiełznaną przyrodą, poszuki- dobę przez sześć dni w tygodniu, nie miał za wiele wanie nieznanego, wytyczanie nowych ścieżek, który- czasu na wspinanie. Ten wzorzec praktykował zresz- mi podąży ludzkość… No dobra – zagalopowałem się. tą przez całe swoje późniejsze życie – nie stał się ni- W każdym razie większość z nas, „ludzi gór”, wstrzą- gdy alpinistą zawodowym, a wszystkie jego wspi- śnie się z obrzydzeniem, kiedy ktoś zapyta o rywaliza- naczki, w tym wielkie nowe drogi, powstawały w dni cję w górach. „To dobre dla rycerzy sklejki” – odpowie wolne od pracy lub w czasie urlopu. prawdziwy Człek Gór – „my idziemy w góry, bo… są”. Zresztą, na początku kariery Riccardo Cassin Jednak jak się za chwilę okaże, sam Riccardo Cas- uprawiał wiele różnych dyscyplin, w tym wyścigi ro- sin od rywalizacji nie stronił, a żeby „zdobyć przed in- werowe i bieganie, później także narciarstwo. Jednak nymi”, skłonny był chyłkiem przemykać się pod ścianę najbliżej mu było do boksu, w którym odnosił spo- tak, by rywale się nie zorientowali. -

Montagne & Mestieri
Montagne360 La rivista del Club alpino italiano novembre 2017 € 3,90 MONTAGNE & MESTIERI Jo Nesbø, Mike Kosterlitz, Silvia Metzeltin e gli altri: non solo alpinismo #DESTINAZIONEK2 Da Torino alla seconda montagna del pianeta utilizzando i mezzi pubblici MOUNTAIN WILDERNESS Trent'anni dalla fondazione: storia e obiettivi di un'associazione che ripensa la montagna del Club alpino italiano n. 62/2017. Poste Italiane Spa, sped. in abb. Post. - 45% art. 2 comma 20/b - legge 662/96 Filiale di Milano. Prima immissione il 27 ottobre 2017 2017 ottobre il 27 immissione Prima 662/96 Filiale di Milano. - legge 20/b 2 comma - 45% art. Post. in abb. sped. Spa, Italiane Poste 62/2017. n. del Club alpino italiano 3,90. Rivista mensile Rivista 3,90. € Montagne360. Novembre 2017, 2017, Novembre Montagne360. Offerta riservata solo ai Soci EDITORIALE orizzonti e orientamenti CLUB ALPINO ITALIANO Fedeltà e riconoscenza P Abbonati di Vincenzo Torti* con lo sconto di oltre il Socie e Soci Carissimi, quando si parla delle attività che ci vedono impegnati, siamo soliti riferirci glo- balmente al “Cai”: il Cai che progetta, il Cai che realizza, il Cai che è presente, il Cai che dovrebbe… In questo modo esprimiamo il nostro sentirci compatti, solidali e ricompre- si in una dimensione fortemente identitaria. Ma questo non deve mai far di- menticare che, dietro tutto ciò, vi sono sempre donne e uomini di ogni età, dai più piccoli ai meno giovani, che silenziosamente, ma fattivamente, dedicano energie ed entusiasmo per realizzare obiettivi che, poi, diventano patrimonio P 6 numeri di di tutti noi. Ed è per questo che, in giorni nei quali, a un primo bilancio dei dati associa- Meridiani Montagne tivi, si riscontra una ulteriore e importante crescita del corpo sociale, vorrei intrattenermi con voi su un dato che mi sembra particolarmente significativo e a soli meritevole di qualche riflessione. -
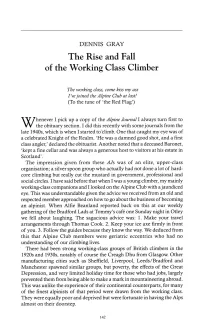
The Rise and Fall of the Working Class Climber
DENNIS GRAY The Rise and Fall of the Working Class Climber The working class, come kiss my ass I've joined the Alpine Club at last! (To the tune of 'the Red Flag') henever I pick up a copy of the Alpine Journal I always turn first to W the obituary section. I did this recently with some journals from the late 1940s, which is when I started to"climb. One that caught my eye was of a celebrated Knight of the Realm. 'He was a damned good shot, and a first class angler,' declared the obituarist. Another noted that a deceased Baronet, 'kept a fine cellar and was always a generous host to visitors at his estate in Scotland'. The impression given from these AJs was of an elite, upper-class organisation; a silver spoon group who actually had not done a lot of hard core climbing but really cut the mustard in government, professional and social circles. I have said before that when I was a young climber, my mainly working-class companions and I looked on the Alpine Club with a jaundiced eye. This was understandable given the advice we received from an old and respected member approached on how to go about the business of becoming an alpinist. When Alfie Beanland reported back on this at our weekly gathering of the Bradford Lads at Tommy's cafe one Sunday night in Otley we fell about laughing. The sagacious advice was: 1. Make your travel arrangements through Thomas Cook. 2. Keep your ice axe firmly in front of you. -

Library List Oct 2016 by Author.Pdf
A. Arnold-Brown. 1962. Unfolding character. The impact of Gordonstoun. A. Christensen (editor). 1987. Wilderness first aid. A. F. Mummery. 1895. My Climbs in the Alps and Caucasus. A. F. Mummery. 1974. My Climbs in the Alps and Caucasus. A. Harvard and T. Thompson. 1974. Mountain of Storms. A. K. Lobeck. 1939. Geomorphology: an introduction to the study of landscapes. A.H. Griffin. 1974. Long days in the hills. A.O. Wheeler. 1905. Selkirk Range, The. A.O. Wheeler. 1912. Selkirk Mountains, The. A guide for mountain pilgrims and climbers. A.P. Coleman. 1911. Canadian Rockies, The: new and old trails. A.W. Moore and E.H. Stevens (editors). 1939. Alps in 1864, The. Adrian and Alan Burgess. 1998. Burgess book of lies, The. Adrian and Alan Burgess. 2007. Brotherhood of the rope. The biography of Charles Houston. Advance Rock Climbing Committee, MIT Outing Club. 1956. Fundamentals of rock climbing. Al Burgess and Jim Palmer. 1983. Everest Canada. The ultimate challenge. Alan Blackshaw. 1965. Mountaineering. From hill walking to alpine climbing. Alan Blackshaw. 1973. Mountaineering. Alan Kane. 1999. Scrambles in the Canadian Rockies. Alastair Borthwick. 1989. Always a Little Further: a classic tale of camping, hiking and climbing in Scotland in the thirties. Alexander Mackenzie Trail Association. 1989 - 1996. Newsletter. Alfred Wills. 1937. Wandering Among the High Alps. Alice Purdey, John Halliday, and David and Mary Macaree . 2014. 109 Walks in British Columbia’s Lower Mainland. Allen Steck, Steve Roper, and David Harris (editors). 1999. Ascent. The climbing experience in word and image. Alpine Club of Canada, Vancouver Section. 1959-2012. -

Monti, Viaggi, Aviazione, Storia
www.donatilibri.it MONTI 1) AA.VV. I° Convegno Nazionale di Frutti- chitettonica del territorio alpino. Trieste, Civi- coltura Montana. St. Vincent 26-29 settem- co Museo Revoltella - Galleria d’Arte Moderna, bre 1953. Atti. Aosta, Margueretta-Diemoz per 1975 Assessorato Agricoltura R.A.Vd’AO, 1954 In 4° grande (cm. 37 x 22); fogli (2), 10, 3, 2, 13, (3) + In 8° grande (cm. 27 x 20); pagg. 471; con alcune tavole 14 carte ripiegate f.t., quasi tutte a colori; leggera car- a colori f.t. e illustraz. n.t.; leggera carton. origin. con ton. origin. figur. VG. ** Contiene: VENZA C. Line- illustraz. a colori applicata al piatto. VG. € 35,00 amenti di geografia nell’analisi sociale di una zona e- marginata. - CARULLI G.B. Lineamenti geologici 2) AA.VV. Cadore. Rivista bimestrale illustra- della Carnia. - POLDINI L. Elemento per una lettura ta edita sotto gli auspici della Magnifica Co- fitogeografica del territorio carnico. - MONTENERO munità Cadorina. Anno I° . N. 1. Feltre, Ca- G. Storia architettonica e urbanistica della Carnia. € 30,00 staldi, 1941 In 4° (cm. 29 x 21,5); pagg. 74; con numerose illustra- 5) (Carta geografica) Domodossola. F.° 15. Fi- zioni fotograf. e incisioni n.t.; leggera carton. origin. figurata a tre colori. VG. ** Primo numero di questa renze, Istituto Geografico Militare, 1901 bella rivista diretta da G.G. Bianco e Andrea Pais. Carta geografica in scala 1:100.000 di cm. 40 x 42 più Tra i collaboratori Giovanni Fabbiani e Bepi Degre- i margini bianchi, montata su tela all’epoca e con co- gorio. -

Aventure Et Littérature 2016 Aventure Etlittérature 2016 Édito
éditions Paulsen Aventure et littérature 2016 Aventure etlittérature Aventure 2016 édito L’amour des livres J’ai toujours aimé les livres. Pour ce qu’ils nous transmettent, pour ce qu’ils nous inspirent et pour ce temps de la lecture, temps privilégié qui libère l’imaginaire. Lorsque j’ai souhaité créer une maison d’édition, en 2006, Christian de Marliave m’a présenté son ami Michel Guérin qui avait fondé les éditions Guérin à Chamonix. J’ai immédiatement ressenti beaucoup d’admiration pour cet homme de lettres qui était aussi un entrepreneur courageux. Sa disparition brutale en 2007 aurait pu remettre en question l’avenir des éditions Guérin, mais son épouse, Marie-Christine Guérin, a poursuivi son œuvre avec une admirable opiniâtreté. En 2011, les éditions Guérin et les éditions Paulsen se sont associées pour unir leurs forces et publier des livres autour d’une ligne commune associant aventure et littérature. Cette année, les éditions Guérin fêtent leurs 20 ans et nos maisons sont désormais réunies autour de trois collections phares. La collection Guérin et ses fameux livres rouges plébiscités par les montagnards, la collection Exploration, qui présente de grandes biographies d’explorateurs avec une prédilection pour les mondes polaires, enfin la collection Démarches, initiée en 2013 par Jean-Christophe Rufin avec Immortelle randonnée, et dans laquelle nous souhaitons inviter des écrivains à vivre une grande aventure et à la raconter. Cette année est donc à la fois un anniversaire important et un renouveau pour nos livres. Dans la continuité de l’œuvre de Michel Guérin, je suis très fier de vous présenter ce catalogue, fruit de la passion de nos équipes et de notre amour partagé pour le livre.