Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo WHISTLEBLOWING GAME. UN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Política Industrial Y Crecimiento Económico En Colombia 1992-2012
POLÍTICA INDUSTRIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN COLOMBIA 1992-2012. Tesis presentada por Oscar Fernando González Alayón para obtener el grado de MAESTRO EN ECONOMÍA APLICADA Tijuana, B. C., México 2016 CONSTANCIA DE APROBACIÓN Director(a) de Tesis: _______________________________________________ Dra. Leticia Hernández Bielma Aprobada por el Jurado Examinador: 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ A mis padres Isabel y Juan, a mis hermanas Mónica y Diana, a mis sobrinos Juan Camilo y Matías, a Luisa y a toda mi familia, fueron mi motivación. AGRADECIMIENTOS Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por la beca otorgada para la realización de mis estudios de maestría, a El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) por su apoyo continuo y las atenciones recibidas durante la estancia en esta institución. Un agradecimiento especial a la Dra. Leticia Hernández Bielma, por su apoyo en la dirección de mi tesis, por sus observaciones, consejos y sugerencias. A todos los profesores e investigadores de la Maestría en Economía Aplicada por el conocimiento transmitido y la formación recibida. De igual forma agradezco a la Dirección General de Docencia por su apoyo, al Dr. Oscar Peláez Herreros quien desde la coordinación siempre estuvo dispuesto a brindarme su apoyo. A la Dra. Araceli Almaraz que fungió como lectora interna y aportó observaciones importantes al tema de investigación. Al Dr. Victor Manuel Cuevas Ahumada que participó como lector externo, gracias por su paciencia y observaciones en el manejo de la metodología y técnica de investigación. Por último, un agradecimiento a mis compañeros, colegas y amigos de la maestría por su acogida y por las jornadas de estudio compartidas. -

Biblioteca Mario Rostoni Fondo Marco Vitale
Biblioteca Mario Rostoni Biblioteca Mario Rostoni Fondo Marco Vitale Castellanza, 9 luglio 2018 2 Indice Monografie .................................................................................................................................... 5 Generalità.................................................................................................................................. 5 Informatica ................................................................................................................................ 8 Filosofia ..................................................................................................................................... 8 Psicologia ................................................................................................................................ 16 Religione ................................................................................................................................. 16 Scienze sociali - Sociologia .................................................................................................... 29 Scienza politica ....................................................................................................................... 44 Economia ................................................................................................................................ 70 Economia del lavoro ........................................................................................................... 94 Economia finanziaria ......................................................................................................... -

Working Paper Series 2017/06/MKT (Revised Version of 2015/01/MKT)
Working Paper Series 2017/06/MKT (Revised version of 2015/01/MKT) Pain of Paying? — A Metaphor Gone Literal: Evidence from Neural and Behavioral Science Nina Mazar University of Toronto, [email protected] Hilke Plassmann INSEAD, [email protected] Corresponding author Nicole Robitaille Queen’s University, [email protected] Axel Lindner Institute for Clinical Brain Research, [email protected] Dec 16, 2016 Do not share or cite without the authors’ permission How do individuals consider the price of a good when making purchase decisions? Standard economic theories assume an analytical process: Individuals consider the opportunity cost. Recent behavioral economic theories suggest an additional, hedonic process: Individuals consider the immediate displeasure or “pain of paying” the price. This paper is the first to present direct empirical evidence that the metaphor is more than a theoretical concept; it stands for a literal pain experience. In addition, the authors characterize its quality as an affective pain experience in three incentive-compatible experiments. First, an fMRI experiment suggests an affective pain experience and rejects a somatosensory (i.e., physical) pain experience. Second, the facilitation of affective pain perception through conceptual priming decreases willingness to pay (WTP). Third, misattributions of pain perception to placebo drugs increases versus decreases WTP for affective pain enhancers versus affective pain relievers. Conversely, facilitation and misattribution of somatosensory pain perceptions do not alter WTP. Keywords: Affective Pain-processing Pathways; Purchasing; Microeconomic Theory; Mental Accounting; Consumer Neuroscience; Pricing Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2901808 Acknowledgements We thank Antonio Rangel for his generous support with experiment 1 and Christof Koch for letting us use his lab’s shock stimulator equipment for experiment 1. -

Il-Ritorno-Emotivo-Sugli-Investimenti
Proprietà letteraria riservata © 2019 Banca Consulia Prima edizione: Giugno 2019 Coordinamento editoriale: Blandings Copertina di Stefano Cardini L’Autore: Matteo Motterlini, Professore Ordinario di Filosofia della Scienza ed E.ON Professor of Behavior Change all’Università San Raffaele di Milano, dove è Direttore del Centro di Epistemologia sperimentale e applicata. Già Consigliere per le Scienze Sociali e Comportamentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente Chief Behavioral Officer del Gruppo Ospedaliero San Donato. Collabora da diversi anni con il Corriere Economia e IlSole24Ore. E’ autore di Economia emotiva, Trappole Mentali e La psicoeconomia di Charlie Brown, per Rizzoli editore e tradotti in varie lingue. 2 Matteo Motterlini IL RITORNO EMOTIVO SUGLI INVESTIMENTI Perché conoscere il cervello fa bene al portafoglio 3 Presentazione EDUCAZIONE FINANZIARIA ED EDUCAZIONE SENTIMENTALE Le scelte quotidiane, comprese le decisioni di investimento, sono influenzate da molteplici fattori - vita privata, contesto sociale, politico ed economico - che impattano sulla nostra ricerca di sicurezza e di benessere. In questo libro Matteo Motterlini spiega, alla luce delle affascinanti ricerche sul funzionamento del nostro cervello, cosa succede quando prendiamo decisioni finanziarie. La finanza comportamentale mostra che per comprendere i meccanismi dei mercati non basta possedere conoscenze tecniche, ma occorre essere consapevoli dell’influenza delle emozioni sui comportamenti dei risparmiatori e gestori. L’unico modo per evitare queste “trappole mentali” è sapere quali sono, e in quali circostanze ne siamo più esposti. Credo fermamente nella positività delle persone, nel “bicchiere mezzo pieno”. E credo fortemente nel ruolo del Consulente Finanziario che si dedica alle dinamiche decisionali del cliente piuttosto che all’enfasi sul prodotto. -
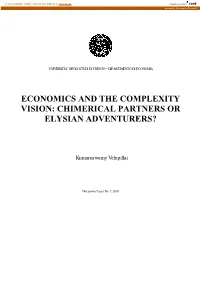
Economics and the Complexity Vision: Chimerical Partners Or Elysian Adventurers?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Unitn-eprints Research UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA _____________________________________________________________________________ ECONOMICS AND THE COMPLEXITY VISION: CHIMERICAL PARTNERS OR ELYSIAN ADVENTURERS? Kumaraswamy Velupillai _________________________________________________________ Discussion Paper No. 7, 2003 The Discussion Paper series provides a means for circulating preliminary research results by staff of or visitors to the Department. Its purpose is to stimulate discussion prior to the publication of papers. Requests for copies of Discussion Papers and address changes should be sent to: Prof. Andrea Leonardi Dipartimento di Economia Università degli Studi Via Inama 5 38100 TRENTO ITALY Economics and the Complexity Vision: Chimerical Partners or Elysian Adventurers? Part I1 K.Vela.Velupillai2 Department of Economics National University of Ireland, Galway Galway Ireland and Department of Economics University of Trento Via Inama 5 38100 Trento Italy October 6, 2003 1This work began as a review article of:Complexity and the History of Economic Thought, edited by David Colander, Routledge, London,UK, 2000; & The Complexity Vision and the Teaching of Economics, edited by David Colander, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2000. It has, in the writing, developed into my own vision of complexity economics. I am deeply indebted to my friend, colleague and fellow Salta- Zambaist, Nico Garrido, for invaluable help in preparing this paper. Alas, he is not responsible for the inevitable infelicities that remain. 2e-mail:[email protected] or [email protected] Contents I Visions and Traditions 2 1 Introduction 2 2 A Cautionary Tale - or Two 7 2.1 Mondrian and Klee - Pitfalls of Super¯cial Analogies . -

HUMANA.MENTE Journal of Philosophical Studies
VOLUME 10 ——— Journal of Philosophical Studies JJUULLYYJULY 101010 220000992009 PPhhiilloossoopphhyPhilosophyy of Economics EDITED BY MAURO ROSSI & LAURA BERITELLI QUARTERLY JOURNAL - ISSN: 1972-1293 JJOURNALOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES Biblioteca Filosofica © 2007 - Humana.Mente, Periodico trimestrale di Filosofia, edito dalla Biblioteca Filosofica - Sezione Fiorentina della Società Filosofica Italiana, con sede in via del Parione 7, 50123 Firenze (c/o la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze) - Pubblicazione regolarmente iscritta al Registro Stampa Periodica del Tribunale di Firenze con numero 5585 dal 18/6/2007. REDAZIONE - Via del Parione 7, Firenze, presso Biblioteca Filosofica - Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze ♦ Direttore editoriale: Alberto Peruzzi ♦ Direttore responsabile: Duccio Manetti ♦ Vice Direttore: Silvano Zipoli ♦ Supervisore scientifico: Marco Salucci Redattori e Area di Ricerca: Elena Acuti - Filosofia Politica Scilla Bellucci - Filosofia del Linguaggio / Antropologia Filosofica Laura Beritelli - Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Alberto Binazzi - Filosofia della Mente / Scienze Cognitive Matteo Borri - Filosofia e Storia della Scienza Roberto Ciuni - Ontologia / Logica Giovanni Casini - Filosofia della Scienza / Logica Chiara Erbosi - Bioetica / Filosofia della Mente Marco Fenici - Logica / Scienze Cognitive Riccardo Furi - Filosofia della Mente Tommaso Geri - Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Matteo Leoni - -

Research Design & Qualitative Methods
Duke University Political Science 330 Research Design & Qualitative Methods Spring 2010 Tuesdays, 4:25 - 6:55, Trent Hall, Room 038A course website at: http://courses.duke.edu Prof. Tim Büthe Dept. of Political Science 303 Perkins Library (919) 660-4365 (office); (919) 493-0304 (home); [email protected] office hours: Wednesdays 1:00 - 2:30pm Objectives PS330 is a course in methods in the broadest sense. The first part of the course deals with fundamental issues that are essential for almost all social science research: concepts and measurement, ontology and epistemology, causation and inference. The second part of the course deals with issues of research design, focusing on problems of case selection in non-statistical research, and specific methodological tools and techniques for empirical research. I allow for some flexibility in the topics covered in the second part to meet students' specific needs, but I intend to cover archival research and the critical use of sources, field research, qualitative interviewing, surveys and questionnaire design, as well as content and discourse analysis. The purpose of the course is to learn specific new skills—possibly for your own use in empirical work you might do. The course should put you in a stronger position to constructively critique published research (and work in progress) from a methodological point of view. This is an important skill both for work that employs the specific techniques that we discuss in this course and for work that "only" uses data generated through such techniques—often without awareness of the implications. The course also aims to make you more aware of your own and others' epistemological assumptions, assumptions about causality, and standards for judging empirical research in political science, as well as allow you to design better research projects yourself. -

A Computable Economist's Perspective
UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA _____________________________________________________________________________ A COMPUTABLE ECONOMIST‘S PERSPECTIVE ON COMPUTATIONAL COMPLEXITY K. Vela Velupillai _________________________________________________________ Discussion Paper No. 23, 2007 The Discussion Paper series provides a means for circulating preliminary research results by staff of or visitors to the Department. Its purpose is to stimulate discussion prior to the publication of papers. Requests for copies of Discussion Papers and address changes should be sent to: Dott. Stefano Comino Dipartimento di Economia Università degli Studi Via Inama 5 38100 TRENTO ITALIA A Computable Economist’sPerspective on Computational Complexity K. Vela Velupillai Department of Economics University of Trento Via Inama, 5 381 00 Trento, Italy Paper Prepared for: The Handbook of Complexity Research Edited by: J. Barkley Rosser, Jr., Edward Elgar Publishing Ltd. September 27, 2007 John McCall, Chico Doria and Stefano Zambelli have been educating me, from di¤erent points of view, on many fascinating visions of the thorny concept of complexity. More than a decade and a half of constant, stimulating, discussions with John McCall on Kolmogorov – algorithmic –complexity and theories of probability have been a source of great pleasure and consistent intellectual adventures. Not being particularly competent in the actual program- ming of theoretically structured computing models, I have had to rely on Stefano Zambelli for instruction and advice on the felicitous link between theory and application that is the hall mark of computational complexity theory. More recently, I have had the pleasure and privilege of being able to pick Chico Doria’s fertile brain for exotic ideas about the P =?NP question. -

Prefazione Introduzione Ringraziamenti 1. PSICOLOGIA ED
Prefazione Introduzione Ringraziamenti 1. PSICOLOGIA ED ESPERIMENTI IN ECONOMIA di Matteo Motterlini e Francesco Guala 1.1 Psicologia in economia 1.2 Esperimenti in economia Note bibliografiche e approfondimenti 2. PROSPECT THEORY: UN’ANALISI DELLE DECISIONI IN CONDIZIONI DI RISCHIO di Daniel Kahneman e Amos Tversky 2.1 Introduzione 2.2 Critica 2.3 Teoria 2.4 Discussione 3. UNO STUDIO SPERIMENTALE DELLA COMPETIZIONE DI MERCATO di Vernon L. Smith 3.1 Introduzione 3.2 Procedura sperimentale 3.3 Descrizione e discussione dei risultati sperimentali 3.4 Analisi empirica dei dati sperimentali: l’ipotesi della “rendita in eccesso” 3.5 Razionalizzazione dell’ipotesi di rendita in eccesso 3.6 Riepilogo Appendice 4. ANOMALIE: EFFETTO DOTAZIONE, AVVERSIONE ALLE PERDITE E DISTORSIONE DA STATUS QUO di Daniel Kahneman, Jack Knetsch e Richard Thaler 4.1 Introduzione 4.2 Effetto dotazione 4.3 Distorsione da status quo 4.4 Avversione alle perdite 4.5 Giudizi di equità e giustizia 4.6 Commento 5. INVERSIONI DI PREFERENZA TRA OFFERTE E SCELTE NELLE SCOMMESSE di Sarah Lichtenstein e Paul Slovic Esperimento 1 Esperimento 2 Esperimento 3 Discussione 6. SCELTA E RAGIONI di Eldar Shafir, Itamar Simonson e Amos Tversky Introduzione 6.1 Scelta tra opzioni ugualmente attraenti 6.2 Ragioni pro o contro 6.3 Scelta in presenza di conflitto 6.4 Scelta in condizioni di conflitto: aggiungere opzioni 6.5 Ragioni definite e disgiuntive 6.6 Caratteristiche senza valore 6.7 Osservazioni conclusive 7. L’OFFERTA DI LAVORO DEI TASSISTI DI NEW YORK di Colin F. Camerer, Linda Babcock, George Loewenstein e Richard Thaler 7.1 Introduzione 7.2 Analisi empiriche 7.3 Spiegare le elasticità salariali negative 7.4 Discussione e conclusioni 8. -

Prospect Theory, Neuroeconomics and Political Choice Decision Making Theories for International Politics
Department of Political Science, Major in Politics, Philosophy and economics Chair of Behavioral psychology and economics Prospect Theory, Neuroeconomics and Political Choice decision making theories for international politics Supervisor: Candidate: Massimo Egidi Myrlande Nardi 074372 Academic Year: 2015/16 1 To mom and dad, without whom I would never have reached this point. 2 Abstract The need of understanding the mechanism which bring us to take determined decisions has always been pronounced. Since the 17th century scholars have observed and analyzed the processes through which we make choices. Until 1979 the most popular theory in this area was Expected Utility Theory, then Kahnemann and Tversky conceived what has become known as Prospect Theory. The theory, which was developed to be an alternative to Expected Utility Theory, is based on the concepts of framing and risk aversion. Moreover, it was influenced by psychology and the new discoveries in neuroscience, such as the effects that emotions have on the decision making processes. As these discoveries became more significant, a new area of study developed which came to be known as neuroeconomics as it was born thanks to the convergence between various areas of study namely economics, psychology and neuroscience. Furthermore, even though Prospect Theory presents determined limitations, it was applied to various cases of international politics. Among these one of the most interesting is surely the Iran Hostage Crisis. The theory seems to be capable of explaining the irrational decision that were taken by the various actors in this context. 3 Index Introduction……………………………………………………………………………………..5 Chapter 1: Prospect Theory……………………………………………………………………...7 I. Historic context………………………………….......................................................7 II. -

Intellectual History As Legal Analysis Yoram Margalioth
Cornell Law Review Volume 96 Issue 4 May 2011 - Symposium: The Future of Legal Article 32 Theory Intellectual History as Legal Analysis Yoram Margalioth Follow this and additional works at: http://scholarship.law.cornell.edu/clr Part of the Law Commons Recommended Citation Yoram Margalioth, Intellectual History as Legal Analysis, 96 Cornell L. Rev. 1025 (2011) Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol96/iss4/32 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Cornell Law Review by an authorized administrator of Scholarship@Cornell Law: A Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. COMMENT INTELLECTUAL HISTORY AS LEGAL ANALYSIS Yoram Margaliotht The world's GDP per capita has grown significantly since World War II, but the distribution of wealth across countries has been ex- tremely unequal.' As William J. Baumol first noted, two clusters formed: one around wealth and one around poverty.2 The wealthy countries converged.3 While a number of developing countries, most notably China and India,4 also seem to be on the path to prosperity, other countries, home to more than one billion people, seem doomed to their poverty cluster.5 Economists have found that even after controlling for differences in resources, including physical and human capital, large differences in GDP per capita across countries remain.6 This has led them to think that the existence of differences in the quality of institutions across countries explains the persistent divergence in income per cap- ita.7 Their theory's main premise is that institutions influence the form and rate of technological progress, which is the engine of sus- tained economic growth, and shape the incentives of economic and political agents, which are the bread and butter of economics. -

Homo Oeconomicus. Paradigma, Critiche, Revisioni / Sergio Caruso
STUDI E SAGGI – 103 – SEMINARIO DI STORIA DELLE IDEE POLITICHE NUOVA SER IE Direttore Claudio De Boni Comitato Scientifico Gianluca Bonaiuti, Sergio Caruso, Brunella Casalini, Vittore Collina, Antonio Zanfarino Volumi pubblicati Fabio Bertini, La democrazia europea e il laboratorio risorgimentale italiano (1848- 1860) Claudio De Boni, Descrivere il futuro. Scienza e utopia in Francia nell’età del positivismo Claudio De Boni (a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L’Ottocento Claudio De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento. Parte prima: da inizio secolo alla seconda guerra mondiale Claudio De Boni (a cura di), Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento. Parte seconda: dal dopoguerra a oggi Sergio Caruso, Homo œconomicus. Paradigma, critiche, revisioni Sergio Caruso Homo œconomicus Paradigma, critiche, revisioni Saggio sui (discutibili) presupposti antropologici della razionalità utilitaria e sulle implicazioni ideologiche della loro entificazione FIrenze UnIversITY Press 2012 Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni / Sergio Caruso. – Firenze : Firenze University Press, 2012. (Studi e saggi ; 103) http://digital.casalini.it/9788866551072 ISBN 978-88-6655-105-8 (print) ISBN 978-88-6655-107-2 (online PDF) ISBN 978-88-6655-109-6 (online EPUB) Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández Immagine di copertina: © Gangster | Shutterstock Certificazione scientifica delle Opere Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul sito-catalogo della casa editrice (http://www.fupress.com).