Homo Oeconomicus. Paradigma, Critiche, Revisioni / Sergio Caruso
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Organizational Behaviour
GLOSSARY Organizational Behaviour aggression Aggression can be governed by rituals and set patterns of threat & response, including rituals for backing down. See also competition, cooperation, hormones (esp. testosterone) allophilia How much we like others. People’s attitudes towards immigration, charitable giving, study, voluntary work, and travel are guided by what sorts of groups make them feel good – more based on how much they like Latinos than party affiliation, social and economic status. Tolerance has limits to: despite years of peaceful symbiosis, age-old distinctions between in and out groups can quickly reappear (e.g. Bosnia and Rwanda). Groups accepting a fiat-based truce may compete violently once they get a chance. See also altruism, attachment, trust anxiety . Unfamiliar or dissimilar audience factors and sources . Novel or formal audience . Subordinate status . Conspicuousness or excess attention from audience . Undergoing evaluation . Previous repeated failure Arrow’s Describes that no voting-based system can prevent ‘despotism’ impossibility theorem See also voting assimilation Muslim beliefs hold that, if Muslim-friendly conditions do not exist, they have a duty to migrate in search of more genial places. When disconnected from moorings – customs, family life, and cuisine – a group of people can become fundamentalist and fanatical. into an organization Learn how to write reports, How to analyze data, manage time, produce on a deadline, attend to detail. attachment Strong bond with others. Mammals have a very strong attachment – families, friends, pets, etc. spring from this. Hormone oxytocin. This may be a key element to some types of religious behaviour, i.e. a belief or trust in a deity. -

The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence from Signals of Nonconformity
The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence from Signals of Nonconformity SILVIA BELLEZZA FRANCESCA GINO ANAT KEINAN This research examines how people react to nonconforming behaviors, such as entering a luxury boutique wearing gym clothes rather than an elegant outfit or wearing red sneakers in a professional setting. Nonconforming behaviors, as costly and visible signals, can act as a particular form of conspicuous consumption and lead to positive inferences of status and competence in the eyes of others. A series of studies demonstrates that people confer higher status and competence to non- conforming rather than conforming individuals. These positive inferences derived from signals of nonconformity are mediated by perceived autonomy and moderated by individual differences in need for uniqueness in the observers. An investigation of boundary conditions demonstrates that the positive inferences disappear when the observer is unfamiliar with the environment, when the nonconforming behavior is depicted as unintentional, and in the absence of expected norms and shared standards of formal conduct. Your sweats, PJs and flip-flops are losing you n both professional and nonprofessional settings, indi- money! . Do you crave more confidence, I viduals often make a significant effort to learn and adhere respect and power? . Find out how image to dress codes, etiquette, and other written and unwritten connects to success. (Eve Michaels, author of standards of behavior. Conformity to such rules and social Dress Code) norms is driven by a desire to gain social acceptance and I have a number of super-successful Silicon status (see Cialdini and Goldstein 2004) and avoid negative Valley clients who dress in ripped denim, Vans sanctions such as social disapproval, ridicule, and exclusion shoes, and T-shirts. -

Biblioteca Mario Rostoni Fondo Marco Vitale
Biblioteca Mario Rostoni Biblioteca Mario Rostoni Fondo Marco Vitale Castellanza, 9 luglio 2018 2 Indice Monografie .................................................................................................................................... 5 Generalità.................................................................................................................................. 5 Informatica ................................................................................................................................ 8 Filosofia ..................................................................................................................................... 8 Psicologia ................................................................................................................................ 16 Religione ................................................................................................................................. 16 Scienze sociali - Sociologia .................................................................................................... 29 Scienza politica ....................................................................................................................... 44 Economia ................................................................................................................................ 70 Economia del lavoro ........................................................................................................... 94 Economia finanziaria ......................................................................................................... -

Working Paper Series 2017/06/MKT (Revised Version of 2015/01/MKT)
Working Paper Series 2017/06/MKT (Revised version of 2015/01/MKT) Pain of Paying? — A Metaphor Gone Literal: Evidence from Neural and Behavioral Science Nina Mazar University of Toronto, [email protected] Hilke Plassmann INSEAD, [email protected] Corresponding author Nicole Robitaille Queen’s University, [email protected] Axel Lindner Institute for Clinical Brain Research, [email protected] Dec 16, 2016 Do not share or cite without the authors’ permission How do individuals consider the price of a good when making purchase decisions? Standard economic theories assume an analytical process: Individuals consider the opportunity cost. Recent behavioral economic theories suggest an additional, hedonic process: Individuals consider the immediate displeasure or “pain of paying” the price. This paper is the first to present direct empirical evidence that the metaphor is more than a theoretical concept; it stands for a literal pain experience. In addition, the authors characterize its quality as an affective pain experience in three incentive-compatible experiments. First, an fMRI experiment suggests an affective pain experience and rejects a somatosensory (i.e., physical) pain experience. Second, the facilitation of affective pain perception through conceptual priming decreases willingness to pay (WTP). Third, misattributions of pain perception to placebo drugs increases versus decreases WTP for affective pain enhancers versus affective pain relievers. Conversely, facilitation and misattribution of somatosensory pain perceptions do not alter WTP. Keywords: Affective Pain-processing Pathways; Purchasing; Microeconomic Theory; Mental Accounting; Consumer Neuroscience; Pricing Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2901808 Acknowledgements We thank Antonio Rangel for his generous support with experiment 1 and Christof Koch for letting us use his lab’s shock stimulator equipment for experiment 1. -

Il-Ritorno-Emotivo-Sugli-Investimenti
Proprietà letteraria riservata © 2019 Banca Consulia Prima edizione: Giugno 2019 Coordinamento editoriale: Blandings Copertina di Stefano Cardini L’Autore: Matteo Motterlini, Professore Ordinario di Filosofia della Scienza ed E.ON Professor of Behavior Change all’Università San Raffaele di Milano, dove è Direttore del Centro di Epistemologia sperimentale e applicata. Già Consigliere per le Scienze Sociali e Comportamentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attualmente Chief Behavioral Officer del Gruppo Ospedaliero San Donato. Collabora da diversi anni con il Corriere Economia e IlSole24Ore. E’ autore di Economia emotiva, Trappole Mentali e La psicoeconomia di Charlie Brown, per Rizzoli editore e tradotti in varie lingue. 2 Matteo Motterlini IL RITORNO EMOTIVO SUGLI INVESTIMENTI Perché conoscere il cervello fa bene al portafoglio 3 Presentazione EDUCAZIONE FINANZIARIA ED EDUCAZIONE SENTIMENTALE Le scelte quotidiane, comprese le decisioni di investimento, sono influenzate da molteplici fattori - vita privata, contesto sociale, politico ed economico - che impattano sulla nostra ricerca di sicurezza e di benessere. In questo libro Matteo Motterlini spiega, alla luce delle affascinanti ricerche sul funzionamento del nostro cervello, cosa succede quando prendiamo decisioni finanziarie. La finanza comportamentale mostra che per comprendere i meccanismi dei mercati non basta possedere conoscenze tecniche, ma occorre essere consapevoli dell’influenza delle emozioni sui comportamenti dei risparmiatori e gestori. L’unico modo per evitare queste “trappole mentali” è sapere quali sono, e in quali circostanze ne siamo più esposti. Credo fermamente nella positività delle persone, nel “bicchiere mezzo pieno”. E credo fortemente nel ruolo del Consulente Finanziario che si dedica alle dinamiche decisionali del cliente piuttosto che all’enfasi sul prodotto. -
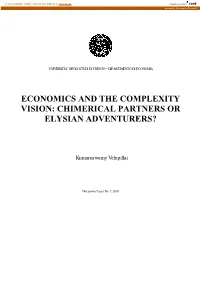
Economics and the Complexity Vision: Chimerical Partners Or Elysian Adventurers?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Unitn-eprints Research UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA _____________________________________________________________________________ ECONOMICS AND THE COMPLEXITY VISION: CHIMERICAL PARTNERS OR ELYSIAN ADVENTURERS? Kumaraswamy Velupillai _________________________________________________________ Discussion Paper No. 7, 2003 The Discussion Paper series provides a means for circulating preliminary research results by staff of or visitors to the Department. Its purpose is to stimulate discussion prior to the publication of papers. Requests for copies of Discussion Papers and address changes should be sent to: Prof. Andrea Leonardi Dipartimento di Economia Università degli Studi Via Inama 5 38100 TRENTO ITALY Economics and the Complexity Vision: Chimerical Partners or Elysian Adventurers? Part I1 K.Vela.Velupillai2 Department of Economics National University of Ireland, Galway Galway Ireland and Department of Economics University of Trento Via Inama 5 38100 Trento Italy October 6, 2003 1This work began as a review article of:Complexity and the History of Economic Thought, edited by David Colander, Routledge, London,UK, 2000; & The Complexity Vision and the Teaching of Economics, edited by David Colander, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2000. It has, in the writing, developed into my own vision of complexity economics. I am deeply indebted to my friend, colleague and fellow Salta- Zambaist, Nico Garrido, for invaluable help in preparing this paper. Alas, he is not responsible for the inevitable infelicities that remain. 2e-mail:[email protected] or [email protected] Contents I Visions and Traditions 2 1 Introduction 2 2 A Cautionary Tale - or Two 7 2.1 Mondrian and Klee - Pitfalls of Super¯cial Analogies . -
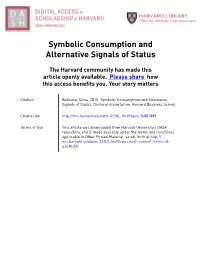
Symbolic Consumption and Alternative Signals of Status
Symbolic Consumption and Alternative Signals of Status The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Bellezza, Silvia. 2015. Symbolic Consumption and Alternative Signals of Status. Doctoral dissertation, Harvard Business School. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:16881889 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Symbolic Consumption and Alternative Signals of Status A dissertation presented by Silvia Bellezza to The Marketing Department at the Harvard Business School in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration in the subject of Marketing Harvard University, Cambridge, Massachusetts March, 2015 © 2015 Silvia Bellezza All rights reserved. Anat Keinan Silvia Bellezza Symbolic Consumption and Alternative Signals of Status Abstract My dissertation is composed of three papers on symbolic consumption–how consumers use products, brands, and time to express who they are and signal status. The first paper (Brand Tourists: How Non–Core Users Enhance the Brand Image by Eliciting Pride) demonstrates the positive impact of non-core users of a prestige brand perceived as “brand tourists” into the brand community. The second paper (The Red Sneakers Effect: Inferring Status and Competence from Signals of Nonconformity) investigates the conditions under which nonconforming behaviors, such as wearing red sneakers in a professional setting, can act as a particular form of conspicuous consumption and lead to positive inferences of status and competence in the eyes of others. -

HUMANA.MENTE Journal of Philosophical Studies
VOLUME 10 ——— Journal of Philosophical Studies JJUULLYYJULY 101010 220000992009 PPhhiilloossoopphhyPhilosophyy of Economics EDITED BY MAURO ROSSI & LAURA BERITELLI QUARTERLY JOURNAL - ISSN: 1972-1293 JJOURNALOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES Biblioteca Filosofica © 2007 - Humana.Mente, Periodico trimestrale di Filosofia, edito dalla Biblioteca Filosofica - Sezione Fiorentina della Società Filosofica Italiana, con sede in via del Parione 7, 50123 Firenze (c/o la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze) - Pubblicazione regolarmente iscritta al Registro Stampa Periodica del Tribunale di Firenze con numero 5585 dal 18/6/2007. REDAZIONE - Via del Parione 7, Firenze, presso Biblioteca Filosofica - Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Firenze ♦ Direttore editoriale: Alberto Peruzzi ♦ Direttore responsabile: Duccio Manetti ♦ Vice Direttore: Silvano Zipoli ♦ Supervisore scientifico: Marco Salucci Redattori e Area di Ricerca: Elena Acuti - Filosofia Politica Scilla Bellucci - Filosofia del Linguaggio / Antropologia Filosofica Laura Beritelli - Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Alberto Binazzi - Filosofia della Mente / Scienze Cognitive Matteo Borri - Filosofia e Storia della Scienza Roberto Ciuni - Ontologia / Logica Giovanni Casini - Filosofia della Scienza / Logica Chiara Erbosi - Bioetica / Filosofia della Mente Marco Fenici - Logica / Scienze Cognitive Riccardo Furi - Filosofia della Mente Tommaso Geri - Filosofia del Linguaggio / Ermeneutica Filosofica Matteo Leoni - -

Research Design & Qualitative Methods
Duke University Political Science 330 Research Design & Qualitative Methods Spring 2010 Tuesdays, 4:25 - 6:55, Trent Hall, Room 038A course website at: http://courses.duke.edu Prof. Tim Büthe Dept. of Political Science 303 Perkins Library (919) 660-4365 (office); (919) 493-0304 (home); [email protected] office hours: Wednesdays 1:00 - 2:30pm Objectives PS330 is a course in methods in the broadest sense. The first part of the course deals with fundamental issues that are essential for almost all social science research: concepts and measurement, ontology and epistemology, causation and inference. The second part of the course deals with issues of research design, focusing on problems of case selection in non-statistical research, and specific methodological tools and techniques for empirical research. I allow for some flexibility in the topics covered in the second part to meet students' specific needs, but I intend to cover archival research and the critical use of sources, field research, qualitative interviewing, surveys and questionnaire design, as well as content and discourse analysis. The purpose of the course is to learn specific new skills—possibly for your own use in empirical work you might do. The course should put you in a stronger position to constructively critique published research (and work in progress) from a methodological point of view. This is an important skill both for work that employs the specific techniques that we discuss in this course and for work that "only" uses data generated through such techniques—often without awareness of the implications. The course also aims to make you more aware of your own and others' epistemological assumptions, assumptions about causality, and standards for judging empirical research in political science, as well as allow you to design better research projects yourself. -

A Computable Economist's Perspective
UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA _____________________________________________________________________________ A COMPUTABLE ECONOMIST‘S PERSPECTIVE ON COMPUTATIONAL COMPLEXITY K. Vela Velupillai _________________________________________________________ Discussion Paper No. 23, 2007 The Discussion Paper series provides a means for circulating preliminary research results by staff of or visitors to the Department. Its purpose is to stimulate discussion prior to the publication of papers. Requests for copies of Discussion Papers and address changes should be sent to: Dott. Stefano Comino Dipartimento di Economia Università degli Studi Via Inama 5 38100 TRENTO ITALIA A Computable Economist’sPerspective on Computational Complexity K. Vela Velupillai Department of Economics University of Trento Via Inama, 5 381 00 Trento, Italy Paper Prepared for: The Handbook of Complexity Research Edited by: J. Barkley Rosser, Jr., Edward Elgar Publishing Ltd. September 27, 2007 John McCall, Chico Doria and Stefano Zambelli have been educating me, from di¤erent points of view, on many fascinating visions of the thorny concept of complexity. More than a decade and a half of constant, stimulating, discussions with John McCall on Kolmogorov – algorithmic –complexity and theories of probability have been a source of great pleasure and consistent intellectual adventures. Not being particularly competent in the actual program- ming of theoretically structured computing models, I have had to rely on Stefano Zambelli for instruction and advice on the felicitous link between theory and application that is the hall mark of computational complexity theory. More recently, I have had the pleasure and privilege of being able to pick Chico Doria’s fertile brain for exotic ideas about the P =?NP question. -

Prefazione Introduzione Ringraziamenti 1. PSICOLOGIA ED
Prefazione Introduzione Ringraziamenti 1. PSICOLOGIA ED ESPERIMENTI IN ECONOMIA di Matteo Motterlini e Francesco Guala 1.1 Psicologia in economia 1.2 Esperimenti in economia Note bibliografiche e approfondimenti 2. PROSPECT THEORY: UN’ANALISI DELLE DECISIONI IN CONDIZIONI DI RISCHIO di Daniel Kahneman e Amos Tversky 2.1 Introduzione 2.2 Critica 2.3 Teoria 2.4 Discussione 3. UNO STUDIO SPERIMENTALE DELLA COMPETIZIONE DI MERCATO di Vernon L. Smith 3.1 Introduzione 3.2 Procedura sperimentale 3.3 Descrizione e discussione dei risultati sperimentali 3.4 Analisi empirica dei dati sperimentali: l’ipotesi della “rendita in eccesso” 3.5 Razionalizzazione dell’ipotesi di rendita in eccesso 3.6 Riepilogo Appendice 4. ANOMALIE: EFFETTO DOTAZIONE, AVVERSIONE ALLE PERDITE E DISTORSIONE DA STATUS QUO di Daniel Kahneman, Jack Knetsch e Richard Thaler 4.1 Introduzione 4.2 Effetto dotazione 4.3 Distorsione da status quo 4.4 Avversione alle perdite 4.5 Giudizi di equità e giustizia 4.6 Commento 5. INVERSIONI DI PREFERENZA TRA OFFERTE E SCELTE NELLE SCOMMESSE di Sarah Lichtenstein e Paul Slovic Esperimento 1 Esperimento 2 Esperimento 3 Discussione 6. SCELTA E RAGIONI di Eldar Shafir, Itamar Simonson e Amos Tversky Introduzione 6.1 Scelta tra opzioni ugualmente attraenti 6.2 Ragioni pro o contro 6.3 Scelta in presenza di conflitto 6.4 Scelta in condizioni di conflitto: aggiungere opzioni 6.5 Ragioni definite e disgiuntive 6.6 Caratteristiche senza valore 6.7 Osservazioni conclusive 7. L’OFFERTA DI LAVORO DEI TASSISTI DI NEW YORK di Colin F. Camerer, Linda Babcock, George Loewenstein e Richard Thaler 7.1 Introduzione 7.2 Analisi empiriche 7.3 Spiegare le elasticità salariali negative 7.4 Discussione e conclusioni 8. -

The Signaling Function of Religious Speech in Domestic Counterterrorism
University of Chicago Law School Chicago Unbound Journal Articles Faculty Scholarship 2011 The Signaling Function of Religious Speech in Domestic Counterterrorism Aziz Huq Follow this and additional works at: https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles Part of the Law Commons Recommended Citation Aziz Huq, "The Signaling Function of Religious Speech in Domestic Counterterrorism," 89 Texas Law Review 833 (2011). This Article is brought to you for free and open access by the Faculty Scholarship at Chicago Unbound. It has been accepted for inclusion in Journal Articles by an authorized administrator of Chicago Unbound. For more information, please contact [email protected]. The Signaling Function of Religious Speech in Domestic Counterterrorism Aziz Z. Huq* A wave of attempted domestic terrorism attacks in 2009 and 2010 has sharpened attention to the threat of domestic-source terrorism inspired or directed by al Qaeda. Seeking to preempt that terror, governments face an information problem. They must separate signals of terrorism riskfrom po- tentially overwhelming background noise and persuadejuries or fact finders that those signals warrant coercive action. Selection of accurate signals of terrorism danger in the information-poor circumstances of domestic counterterrorismis arguably a central challenge today for law enforcement tasked with preventing further terrorist attacks. To an underappreciated extent, governments have used religious speech as a proxy for terrorism risk in order to resolve this signaling problem. This Article analyzes the legal and policy significance of state reliance upon religious speech as a predictor of terrorism risk. Constitutional doctrine under the Religion Clauses does recognize interests implicated by the signalingfunction of religious speech.