PDF 2016 Spazi Fluidi Il Giornalismo Toscano E La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Blogs: What Are They??
BLOGS: WHAT ARE THEY?? Blogs are a contemporary form of journalism. To answer the title question, we may build our reply using several of the questions journalists are trained to address. When did blogs appear on the scene? The term blog has its earliest direct roots in on-line diaries which appeared in 1994 (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_blogging). It was not until 1997 that the term “weblog” was coined to describe this form of communication; by 1999, it finally morphed into simply blog. In 2004, Meriam-Webster cataloged the word blog as a legitimate dictionary denizen. Ian Ring is credited with being the inventor (or parent) of the blog in 1997. As noted above, in its earliest years the blog appeared primarily as an on line diary or serial of the life and times of its author(s). Today’s blogs are adolescents in linguistic terms and they have outgrown all of their early childhood clothing to take on a host of very different appearances. An early Ted Talk includes commentary on the young years of blogging. Mena Trott in 2006 recounts some of her early experiences with blogging she began in 2001 ( https:// www.ted.com/talks/mena_trott_tours_her_blog_world ). Now, some 10 years after this Ted Talk, blogs have undergone explosive growth in both content and numbers, achieving a stature only dimly envisioned by their parents. We now encounter blog as just one of a whole host of terms building upon it including blogger, blogging, liveblogging, photoblog, microblog, moblog and a host of others. What purposes can blogs serve? Want to inform, teach, convince, amuse, sway, share, sell, defend, support or refute something? • Long and short of it – blogs are contemporary forms of journalism in the broadest sense of the art. -

CUE Live User Guide 3.2.1-2 Table of Contents
CUE Live User Guide 3.2.1-2 Table of Contents 1 Introduction.......................................................................................................................................... 5 2 Using CUE Live................................................................................................................................... 6 2.1 Creating an Event...................................................................................................................6 2.2 Blogging with CUE Live......................................................................................................... 6 2.2.1 Adding Images...........................................................................................................7 2.2.2 Adding Social Content...............................................................................................7 2.2.3 Pinning Entries.......................................................................................................... 8 2.2.4 Tagging Entries......................................................................................................... 8 2.2.5 Editing Entries........................................................................................................... 9 2.2.6 Posting to Twitter...................................................................................................... 9 2.3 Including External Content..................................................................................................... 9 2.3.1 Social Media Feeds...................................................................................................9 -
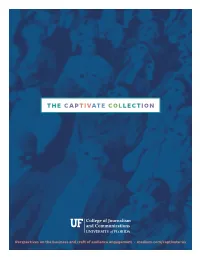
The Captivate Collection
THE CAPTIVATE COLLECTION Perspectives on the business and craft of audience engagement • medium.com/captivate-us THE CAPTIVATE COLLECTION 8 Introduction: The Captivate Collection RANDY BENNETT, DIRECTOR, ENTREPRENEURSHIP AND PARTNERSHIPS UF COLLEGE OF JOURNALISM AND COMMUNICATIONS ENGAGEMENT THE CAPTIVATE COLLECTION 10 What’s the Key to Media Success? Products that Build Relationships DAVID COHN, EXECUTIVE PRODUCER, AJ+ 13 What Buzzfeed, Medium and Adafruit Know About Engagement RYAN SINGEL, CO-FOUNDER, CONTEXLY 17 Be Social, Leverage Technology, Build Stuff TOM KELLEHER, CHAIR/DEPARTMENT OF ADVERTISING, UF COLLEGE OF JOURNALISM AND COMMUNICATIONS 21 Monetize Passion, Not Pageviews: A Q&A with Jim Brady JIM BRADY, CEO, STOMPING GROUND 24 What Customers Want is Invisible to the Eye KAILA COLBIN, CO-FOUNDER, MINISTRY OF AWESOME STORYTELLING THE CAPTIVATE COLLECTION 29 From Story Told to Story Lived DARREN “DAZ” MCCOLL, GLOBAL CHIEF STRATEGY OFFICER, SAPIENTNITRO 32 An Actor’s Guide to Better Storytelling ROB BIESENBACH, CORPORATE COMMUNICATIONS CONSULTANT AND WRITER 36 Creating a Richer Storytelling Experience MARK POTTS, FOUNDER, NEWSPEG.COM MARKETING THE CAPTIVATE COLLECTION 41 The Dawn of a New Era in Marketing RISHAD TOBACCOWALA, CHIEF STRATEGIST AND MEMBER OF THE DIRECTOIRE+, PUBLICIS GROUP 44 “Emotional fulfillment, not technology, will be the stand-out offering of a winning brand” KEVIN ROBERTS, CEO WORLDWIDE, SAATCHI & SAATCHI 48 Don’t Call It Advertising Anymore DOUG WEAVER, FOUNDER AND CEO, UPSTREAM GROUP 51 We Need a New “Church -

Communities of Blogging: Extensions of Our Identities Ellen Taricani
American Communication Journal Vol. 9, No. 3, Fall 2007 Communities of Blogging: Extensions of Our Identities Ellen Taricani Keywords: blogging, identity, social networking Writing through a blog is a way of extending ourselves in a virtual world. Our identity is formed and molded as we unveil our thoughts and have others offer comments and feedback. The online environment has a direct impact in creating active social interactions to assist in defining our identity. Most blogs are a personal journal type of entry that deals with the personal experiences and reflections. Our concept of ourself is derived from a perceived membership in a particular blog through the deeper connectivity of the dialog. Most bloggers are under 30 and influenced by the postmodern philosophies. Some of these are discussed and parallels are made to bring more understanding of this fascination with the public broadcast of thoughts and feelings. ________________________________________________________________________ Dr. Ellen Taricani is a Lecturer in the Dept. of Communication Arts and Sciences at Penn State University. Correspondence to: Dept. of Communication Arts and Sciences, Penn State University 227 Sparks Building, University Park, PA 16802. Email: [email protected] Paper presented at the American Communication Conference annual meeting, Taos, New Mexico, Oct. 3-7, 2007 Blogging is a popular social and cultural collection of thought and communication. It consists of a presence that is an expression of who we are, our identity. Culture attempts to adopt this technology across dimensions of life, such as personal and professional life. Dertouzos (1997) described it as a world of human-centric computing that will insinuate the lives of individuals in societies that have learned to accept technology. -

Blogging Glossary
Blogging Glossary Glossary: General Terms Atom: A popular feed format developed as an alternative to RSS. Autocasting: Automated form of podcasting that allows bloggers and blog readers to generate audio versions of text blogs from RSS feeds. Audioblog: A blog where the posts consist mainly of voice recordings sent by mobile phone, sometimes with some short text message added for metadata purposes. (cf. podcasting) Blawg: A law blog. Bleg: An entry in a blog requesting information or contributions. Blog Carnival: A blog article that contains links to other articles covering a specific topic. Most blog carnivals are hosted by a rotating list of frequent contributors to the carnival, and serve to both generate new posts by contributors and highlight new bloggers posting matter in that subject area. Blog client: (weblog client) is software to manage (post, edit) blogs from operating system with no need to launch a web browser. A typical blog client has an editor, a spell-checker and a few more options that simplify content creation and editing. Blog publishing service: A software which is used to create the blog. Some of the most popular are WordPress, Blogger, TypePad, Movable Type and Joomla. Blogger: Person who runs a blog. Also blogger.com, a popular blog hosting web site. Rarely: weblogger. Blogirl: A female blogger Bloggernacle: Blogs written by and for Mormons (a portmanteau of "blog" and "Tabernacle"). Generally refers to faithful Mormon bloggers and sometimes refers to a specific grouping of faithful Mormon bloggers. Bloggies: One of the most popular blog awards. Blogroll: A list of other blogs that a blogger might recommend by providing links to them (usually in a sidebar list). -

20Entrepreneurial Journalism
Journalism: New Challenges Karen Fowler-Watt and Stuart Allan (eds) Journalism: New Challenges Edited by: Karen Fowler-Watt and Stuart Allan Published by: Centre for Journalism & Communication Research Bournemouth University BIC Subject Classification Codes: GTC Communication Studies JFD Media Studies KNTD Radio and television industry KNTJ Press and journalism JNM Higher and further education, tertiary education First published 2013, this version 1.02 ISBN: 978-1-910042-01-4 [paperback] ISBN: 978-1-910042-00-7 [ebook-PDF] ISBN: 978-1-910042-02-1 [ebook-epub] http://microsites.bournemouth.ac.uk/cjcr/ Copyright © 2013 Acknowledgements Our first thank you is to the contributors who made Journalism: New Challenges possible, not least for so generously sharing their expertise, insights and enthusiasm for this approach to academic e-publishing. This endeavour was supported by the Centre for Journalism and Communication Research (CJCR), here in the Media School at Bournemouth University, UK. With regard to the production and distribution of this book, we are grateful to Einar Thorsen and Ann Luce for their stellar efforts. They would like to thank, in turn, Carrie Ka Mok for setting its design and layout, and Ana Alania for contributing ideas for the cover. Many thanks as well to Mary Evans, Emma Scattergood and Chindu Sreedharan for their helpful sugges- tions on how to develop this publishing venture. Karen Fowler-Watt and Stuart Allan, editors Table of contents Introduction i Karen Fowler-Watt and Stuart Allan Section One: New Directions -
216631157.Pdf
The Alternative Media Handbook ‘Alternative media’ are media produced by the socially, culturally and politically e xcluded: they are always independently run and often community-focused, ranging from pirate radio to activist publications, from digital video experiments to ra dical work on the Web. The Alternative Media Handbook explores the many and dive rse media forms that these non-mainstream media take. The Alternative Media Hand book gives brief histories of alternative radio, video and lm, press and activity on the Web, then offers an overview of global alternative media work through nu merous case studies, before moving on to provide practical information about alt ernative media production and how to get involved in it. The Alternative Media H andbook includes both theoretical and practical approaches and information, incl uding sections on: • • • • • • • • successful fundraising podcasting blogging publishing pitch g a project radio production culture jamming access to broadcasting. Kate Coyer is an independent radio producer, media activist and post-doctoral re search fellow with the Annenberg School for Communication at the University of P ennsylvania and Central European University in Budapest. Tony Dowmunt has been i nvolved in alternative video and television production since 1975 and is now cou rse tutor on the MA in Screen Documentary at Goldsmiths, University of London. A lan Fountain is currently Chief Executive of European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE), a professional development programme for lm and television producers. He was the rst Commissioning Editor for Independent Film and TV at Channel Four, 198 1–94. Media Practice Edited by James Curran, Goldsmiths, University of London The Media Practice hand books are comprehensive resource books for students of media and journalism, and for anyone planning a career as a media professional. -

State of Scholarship on Weblogs Definition of Weblogs
Introduction: Weblogs, Rhetoric, Community, and Culture Laura Gurak, Smiljana Antonijevic, Laurie Johnson, Clancy Ratliff, and Jessica Reyman, University of Minnesota State of scholarship on weblogs During the past two decades, we have witnessed the introduction of many new digital spaces for writing and communicating, from hypertext, to chat rooms, to newsgroups, to discussion boards, to MOOS and MUDs, to wikis, to peer-to-peer file sharing networks. The proliferation of new spaces for communicating via the Internet has evoked scholarship in the fields of communication, rhetoric, composition, and writing studies from researchers seeking to address the social, rhetorical, and discursive implications. Recently, there has emerged a new object for study of great rhetorical impact: the weblog. The scholarly exploration of weblogs is still new, having up to this point taken place at primarily at conferences. Some examples include Computers and Writing 2003 and 2004, Conference on College Composition and Communication 2004, the Association of Internet Researchers 2003, and Harvard Law School's BloggerCon, a conference devoted to "the art and science of weblogs." At these conferences, scholars have recognized that blogs are more than mere tools for communicating online; rather, they provide new possibilities for the Internet as a rhetorical space. Blogs, some would argue, have revolutionized the way we receive information and connect with each other in online environments. Enthusiasts claim that blogs allow anyone's voice to be heard and resist hierarchical modes of information dissemination and communication. While this idealist egalitarian model of the Internet has often been criticized, we find value in the power of blogs to forego the institutionalization of communicative practices and offer spaces for writing that are more collaboratively constructed than other online spaces, as bloggers freely link to, comment on, and augment each other's content. -

A New Model for Media Criticism: Lessons from the Schiavo Coverage
University of Miami Law Review Volume 61 Number 3 Volume 61 Number 3 (April 2007) SYMPOSIUM The Schiavo Case: Article 4 Interdisciplinary Perspectives 4-1-2007 A New Model for Media Criticism: Lessons from the Schiavo Coverage Lili Levi University of Miami School of Law, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.law.miami.edu/umlr Part of the Family Law Commons, Health Law and Policy Commons, and the Medical Jurisprudence Commons Recommended Citation Lili Levi, A New Model for Media Criticism: Lessons from the Schiavo Coverage, 61 U. Miami L. Rev. 665 (2007) Available at: https://repository.law.miami.edu/umlr/vol61/iss3/4 This Article is brought to you for free and open access by the Journals at University of Miami School of Law Institutional Repository. It has been accepted for inclusion in University of Miami Law Review by an authorized editor of University of Miami School of Law Institutional Repository. For more information, please contact [email protected]. A New Model for Media Criticism: Lessons from the Schiavo Coverage LILI LEVI* I. INTRODUCTION ...................................................... 665 II. SHARPLY DIVIDED CRITICISM OF SCHIAVO MEDIA COVERAGE ................... 666 . III. How SHOULD WE ASSESS MEDIA COVERAGE? 674 A. JournalisticStandards ............................................ 674 B. Internal Limits of JournalisticStandards ............................. 677 C. Modern Pressures on Journalistic Standards and Editorial Judgment .... 680 1. CHANGES IN INDUSTRY STRUCTURE AND RESULTING ECONOMIC PRESSURES ................................................... 681 2. THE TWENTY-FOUR HOUR NEWS CYCLE ................................. 686 3. BLURRING THE DISTINCTION BETWEEN NEWS, OPINION, AND ENTERTAINMENT .............................................. 688 4. THE RISE OF BLOGS AND NEWS/COMMENTARY WEB SITES ................. 690 5. "NEWS AS CATFIGHT" - CHANGING DEFINITIONS OF BALANCE ........... -
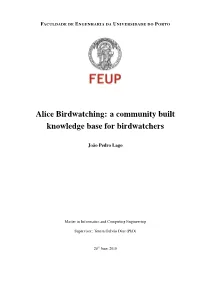
Alice Birdwatching: a Community Built Knowledge Base for Birdwatchers
FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO Alice Birdwatching: a community built knowledge base for birdwatchers João Pedro Lago Master in Informatics and Computing Engineering Supervisor: Teresa Galvão Dias (PhD) 26th June, 2010 Alice Birdwatching: a community built knowledge base for birdwatchers João Pedro Lago Master in Informatics and Computing Engineering Approved in oral examination by the committee: Chair: Jorge Manuel Gomes Barbosa (PhD) External Examiner: Rui João Peixoto José (PhD) Supervisor: Maria Teresa Galvão Dias (PhD) 31st July, 2010 Abstract Drawing on the reasons for the origins of the Internet, the web 2.0 phenomenon in the latter decade has enabled Internet users to become not only consumers but also producers of information, something that most of them didn’t let pass. The success of User Generated Content (UGC) sites like Wikipedia has inspired the expansion of the principle to other, more specific contexts. Similarly, there has been an explosion in the abilities of mobile devices, which have also started contributing to this content frenzy with different types of data, such as geographically referenced content. This document describes the conception and development a project, Alice Birdwatch- ing, that aims at creating an online community for content generation in the context of birdwatching. This application will allow birdwatcher to generate content about their fa- vorite hobby (sometimes taken very seriously) in an easy and comfortable way, such as it was not available on the web as of the writing of this paper. The application will also take advantage of mobile technologies, both to help generate content and to help bird watchers on the field, where a computer would be a liability. -

Image Munitions and the Continuation of War and Politics by Other Means
_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses Image warfare in the war on terror: Image munitions and the continuation of war and politics by other means. Roger, Nathan Philip How to cite: _________________________________________________________________________ Roger, Nathan Philip (2010) Image warfare in the war on terror: Image munitions and the continuation of war and politics by other means.. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42350 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation reference above.) http://www.swansea.ac.uk/library/researchsupport/ris-support/ Image warfare in the war on terror: Image munitions and the continuation of war and politics by other means Nathan Philip Roger Submitted to the University of Wales in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Swansea University 2010 ProQuest Number: 10798058 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. -

Money Ruins Everything John Quiggin
Hastings Communications and Entertainment Law Journal Volume 30 | Number 2 Article 1 1-1-2008 Money Ruins Everything John Quiggin Dan Hunter Follow this and additional works at: https://repository.uchastings.edu/ hastings_comm_ent_law_journal Part of the Communications Law Commons, Entertainment, Arts, and Sports Law Commons, and the Intellectual Property Law Commons Recommended Citation John Quiggin and Dan Hunter, Money Ruins Everything, 30 Hastings Comm. & Ent. L.J. 203 (2008). Available at: https://repository.uchastings.edu/hastings_comm_ent_law_journal/vol30/iss2/1 This Article is brought to you for free and open access by the Law Journals at UC Hastings Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Hastings Communications and Entertainment Law Journal by an authorized editor of UC Hastings Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. Money Ruins Everything by JOHN QUIGGIN AND DAN HUNTER* I. Introduction ........................................................................................ 204 II. The Evolution of Innovation .............................................................. 206 A. Amateur Collaborative Innovation in Content Production .......... 215 1. The Internet ........................................................................... 216 2. Open-Source Software .......................................................... 218 3. B log s ..................................................................................... 2 2 0 4. Citizen Journalism ................................................................