Il Programma Provinciale Di Previsione E Prevenzione Dei Rischi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“Basilicata 2012”
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA PROVINCIA DI POTENZA U.T.G. DI POTENZA Esercitazione Nazionale di Protezione Civile Rischio Sismico “Basilicata 2012” 14 - 15 Dicembre 2012 Schema di documento d’impianto a livello provinciale Provincia di Potenza Schema di impianto a livello provinciale: provincia di Potenza pag. 1/64 Esercitazione Nazionale “Basilicata 2012” INDICE PREMESSA 1. INQUADRAMENTO CONOSCITIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 1.1 GEOMORFOLOGIA 1.2 GEOLOGIA 1.3 IDROGEOLOGIA 1.4 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 1.5 ASSETTO DELLA POPOLAZIONE ED ASPETTI CARATTERISTICI 1.6 IL SISMTEMA INDUSTRIALE 1.7 SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI RILIEVO 1.8 IL SISTEMA SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE 1.9 LE STRUTTURE RICETTIVE 2. RETI DI COMUNICAZIONE 2.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DELLA RETE STRADALE 2.2 RETE FERROVIARIA 3. IL MODELLO DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO PROVINCIALE 4. TIPO D’ESERCITAZIONE 4.1 OBIETTIVI 4.2 LIVELLO COMUNALE 4.3 LIVELLO INTERCOMUNALE 4.4 LIVELLO PROVINCIALE 4.5 LIVELLO REGIONALE 5. EVENTO SISMICO 5.1 L’EVENTO DI RIFERIMENTO 5.2 L’EVENTO SIMULATO 6. I LIVELLI DI COMANDO E COORDINAMENTO 6.1 IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) 6.2 I CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) 6.3 I CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC) 6.4 SALA OPERATIVA REGIONALE (SOR) 7. PARTECIPANTI 8. SCENARI ESERCITATIVI DI EMERGENZA ATTIVATI 8.1 EVOLUZIONE DELLO SCENARIO DI DANNO 8.2 MONITORAGGIO 8.3 VULNERABIITA’ INFRASTRUTTURE 8.4 RISCHI INDOTTI 8.5 ACCESSIBILITA’ 8.6 CENTRI COORDINAMENTO ED AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 8.7. MODELLO DI INTERVENTO SANITA’ 8.8. CRISI DI ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI 8.9. TELECOMUNICAZIONI 8.10. LOGISTICA VOLONTARIATO 8.11 FORMAZIONE – DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 8.12 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 8.13. -
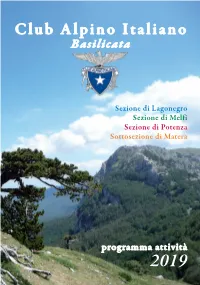
Programma 2019
Club Alpino Italiano Basilicata Sezione di Lagonegro Sezione di Melfi Sezione di Potenza Sottosezione di Matera programma attività 2019 il CAI in Basilicata contatti Gruppo Regionale Sede: c/o CAI Potenza, via Tirreno-fab. A. Del Favero 85100 Potenza - Tel. 320.4277910 [email protected], www.caibasilicata.com Sezione Lagonegro Sede: via Roma - 85042 Lagonegro (PZ) Tel. 339.7646529 [email protected] www.cailagonegro.com Sezione Melfi Sede: viale G. D’Annunzio, 35 - 85025 Melfi (PZ) Tel. 348.0822194 [email protected] www.caimelfi.it Sezione Potenza Sede: via Tirreno-fab. A. Del Favero - 85100 Potenza Tel. 349.4698287 [email protected] , [email protected] www.caipotenza.it Sottosezione di Matera Sede: vico Lombardi, 3 - 75100 Matera [email protected], [email protected] www.falconaumanni.it (in attesa del sito ufficiale CAI) i l C l u b A l p i n o I t a l i a n o Il Club Alpino Italiano è stato fondato nel 1863 da Quintino Sella con lo scopo di far conoscere le montagne e di agevolarvi le escursioni, le salite e le esplorazioni scientifiche. Finalità espresse nell’articolo 1 dello Statuto, tuttora il manifesto politico e culturale dei soci del CAI. Gli obiettivi fondamentali non sono cambiati, ma l’associazione è molto cresciuta sia nel numero dei soci sia nelle attività volte a vivere la montagna in tutti i suoi aspetti attraverso diverse modalità di approccio: alpinismo, escursionismo, sci di fondo-escursionismo, speleologia e altro. Per tali attività il CAI si avvale del supporto di figure tecniche altamente specializzate nei diversi settori e discipline: esperti e operatori naturalistici, osservatori glaciologici e di tutela montana, esperti di neve e valanghe, guide alpine, accompagnatori di escursionismo, esperti di sentieristica e soprattutto il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. -

Documento Preliminare Al Piano Strutturale Della Provincia Di Potenza Sezione 2
DOCUMENTO PRELIMINARE AL PIANO STRUTTURALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA SEZIONE 2: - IL QUADRO CONOSCITIVO: LO STATO DELL’ARTE Sezione2 - Il quadro conoscitivo: lo stato dell’arte 29 La SEZIONE 2 presenta la documentazione di base per la formazione del PSP, assunta attraverso studi ad hoc svolti dall’Unità di Ricerca del DAPIT, individua le procedure di massima ed i tempi per eventuali completamenti alla scala a maggior denominatore (1:100.000 o 50:000), nonché gli approfondimenti da sviluppare a scala più ravvicinata (1:10.000). A questo riguardo, si propone il coinvolgimento degli altri Enti che su queste proposte potranno esprimersi sia in sede di incontri di lavoro che in sede di Conferenza di Pianificazione. Questa sezione è articolata secondo settori di studio disciplinarmente distinguibili, riferiti alle indicazioni di cui all’articolo 13, c2, lett. a) della LR 23/99 e rappresenterà, unita alle maggiori articolazioni previste per la CRS, alla quale deve fare riferimento (cfr. articolo 2 della stessa legge), un primo contributo alla costruzione del quadro dello stato dell’arte sulle conoscenze del territorio provinciale. 1. L’ESAME DEI DOCUMENTI DELLA FASE CONOSCITIVA GIÀ ATTUATA DALL’AMMINISTRAZIONE. LA VERIFICA DELLA ADATTABILITÀ AL SIT E LA INTEGRAZIONE CON DATI A CURA DEL DAPIT. 1.1 Il riordino dei dati cartografici di base Riferimenti metodologici e fonti informative Il lavoro di ricerca relativo all’individuazione ed alla conoscenza della struttura del Sistema Naturalistico Ambientale provinciale ha avuto il suo punto di partenza nell’acquisizione dei dati esistenti in riferimento alle risorse ambientali, alla loro qualità e consistenza, ed alla loro individuazione sul territorio: − geometrici, numerici, disegni, diagrammi, modelli digitali del terreno, immagini fotografiche, fotorilevate; − dati statistici economici e demografici tutti aventi come caratteristica unificante il fattore spaziale, al fine di ottenere una conoscenza integrata e coerente del sistema oggetto di studio. -

Equiturismo in Basilicata Equiturismo in Basilicata 3 L’Equiturismo Come Risorsa
BasilicataSport&Natura BasilicataSport&Natura AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA POTENZA Via del Gallitello, 89 Tel. +39 0971 507611 [email protected] MATERA Via De Viti De Marco, 9 Tel. +39 0835 331983 [email protected] www.basilicataturistica.it www.aptbasilicata.it PUBBLICAZIONE GRATUITA Natura Equiturismo & Sport in Basilicata Basilicata 6 itinerari per vivere da protagonisti l’esperienza dell’equiturismo BASILICATA SPORT&NATURA BASILICATA SPORT&NATURA SOMMARIO L’EQUITURISMO COME RISORSA 5 VADEMECUM PER LA SICUREZZA A CAVALLO 10 GLI ITINERARI 13 ITINERARIO 1 - MELFI / MARATEA 14 ITINERARIO 2 - MELFI / VALLE DI VITALBA 36 ITINERARIO 3 - SAN FELE / MURO LUCANO / VALLE DI VITALBA 46 ITINERARIO 4 - BRINDISI DI MONTAGNA / LAURENZANA / BRINDISI DI MONTAGNA 60 ITINERARIO 5 - MATERA / POLLINO 68 ITINERARIO 6 - VENOSA / METAPONTO 78 UN VIAGGIO DA RACCONTARE 86 STRUTTURE RICETTIVE 98 2_EQUITURISMO IN BASILICATA EQUITURISMO IN BASILICATA_3 L’EQUITURISMO COME RISORSA 4_EQUITURISMO IN BASILICATA EQUITURISMO IN BASILICATA_5 BASILICATA SPORT&NATURA | L’EQUITURISMO COME RISORSA BASILICATA SPORT&NATURA | L’EQUITURISMO COME RISORSA on questa guida l’Agenzia di Promo- zione Territoriale ha inteso offrire, a quanti intendano fare un viaggio Ca cavallo in Basilicata, una serie di itinera- ri che presentino la vastità e la varietà del paesaggio della nostra regione che ben si presta ad essere conosciuta secondo la modalità dell’equiturismo. E’ un primo mo- mento di un percorso che è destinato nelle prossime edizioni ad arricchirsi sempre di più, viste le potenzialità del territorio e la tendenza sempre più diffusa tra i viaggia- tori e visitatori di un approccio autentico e diretto con la natura e con tutto ciò che è correlato ad essa. -

Schede Delle Aree* Di Reperimento
Schede delle aree* di reperimento *La Basilicata é stata suddivisa in ambiti territoriali coincidenti per la gran parte con le Comunità Montane. Atlante dei funghi commestibili della Basilicata OFANTO-VULTURE Il territorio che costituisce l’ambito “Ofanto-Vulture” degrada dalle giogaie del monte Carmine di Avigliano e del monte Pierno di San Fele (1.407 m s.l.m.) alla media valle dell’Ofanto di Lavello (106 m s.l.m.), attraverso le ampie valli della fiumara di Atella e dell’Arcidiaconata. Si estende su Km2 1.065,87 e comprende 14 centri abitati. SUPERFICIE ALTITUDINE SUPERFICIE TERRITORIALE m s.l.m. BOSCATA COMUNE Km2 Max Min ha A8tella 828,2 15.26 300 4.23 B4arile 204,6 914 219 28 G1inestra 193,2 865 344 33 L2avello 1032,9 367 150 74 M9aschito 445,4 899 325 3 M5elfi 2605,1 16.32 153 2.05 M0ontemilone 1013,4 402 175 97 R5apolla 279,0 912 109 32 R4apone 279,1 14.26 332 80 R9ionero 563,1 11.32 278 2.32 R2ipacandida 313,3 907 377 66 R9uvo del monte 362,1 840 370 65 S5an Fele 976,5 12.40 306 1.59 V4enosa 1369,3 871 187 83 Il territorio dell’ambito Ofanto-Vulture, oltre ad essere ricoperto dalla lussureg- giante foresta di Monticchio, è straordinariamente vario e suggestivo. Ora è “misti- co e guerriero” come quello testimoniato dal famoso santuario di Pierno a San – 55 – Osvaldo e Rosario Tagliavini Fele o dalla badia di San Michele a Monticchio e dai castelli di Melfi e di Venosa, ora è arcaico e dolce come quello ammantato di viti e d’ulivi che conferiscono al paesaggio un aspetto morbido e seducente. -

Basilicata Allegato3 Schede
1 Linea AT 4.3 Costruire e proporre un’immagine forte e unitaria del sistema Basilicata, in modo da accrescere la visibilità e la riconoscibilità della Regione – GLOBAL DESIGN- Allegato 3 “i contesti paesistici locali come immagini delle aree prodotto“ Schede Lucina Caravaggi Davide Paolini Cristina Imbroglini Collaboratori: Valentina Azzone 2 Premessa Il riconoscimento di “paesaggi”, intesi come immagini trainanti capaci di comunicare in forma sintetica spazi, forme del suolo, percezioni sensoriali, prodotti e tradizioni culturali, muove dalla identificazione dei “contesti paesistici locali”,ovvero di parti di territorio identificabili in base ad analoghi caratteri fisico-naturalistici, storico-culturali e produttivi, che procede parallelamente alla ricerca di storie e immaginari locali, fortemente connesse alle produzioni di nicchia relative ai prodotti eno-gastronomici. Nella identificazione dei contesti paesistici si è tenuto conto dell’immagine condivisa della Basilicata come territorio plurale, molteplice, difficilmente riconducibile ad un’immagine unitaria e omogenea e che tuttavia, proprio nella pluralità e nelle differenze, può trovare i suoi punti di forza e la sua riconoscibilità. In particolare la ricerca ha preso avvio dall’immagine della Basilicata proposta dai suoi amministratori, e particolarmente evidente nel Piano Turistico Regionale.1 Questa immagine contemporanea, fortemente propositiva e integrata si sintetizza nelle “Aree -Prodotto” definite come aggregazioni di risorse del territorio sulla base di elementi omogenei caratterizzanti i singoli comprensori e intese come elementi fondamentali della nuova metodologia di marketing turistico e territoriale. L’offerta turistica per “Area/ Prodotto” propone un prodotto turistico ben definito, distinguibile da altre offerte simili, contraddistinto dalle peculiarità dell’area, intorno al quale si costruisce una adeguata attività “promo-commerciale”, attraverso la concertazione fra soggetti pubblici e privati interessati e il rafforzamento dei “marchi d’Area/Prodotto”. -

CAPITOLO SECONDO Strutture Geo-Morfologiche E Organizzazione
CAPITOLO SECONDO STRUTTURE GEO-MORFOLOGICHE E ORGANIZZAZIONE DEL RETICOLO AMMINISTRATIVO DELLA BASILICATA II. 1. BASILICATA: UNa “regIONE RESIDUA”? Le caratteristiche geo-morfologiche della regione1, nella presente ricostruzione, sono mes- se a confronto con l’influenza esercitata dall’articolazione delle strutture agrarie sulla con- figurazione del mosaico comunale. Due distinti livelli di analisi per comprendere, sulla scorta dei lavori che hanno trattato il rapporto tra conformazioni geografico-fisiche del territorio e preesistenze storiche – legate in particolare alle forme della proprietà e all’uso del suolo – come anche in Basilicata l’interazione di tali fattori abbia influito e, in molti casi, plasmato la struttura del découpage comunale. Più volte, in passato, il dibattito relativo a questi aspetti ha teso a sottolineare come il territorio attuale della regione presenti al proprio interno una certa disomogeneità geo- morfologica (Tav. 1), tanto da indurre gli autori che si sono dedicati allo studio dell’area lucana (si vedano Algranati, 1929-B; Ranieri, 1972-B), ad interrogarsi sulla reale identifica- zione della Basilicata come regione geografica in senso pieno2. 1 La Basilicata, con un’estensione di circa 9994 Km2, costituisce insieme al Molise una delle più piccole re- gioni del Mezzogiorno continentale e conta una popolazione di poco inferiore ai 590.000 abitanti (rilevazioni demografiche Istat al dicembre 2011). 2 La letteratura geografica cui si fa riferimento assume il concetto di “regione naturale” nell’accezione in- dicata dallo stesso RANIERI, ossia quale unità geografica «individuata dalla uniformità d’insieme dei caratteri fisici del territorio, dalla quale deriva uniformità di condizioni di ambiente fisico, costituente la base su cui si impianta la vita umana» (1972-B, p. -

Book Impaginato 4C
p o r t f o l i o basileuspublishing - graphics - web - multimedia Basileus nasce nel dicembre del 1990 per iniziativa di un gruppo di profes- sionisti, giovanissimi come giovanissime erano le tecnologie che si apprestavano a proporre. Da allora Basileus è impegnata in una costante ricerca artistica e tecnologica per poter offrire ai propri clienti la comunicazione più innovativa, elegante ed efficace. Ogni settore della nostra attività utilizza hardware professionali e software specialistici sempre aggiornati. Attraverso l’uso delle più moderne tecnologie, dei più avanzati packages software e con quindici anni di esperienza sul mercato, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza. I servizi che Basileus eroga ad Aziende, Enti pubblici e utenza pri- vata riguardano tutti i principali settori dell’editoria e della comunicazione istituzionale, aziendaleb e pubblicitaria. Il più classico di questi settori è il DTP (DeskTop Publishing) che ha stravolto il mondo della grafica editoriale e di cui ci occupiamo quasi dal suo nascere. Una solida cultura scientifica ci permette inoltre di utilizzare al massimo i moderni sof- tware di fotoritocco consentondoci di accedere a sofisticate tecniche di image proces- sing e di image enhancement gestite, se necessario, anche con l’aiuto di tecnologie AI (Artificial Intelligence) per ottenere la massima qualità possibile sulle immagini sia illustrative o artistiche che scientifiche o diagnostiche. Un altro settore importante della nostra attività è l’editoria multimediale, uno stru- mento che permette di ottenere il massimo della spettacolarità integrando tra loro le nuove tecnologie della comunicazione. Progettiamo e realizziamo Cd Rom multimedia- li capaci di coinvolgere e appassionare grazie a interfacce intuitive e ad una interattività sempre accuratamente studiata. -

GE06/84 BR IFIC Nº 2754 Special Section
BR IFIC Nº 2754 Special Section GE06/84 Date : 01.10.2013 International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) Radiocommunication Bureau Date of limit for comments on Part A pursuant to §4.1.2.9 or §4.1.3.1 : 10.11.2013 Date of limit for comments on Part A pursuant to §4.1.4.9: 15.12.2013 Comments should be sent directly to the Administration originating the proposal and to the Bureau. Information included in the columns Column App. Description of columns number 4 1 -- BR identification number 2 B ITU symbol for the administration responsible for the submission 3 1a Assigned frequency 4 Frequency block/Channel number 5 Unique identification code given by the administration for the assignment/allotment (AdminRefId) 6 4b ITU symbol for the geographical area 7 Intent 8 4a Name of the location of the transmitting station/allotment Notice type GS1 – Digital sound (T-DAB) broadcasting assignment GS2 – Digital sound (T-DAB) broadcasting allotment 9 GT1 – Digital television (DVB-T) broadcasting assignment GT2 – Digital television (DVB-T) broadcasting allotment G02 - Analogue television broadcasting assignment 10 Plan entry code 11 Unique identification code for the associated allotment 12 Allotment reference network (RN1-RN6) 13 8BH Maximum effective radiated power of the horizontally polarized component in the horizontal plane (dBW) 14 8BV Maximum effective radiated power of the vertically polarized component in the horizontal plane (dBW) 15 ITU symbols of administrations considered to be affected ITU symbol designating the administration with which coordination has been successfully completed, as indicated by 16 the administration responsible for the submission.