Issn 2532-182X
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dubbelhelix! Tvivlen På Dna-Spiralen
Dubbelhelix! Tvivlen på dna-spiralen No2 2020 VIRUS Så har mänskligheten hanterat utbrott genom tiderna + Spritinitiativet Max IV accelererar Öppen publicering ANNONS Change is here ChemPubSoc Europe has transformed into Chemistry Europe. European Journal of Inorganic Chemistry European Journal of Organic Chemistry Front Cover: Farheen Fatima Khan, Abhishek Dutta Chowdhury, and Goutam Kumar Lahiri Bond Activations Assisted by Redox Active Ligand Scaffolds Front Cover: Place your cover credit here over a maximum of 3 lines Cover Feature: K. Tanaka et al. Rhodium-Catalyzed ortho-Bromination of O-Phenyl Carbamates Accelerated by a Secondary Amide-Pendant Cyclopentadienyl Ligand 01/2020 Our mission is Batteries & Supercaps ChemBioChem to evaluate, publish, disseminate and amplify the scientifi c excellence of Combining Chemistry and Biology chemistry researchers from around the globe in high-quality publications. ChemCatChem The European Society Journal for Catalysis We represent 16 European chemical societies and support their members ChemElectroChem at every stage of their careers as they strive to solve the challenges that impact humankind. We value integrity, openness, diversity, cooperation ChemistryOpen and freedom of thought. Chemistry—Methods New Approaches to Solving Problems in Chemistry Chemistry Europe ChemistrySelect ChemMedChem 16 chemical societies With 72 Fellows recognized for excellence in chemistry From 15 European countries ChemPhotoChem 14,000 million downloads Who co-own 16 scholarly in 2019 journals ChemPhysChem 9,800 articles published And represent over in 2019 ChemPlusChem 75,000 chemists A Multidisciplinary Journal Centering on Chemisty ChemSusChem www.chemistry-europe.org Chemistry–Sustainability–Energy–Materials ChemSystemsChem published in partnership with Advertorial_CE_AD 210x297_FINAL.indd 2 13.03.20 15:21 No 2 2020 InnehållIntro Signaler 6 Kemisveriges spritinitiativ 22 hjälper vården. -
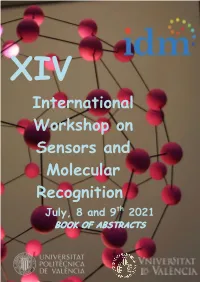
International Workshop on Sensors and Molecular Recognition, 2016
XIV International Workshop on Sensors and Molecular Recognition th July, 8 and 9 2021 BOOK OF ABSTRACTS ORGANIZING COMMITTEE CHAIR: Pablo Gaviña Costero Salvador Gil Grau Silvia Rodriguez Nuévalos María Manconi Daniel Ferri Angulo Carmen Ferriol Eva Mª Brun Sánchez SCIENTIFIC COMITTEE Ana Mª Costero Ramón Martínez-Mañez Angel Maquieira Catalá Miguel Alcañiz Fillol Rurack Knut Gustavo Fernandez Carla Caddeo Matilde Merino Sanjuan INDEX Page Scientific Program 7 Full Lectures 11 Oral Communications 21 Poster Communications 47 List of participants 147 SCIENTIFIC PROGRAM Thursday, July 8, 2021 MORNING SESSION 9.00 – 9.15h Opening ceremony Chaired by Vicerrector de Investigación de la Universitat de Valencia, Carlos Hermenegildo Caudevilla 9.15 – 10.15h Full Lecture Interfacing Self-Assembly and External Stimuli: from responsive to adaptive behaviour Gustavo Fernández 10.15 – 11.00h First Session of Oral Communications: Chairman: Ana María Costero Nieto O-01 Gold nanoclusters for ratiometric sensing of pH in extremely acidic media Irene Pérez-Herráez, Adele Bonanno, Elena Zaballos-García, Julia Pérez- Prieto O-02 Non-invasive and renal clearable cy7gal probe for the fluorescence senescence detection by direct urine measurement Juan F. Blandez, Beatriz Lozano-Torres, Alba García-Fernández, Félix Sancenón and Ramón Martínez-Máñez O-03 Host-guest chemistry of fullerene derivatives with polyamide macrocycle-based metal-organic frameworks Adrian Saura-Sanmartin, Alberto Martinez-Cuezva, Marta Marin-Luna, Jose Berna 11.00 – 11.30h Coffee break 11.30 – 12.30h Second Session of Oral Communications: Chairman: Salvador Gil Grau O-04 Molecular encapsulagion using molecular cages Vicente Martí-Centelles, Giovanni Montà González, Félix Sancenón, Ramón Martínez-Máñez O-05 An off-on fluorescent probe for the sensitive detection of Alanine Aminopeptidase (APN) in real urine samples Marcia Domínguez, Juan F. -
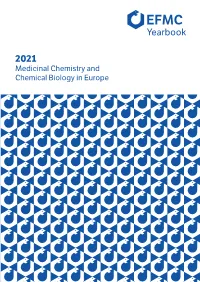
YEARBOOK 2021 | 1 Editorial
EFMC Yearbook 2021 Medicinal Chemistry and Chemical Biology in Europe EFMC-ISMC International Symposium on Medicinal Chemistry Virtual Event Aug. 29-Sept. 2, 2021 SESSIONS AND SESSION NEXT GENERATION DRUGS FOR HEART CONFIRMED PLENARY LECTURES COORDINATORS FAILURE Alleyn Plowright, Wren Therapeutics, UK Phil Baran, The Scripps Research Institute, US CHEMICAL BIOLOGY Karin Briner, Novartis, US RECENT ADVANCES IN ANTICANCER DRUG Jean-Paul Clozel, Idorsia, CH CARBOHYDRATE RECOGNITION AND DRUG DISCOVERY Stefan Knapp, Goethe University Frankfurt, DE DESIGN Roberto di Santo, Sapienza University of Rome, IT Alexander Titz, Helmholtz Institute for Pharmaceutical Sciences, DE TARGETING FIBROTIC DISEASES WITH SMALL MOLECULES EFMC AWARD LECTURES CHEMICAL APPROACHES TO STEM CELL Boehringer Ingelheim, DE DIFFERENTIATION (ICBS Session) THE NAUTA PHARMACOCHEMISTRY AWARD Colin Pouton, Monash University, AU TISSUE AND CELL SPECIFIC DRUG DELIVERY FOR MEDICINAL CHEMISTRY AND CHEMICAL (EUFEPS Session) BIOLOGY CHEMICAL PROBES FOR TARGET DISCOVERY Sébastien Papot, University of Poitiers, FR Ad P. Ijzerman, Leiden University, NL AND VALIDATION Gyorgy Keseru, Hungarian Academy of Sciences, HU TECHNOLOGIES IN MEDICINAL CHEMISTRY MOLECULAR IMAGING TOOLS FOR CHEMICAL Malin Lemurell, AstraZeneca, SE BIOLOGY APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Valle Palomo, CIB, ES IN DRUG DISCOVERY PROJECTS Christopher Swain, Cambridge MedChem AWARD FOR NEW TECHNOLOGIES IN DRUG PHOTOCHEMISTRY IN DRUG DISCOVERY: Consulting, UK DISCOVERY PHOTOPHARMACOLOGY, PHOTOTOXICITY Gisbert Schneider, ETH Zürich, CH AND SYNTHESIS (ACSMEDI Session) BIOCATALYSIS & LATE STAGE Timothy Henderson, MSD, US & Amjad Ali, MSD, US FUNCTIONALISATION Radka Snajdrova, Novartis, CH EFMC PARTNER PRIZES SMALL MOLECULES TARGETING RNA FUNCTION AND PROCESSING Maria Duca, University of Côte d'Azur, FR Jean-Paul Renaud, Urania Therapeutics, FR John E. Macor, Sanofi, US TARGET DECONVOLUTION STRATEGIES IN THE KLAUS GROHE AWARD DRUG DISCOVERY EXPANDING CHEMICAL SPACE THROUGH Stephan A. -

Download This Article PDF Format
Volume 50 Number 14 21 July 2021 Pages 7883–8346 Chem Soc Rev Chemical Society Reviews rsc.li/chem-soc-rev ISSN 0306-0012 REVIEW ARTICLE Uwe T. Bornscheuer et al . Recent trends in biocatalysis Chem Soc Rev View Article Online REVIEW ARTICLE View Journal | View Issue Recent trends in biocatalysis Cite this: Chem. Soc. Rev., 2021, Dong Yi, † Thomas Bayer, † Christoffel P. S. Badenhorst, † Shuke Wu, † 50, 8003 Mark Doerr, † Matthias Ho¨hne † and Uwe T. Bornscheuer * Biocatalysis has undergone revolutionary progress in the past century. Benefited by the integration of multidisciplinary technologies, natural enzymatic reactions are constantly being explored. Protein engineering gives birth to robust biocatalysts that are widely used in industrial production. These research achievements have gradually constructed a network containing natural enzymatic synthesis pathways and artificially designed enzymatic cascades. Nowadays, the development of artificial intelligence, automation, and ultra-high-throughput technology provides infinite possibilities for the Received 19th December 2020 discovery of novel enzymes, enzymatic mechanisms and enzymatic cascades, and gradually comple- DOI: 10.1039/d0cs01575j ments the lack of remaining key steps in the pathway design of enzymatic total synthesis. Therefore, the research of biocatalysis is gradually moving towards the era of novel technology integration, intelligent rsc.li/chem-soc-rev manufacturing and enzymatic total synthesis. Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence. Introduction a completely new research field: biocatalysis.1 Over the next hundred years, this research field had developed rapidly and More than a century ago, Rosenthaler synthesised (R)-mandelo- experienced three distinct waves,2 advancing from the use of nitrile from benzaldehyde and hydrogen cyanide using a plant crude extract to purified enzymes and then to recombinant extract containing a hydroxynitrile lyase and opened the door to enzyme systems. -

Irish Chemical News 2021 Issue 2
1 Irish Chemical News A Journal of the Institute of Chemistry of Ireland The Next big Challenge for Humanity – Carbon. Getting Alternatives - Hydrogen, Solar Energy, Wind Power, Li Batteries, Storing Electricity, Fuel Cells, Carbon Capture, Fusion Power, Bio-Fuels irishtimes.com Lim et al., Joule 4 1-10 (2020). urce: University of Illinois at Urbana-Champaign IRISH CHEMICAL NEWS ISSUE NO.2 MAY 2021 2 Ravensdale Road, Dublin D03 CY66. Web: www.instituteofchemistry.org Contents: Page A message from the President 6 Editorial 8 Chemistry in Europe 16 Institute of Chemistry of Ireland Annual Award Ceremony 2021 17 The Institute of Chemistry of Ireland’s Young Chemists’ Network 19 Message to President Michael D. Higgins on the Occasion of His 80th Birthday 22 Professor Dervilla M.X. Donnelly, ICI Honorary Fellowship 23 The Institute Honours Dr Raymond Leonard as he retires from Council 24 The International Mass Spectrometry School (IMSSc), Belfast, August 2021 26 Dr Mike Ryan awarded inaugural Cameron Award by RCSI Virtual Event 28 ICI Nominee appointed to Environmental Protection Agency advisory committee 29 The European Chemical Workshop Society “The Carbon Element” 30 EUROVARIETY 2021 on-line Conference 36 From Soap to Ice-cream: the Irish Seaweed Industry 18th – 21st Century. Dr Peter Childs 37 IBICS & ICI Lecture COVID – A Year Like No Other, Where Next? 64 ChemPubSoc Europe becomes Chemistry Europe 65 Irish University & 3rd Level Chemistry News & New TU Announcements 68 Chemistry and related Science around the World 80 Science Foundation Ireland Reports 114 SARS CoV-2 Virus Updates and Developments 135 Addenda 1-7 183 Industrial Development Authority IDA Reports 225 Enterprise Ireland 235 Silicon Republic 249 National Manufacturing & Supply Chain Conference & Exhibition 260 Manufacturing and Supply Chain Awards, 2020 263 New email for the Editor: [email protected] Note: Opinions expressed in this Journal are those of the authors and not necessarily those of the Institute. -

Open Access E-Journals on Chemistry
OPEN ACCESS E-JOURNALS ON CHEMISTRY ORGANIC CHEMISTRY: 1. Nuclear Receptor Research https://www.kenzpub.com/journals/nurr/toc/all/ 2. Journal of Medical Biochemistry https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=1452-8258&lang=en 3. Journal of Saudi Chemical Society https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-saudi-chemical-society/issues 4. Journal of the Brazilian Chemical Society http://jbcs.sbq.org.br/past_issues 5. Chemical Review & Letters http://www.chemrevlett.com/ 6. Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-nutrition-and-intermediary- metabolism/issues 7. Organic Materials https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/journal/10.1055/s-00040992 8. The Ukrainian Biochemical Journal http://ukrbiochemjournal.org/magarchive 9. International Journal of Tryptophan Research https://journals.sagepub.com/home/try 10. Journal of Lipids https://www.hindawi.com/journals/jl/contents/year/2021/ 11. Cogent Chemistry https://www.tandfonline.com/toc/oach20/current 12. Soils https://www.mdpi.com/journal/soils 13. Materials Science for Energy Technologies https://www.sciencedirect.com/journal/materials-science-for-energy- technologies/issues 14. BMB Reports http://www.bmbreports.org/journal/archives.html 15. Journal of Molecular Biochemistry http://www.jmolbiochem.com/index.php/JmolBiochem/issue/archive 16. Biosurface and Biotribology https://digital- library.theiet.org/content/journals/bsbt/6/4;jsessionid=3e74b83mpovio.x-iet-live-01 17. Pharmaceutical Fronts https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00043364 18. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures https://chalcogen.ro/index.php/journals/digest-journal-of-nanomaterials-and- biostructures?start=3 19. ARKIVOC https://www.arkat-usa.org/ 20. -

Renato Ugo, Di Rinaldo Psaro Pag
ISSNISSN 2532 2532-182X-182X Leggi La Chimica e l’Industria Scarica la app sul telefonino e sui tuoi dispositivi elettronici È gratuita! Disponibile per sistemi Android e iOS La Chimica e l’Industria Newsletter n. 1 - gennaio 2021 Attualità LE SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE NELLE LISTE DELL’ECHA. NOTA 2 - Alcuni PFAS: gli acidi perfluoroalchilici e perfluoroalchilsolfonici pag. 4 Ferruccio Trifirò QUALI ENERGIE PER L’INDUSTRIA E LA MOBILITÀ DI DOMANI pag. 10 Carlo Giavarini IL CONTRIBUTO DELLA IUPAC NEL REALIZZARE I GOAL DELL’ONU pag. 15 Paolo Zanirato Chimica & Ambiente ULTRAFILTRAZIONE E REFORMING DI ACQUE DI VEGETAZIONE pag. 27 Andrea Cianfanelli, Luca Farina, Lorenzo Bartolucci, Vincenzo Mulone, Stefano Cordiner, Silvano Tosti Ambiente Luigi Campanella pag. 28 In ricordo di Pietro Greco, di Marco Taddia pag. 30 Renato Ugo, di Rinaldo Psaro pag. 31 Sir John Meurig Thomas, di Salvatore Coluccia pag. 34 Pagine di Storia CELSO PELLIZZARI E I PRIMI MILLIGRAMMI DI RADIO IN TOSCANA pag. 36 Marco Fontani, Mariagrazia Costa, Mary Virginia Orna Recensioni L’INFINITA SCIENZA DI LEOPARDI pag. 46 Marco Taddia Notizie da Federchimica pag. 48 Pills&News pag. 52 La Chimica e l’Industria - ISSN 2532-182X - 2021, 8(1), gennaio 3 Attualità LE SOSTANZE CHIMICHE TOSSICHE NELLE LISTE DELL’ECHA. Nota 2 - Alcuni PFAS: gli acidi perfluoroalchilici e perfluoroalchilsolfonici Ferruccio Trifirò Diverse sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) hanno delle restrizioni nel loro uso in Europa, essendo presenti nelle liste delle sostanze sotto controllo da parte dell’ECHA, nell’ambito della direttiva Reach. In questa nota è riportato quello cha sarà il futuro degli acidi perfluoroalchilici da C2 a C16 atomi di carbonio, degli acidi perfluoroalchilsolfonici da C4 a C8 atomi di carbonio e di due acidi perfluoroalchilici complessi. -

Curriculum Vitae
1 CURRICULUM VITAE ARMANDO J.L. POMBEIRO 2 CONTENTS CURRICULUM VITAE (ABRIDGED) .................................................................................................................. 3 PERSONAL DATA ........................................................................................................................................... 6 HONOURS, APOINTMENTS, MEMBERSHIP, COMMISSIONS, ETC. .................................................................. 6 SCIENTIFIC AND CULTURAL SOCIETIES (MEMBERSHIP)................................................................................................. 6 AT THE ACADEMY OF SCIENCES OF LISBON AND RELATED ORGANIZATIONS .................................................................... 7 AT THE COLLEGE OF CHEMISTRY OF THE UNIVERSITY OF LISBON ................................................................................. 11 AT THE INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO ................................................................................................................... 12 AT THE CENTRO DE QUÍMICA ESTRUTURAL ............................................................................................................. 13 AT THE PORTUGUESE ELECTROCHEMICAL SOCIETY (AND AKIN SOCIETIES) ..................................................................... 14 AT CONGRESSES ................................................................................................................................................. 15 EVALUATION ACTIVITIES AND COMMISSIONS ......................................................................................................... -

SCS Annual Report 2020
A142 CHIMIA 2021, 75, No. 1/2 ANNUAL REPORT ANNUAL REPORT 2020 • Develop and promote the two social networks Women in Chemistry and youngSCS, which reinforce and enrich our strong thematic communities. Published in CHIMIA Volume 75, No 1-2/2021 • Develop the new SCS webpage including the portals for our thematic and social communities as well as a new website Introduction and Summary template for the efficient handling of our numerous events. With pleasure we look back on a very interesting and Furthermore, we stayed actively connected to our partners active year. The Swiss Chemical Society not only continued and co-operated in many projects. Please enjoy reading through and developed its well-established activities but again pushed the 2020 annual report that shows again a very active and lively new initiatives to face today’s challenges. We also implemented society. new sections and networks to incorporate community members whose interests had not been covered so far. In addition, the Dr. Alain De Mesmaeker David Spichiger SCS took over the responsibility for existing programs that now President Executive Director run under the umbrella of the SCS and complete our activity portfolio. 2020 was one of the most difficult and challenging years that we have lived through at the personal and professional level and the outbreak of the global Covid-19 pandemic restricted our life in ways we could never have imagined. From March 2020, meetings with larger groups were prohibited and collaboration was therefore limited to virtual meetings. Many of our events had to be cancelled, postponed or conducted virtually and it seems that this situation will continue at least until summer 2021.