Regione Veneto Comune Di Malo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Resisui Passivi 2018
COMUNE DI CREAZZO ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL’ANNO 2018 GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL’ANNO 2018 Pag. 2 ( Data di stampa 26-03-2019 ) Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio Impegnato a residui 10 10 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI 010110302010 10.295,60 COMUNALI 01 Num. Data T. Causale dell’Operazione Atto T. Data RESIDUO 127 09-02-18 ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACO ED AGLI ASSESSORI ANNO 2018. 65 DT 09-02-18 5.298,86 TOTALE RESIDUI ANNO 2018 5.298,86 TOTALE CAPITOLO 5.298,86 Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio Impegnato a residui 10 20 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO 010110302010 939,53 COM.LE 01 Num. Data T. Causale dell’Operazione Atto T. Data RESIDUO 167 16-02-18 ASSUNZIONE SPESA PER EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018 63 DT 09-02-18 1.020,39 TOTALE RESIDUI ANNO 2018 1.020,39 TOTALE CAPITOLO 1.020,39 Capitolo Artic. Descrizione Cod.Bilancio Impegnato a residui 90 2 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI 010110302010 22.000,00 AMMINISTRATORI 02 Num. Data T. Causale dell’Operazione Atto T. Data RESIDUO 1005 31-12-18 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO 814 DT 24-12-18 22.000,00 TOTALE RESIDUI ANNO 2018 22.000,00 TOTALE CAPITOLO 22.000,00 Capitolo Artic. -

Via Degli Alpini, 49 · SOVIZZO Giocattoli
Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. 1010 del 23.10.2001. Direttore Responsabile Federico Ballardin. Stampato in proprio. • A CURA DI PAOLO FONGARO • n. 151 · 03.10.2009 A.F.V.P.F.S.C.D. Torniamo al tradizionale formato. Tanti di voi hanno apprezzato lo scorso numero tutto colo- IN FONDO A VIA VERDI… rato: anche a noi piacerebbe presentarvi ogni È la strada dove son nato e cresciuto, dove ho imparato a correre ed andare in bicicletta. Una lingua uscita imbandita con una veste grafica così d’asfalto e di cancelli, dove ogni tombino e campanello è familiare, ogni portone equamente preso accattivante, ma per motivi tecnici e soprattutto a pallonate, il nome, la voce e le sembianze di tutti impressi ed incancellabili in dolci ricordi che costi di stampa decisamente più alti rimaniamo profumano di irripetibile spensieratezza. Parenti ed amici mi segnalano due splendide ricorrenze, per ora con le foto in bianco e nero. Scrivo "per divise solo da un giorno e una cinquantina di metri: il 19 ed il 20 settembre di cinquant’anni fa si ora": la Provvidenza non ha limiti e chissà che in scambiavano il rituale “Sì” rispettivamente Norma con Bepi Paganin e Marcella con Bepi Frizzo. futuro, grazie a qualche sponsor particolarmente La felice tappa delle loro nozze d’oro è stata festeggiata ovviamente dalle due generazioni germo- generoso, la quadricromia del celebrativo nume- gliate dal matrimonio: in casa Paganin hanno brindato le figlie Lorella con Mario e Giuliana con ro 150 non diventi il nostro standard! Salvatore, insieme ai nipoti Matteo, Alessia, Michele e Deborah, mentre dal versante Frizzo hanno Siamo a tutti gli effetti in autunno: le giornate fatto festa i figli Mauro con Edi, Loris con Elisa, Lorena con Stefano, Diego con Monica, nonché i sono ancora più che gradevoli, ma l’ormai con- nipoti Alessandro, Enrico, Nicola, Claudia, David e Matteo. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2020
Ufficio del territorio di VICENZA Data: 02/11/2020 Ora: 15.36.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. del n. del REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 ALTOPIANO DI ASIAGO ALTO ASTICO OCCIDENTALE E ALTO AGNO Comuni di: ASIAGO, ENEGO, FOZA, GALLIO, ROANA, ROTZO Comuni di: ALTISSIMO, ARSIERO, CRESPADORO, TONEZZA DEL CIMONE, LAGHI, LASTEBASSE, POSINA, RECOARO TERME, SCHIO (P), TORREBELVICINO, VALDAGNO, VALLI DEL PASUBIO, VELO D`ASTICO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 13100,00 SI 1-(1) I TERRENI VANNO 13100,00 SI SI 1-(1) I TERRENI VANNO DIMUNUITI DEL 5% IN DIMUNUITI DEL 5% IN COLLINA E DEL 20% IN COLLINA E DEL 20% IN MOTAGNA.) MOTAGNA.) 14-(1)I VALORI VANNO 14-(1)I VALORI VANNO DIMINUITI DEL 5% PER ZONA DIMINUITI DEL 5% PER ZONA COLLINARE (TRA 301 A 700 M COLLINARE (TRA 301 A 700 M S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE MONTANE (SUPERIORE A 700 MONTANE (SUPERIORE A 700 M S.L.M.) CON RIFERIMENTO M S.L.M.) CON RIFERIMENTO PUNTO PIÙ BASSO DEL PUNTO PIÙ BASSO DEL TERRENO.) TERRENO.) BOSCO D`ALTO FUSTO 14100,00 SI SI 1-(1) I TERRENI VANNO 14100,00 1-(1) I TERRENI VANNO DIMUNUITI DEL 5% IN DIMUNUITI DEL 5% IN COLLINA E DEL 20% IN COLLINA E DEL 20% IN MOTAGNA.) MOTAGNA.) 14-(1)I VALORI VANNO 14-(1)I VALORI VANNO DIMINUITI DEL 5% PER ZONA DIMINUITI DEL 5% PER ZONA COLLINARE (TRA 301 A 700 M COLLINARE (TRA 301 A 700 M S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE S.L.M.) E DEL 20% PER ZONE MONTANE (SUPERIORE A 700 MONTANE (SUPERIORE A 700 M S.L.M.) CON RIFERIMENTO M S.L.M.) CON RIFERIMENTO PUNTO PIÙ BASSO DEL PUNTO PIÙ BASSO DEL TERRENO.) TERRENO.) Pagina: 1 di 56 Ufficio del territorio di VICENZA Data: 02/11/2020 Ora: 15.36.29 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2020 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n. -
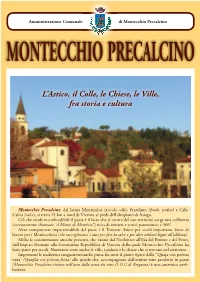
Montecchio Precalcino MONTECCHIO PRECALCINO
Amministrazione Comunale di Montecchio Precalcino MONTECCHIO PRECALCINO L’Astico, il Colle, le Chiese, le Ville, fra storia e cultura Montecchio Precalcino, dal latino Monticulus (piccolo colle), Praedium (fondo, podere) e Calx- Calcis (calce), si trova 15 km a nord di Vicenza ai piedi dell’altopiano di Asiago. Ciò che rende inconfondibile il paese è il fatto che al centro del suo territorio sorge una collinetta (comunemente chiamata “el Monte de Montècio”) ricca di sentieri e scorci panoramici a 360°. Altro componente imprescindibile del paese è il Torrente Astico per secoli importante fonte di lavoro per i Montecchiesi (che raccoglievano i sassi per fare la calce e per altri utilizzi legati all’edilizia). Molte le testimonianze antiche presenti, che vanno dal Neoloitico all’Età del Bronzo e del Ferro, dall’Impero Romano alla Serenissima Repubblica di Venezia della quale Montecchio Precalcino ha fatto parte per secoli. Numerose sono anche le ville, i palazzi e le chiese che si trovano nel territorio. Importanti le tradizioni enogastronomiche prina fra tutte il piatto tipico della “Quaja con poènta onta” (Quaglia con polenta fritta) allo spiedo che, accompagnato dall’ottimo vino prodotto in paese (Montecchio Precalcino rientra nell’area della zona dei vini D.O.C.di Breganze) è una autentica preli- batezza. Villa Da Schio - Cita: del XVII e XVIII secolo fu donata al Comune di Montecchio Precalcino nel 1978 dalla signora Marianna Cita Cabianca. Posta in splendida posizione sul lato orientale della collina ospita varie associazioni ed è sede di numerose manifestazioni ricreative e culturali. Villa Nievo Bonin Longare: già dei conti Nievo, poi Nievo Bonin Longare ed attualmente di pro- prietà dell’Ulss 4 Alto Vicentino. -

1. World Heritage Property Data
Periodic Report - Second Cycle Section II-City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto 1. World Heritage Property Data Villa Forni Cerato, 45.653 / 11.561 2.23 0 2.23 1996 Montecchio Precalcino , 1.1 - Name of World Heritage Property Province of Vicenza , Veneto City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto Region , Italy Comment Villa Godi 45.746 / 11.529 4.66 0 4.66 1996 Committee Decision 20COM VIIC: The name of the property Malinverni, Lonedo di Lugo was changed to “The City of Vicenza and the Palladian Villas Vicentino , of the Veneto” . (Note: "The") Province of Vicenza , Veneto Region , Italy 1.2 - World Heritage Property Details Villa Pisani Ferri, 45.359 / 11.369 1.6 0 1.6 1996 State(s) Party(ies) Bagnolo di Lonigo , Province Italy of Vicenza , Veneto Region , Type of Property Italy cultural Villa Pojana, 45.282 / 11.501 6.14 0 6.14 1996 Identification Number Poiana Maggiore , 712bis Province of Vicenza , Veneto Year of inscription on the World Heritage List Region , Italy 1994, 1996 Villa Saraceno, 45.311 / 11.587 0.59 0 0.59 1996 Agugliaro , Province of 1.3 - Geographic Information Table Vicenza , Veneto Name Coordinates Property Buffer Total Inscription Region , Italy (latitude/longitude) (ha) zone (ha) year Villa Thiene, 45.573 / 11.63 0.38 0 0.38 1996 (ha) Quinto Vicentino , 0 / 0 ? ? ? Province of Vicenza , Veneto 0 / 0 ? ? ? Region , Italy City of Vicenza 45.549 / 11.549 218 0 218 1994 Villa Trissino, 45.428 / 11.414 3.78 0 3.78 1996 (including 23 Sarego , Province buildings of Vicenza , constructed -

Camminando Per Monte Pian E Vallugana
Camminando per Monte Pian e Vallugana 8 Santuario di S. Libera (foto di L. Grotto) Croce sul monte Còrnolo, sullo sfondo il paese di Malo (foto di L. Grotto) Camminando per Monte Pian e Vallugana Comune di Malo La Convenzione Europea del Paesaggio, siglata a Firenze il 20 Ottobre 2000 definisce il paesaggio “una determinata parte di ter- ritorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interre- lazioni”. Da questa definizione emergono due concetti fondamen- tali: l’evoluzione del paesaggio per effetto di forze naturali ed an- tropiche e l’importanza della sua percezione da parte dell’uomo. Per cui il paesaggio forma un insieme unico, in cui convivono e- lementi naturali e culturali, che vanno considerati simultaneamen- te. Con l’avanzare dell’urbanizzazione verso le campagne, diventa sempre più rilevante la protezione e gestione del paesaggio, non più inteso come scenografia dei vari momenti della vita, ma come bene primario in cui l’uomo si inserisce, e per questo motivo da tutelare. Ecco allora che la creazione di una rete sentieristica può essere una possibile modalità di protezione, gestione e protezio- ne del paesaggio, e di conseguenza del territorio. Inoltre, il recupero e la manutenzione della rete sentieristica 9 possono anche garantire, allo stesso tempo, una corretta e conti- nua gestione e manutenzione del territorio, assicurandone un monitoraggio continuo. A partire da tali considerazioni, l’Amministrazione Comunale di Malo ha deciso di studiare il territorio di Monte Pian e Vallugana e riabilitarli dal punto di vista della funzione ricreativa. -

Curriculum Vitae Del Segretario Comunale
CURRICULUM VITAE DEL SEGRETARIO COMUNALE INFORMAZIONI PERSONALI Cognome Emanuele Nome Gaetano Luogo e data di nascita Catania – 26 gennaio 1959 Qualifica Segretario comunale Amministrazione Comune di Villaverla (VI) Numero telefonico ufficio 0445 355520 Fax ufficio 0445 355599 E mail istituzionale [email protected] TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE Titolo di studio Laurea giurisprudenza Altri titoli di studio e Abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato professionali Esperienze professionali Il 15 Aprile 1991 ha iniziato la carriera di Segretario comunale (incarichi ricoperti) presso la Segreteria convenzionata di Lastebasse – Pedemonte (VI) ove ha lavorato fino al 28 febbraio 1993. In qualità di Segretario del Comune di Pedemonte è stato nominato contestualmente anche Segretario dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Casotto. Dal 01 Marzo 1993 e fino al Settembre 1996 è stato nominato titolare della sede di Caltrano (VI), mentre, dal Settembre 1996 al Settembre 1998, ha assunto la titolarità della sede di Quinto Vicentino. Dopo un periodo di lavoro presso la sede convenzionata Quinto Vicentino – Sarcedo svolto tra l’Ottobre 1998 ed il Settembre 1999, ha mantenuto la titolarità della sola sede di Sarcedo fino all’Aprile 2002. Dall’Aprile 2002 al 31.12.2006, detta sede è stata convenzionata con il Comune di Montecchio Precalcino e classificata, con decorrenza Febbraio 2005, in 2^ classe in quanto il totale degli abitanti oltrepassava il limite dei 10.000. Nello stesso periodo, in entrambi gli enti di Sarcedo e Montecchio Precalcino è stato nominato Direttore Generale ed ha svolto le funzioni di Nucleo di valutazione. -

Sovizzo Post 91.Indd
ti: la band “Le Memorie” con il suo rock anni ’70 ed APERTURA ISCRIZIONI AL Herman Medrano, rapper che si sta facendo apprezzare TRE SERATE DI DANZA TRASPORTO SCOLASTICO con i suoi testi taglienti in veneto, giungendo alla In occasione del decen- Dal 22 al 31 maggio 2006 sono aperte le iscrizioni per ribalta nazionale con l’esibizione nel programma di RAI nale l’Associazione Etra il servizio del Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2 “CD LIVE” nel settembre 2005. In tutte e tre le serate Danza di Montecchio 2006-2007. Il servizio interessa la scuola primaria “D. sarà presente stand gastronomico con panini caldi, hot Maggiore (diretta da Chiesa” e la scuola secondaria di primo grado “A. Moro” dog, bibite e birra in botte e tanto buon vino. Il tutto Berta Ghiotto, Francesca dell’Istituto Comprensivo Statale di Sovizzo. Per le iscri- si svolgerà nella nuova cornice creata presso la piastra Bolzon e Michela zioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del comune polivalente, nell’area sportiva dietro il Palazzetto dello Negro), con il patroci- di Sovizzo che, dal 22 maggio al 31 maggio , sarà aperto Sport. nio del Comune, orga- nei seguenti orari: al mattino dalle 8.30 alle ore 12.30 e La Pro Loco Sovizzo nizza una “tre giorni” il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per dedicata alla danza nel informazioni è possibile telefonare allo 0444/376150. prestigioso palco del Cordiali saluti Castello di Romeo (già U.R.P. Comune di Sovizzo sede di OperaEstate Festival). Si inizia saba- to 3 giugno alle 21.30 Iscrizione al Tribunale di Vicenza n. -

Vicenza, Italia Settentrionale) (Decapoda, Stomatopoda, Isopoda)
CCITTÀITTÀ DDII MMONTECCHIOONTECCHIO MAGGIOREMAGGIORE MMUSEOUSEO DDII AARCHEOLOGIARCHEOLOGIA E SCIENZESCIENZE NNATURALIATURALI ““G.G. ZZANNATO”ANNATO” CLLAUDIOAUDIO BEESCHINSCHIN, ANNTONIOTONIO DE ANNGELIGELI, ANNDREADREA CHHECCHIECCHI, GIIANNINOANNINO ZAARANTONELLORANTONELLO CCROSTACEIROSTACEI DELDEL GGIACIMENTOIACIMENTO EEOCENICOOCENICO DDII GGROLAROLA PPRESSORESSO SSPAGNAGOPAGNAGO DDII CORNEDOCORNEDO VICENTINOVICENTINO ((VICENZA,VICENZA, ITALIAITALIA SETTENTRIONALE)SETTENTRIONALE) ((DECAPODA,DECAPODA, STOMATOPODA,STOMATOPODA, ISOPODA)ISOPODA) MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) 2012 Iniziativa realizzata con il contributo della Regione del Veneto Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” Sistema Museale Agno-Chiampo Città di Montecchio Maggiore Associazione Amici del Museo Zannato Montecchio Maggiore Copyright © Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” Piazza Marconi, 15 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Tel.-Fax 0444 492565 E-mail: [email protected] ISBN 978-88-900625-2-0 Casa editrice Cooperativa Tipografica Operai - Vicenza Le riproduzioni dei beni di proprietà dello Stato Italiano sono state realizzate su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; è vietata l’ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo. In copertina: disegni di A. De Angeli ©. Claudio BesChin, antonio de angeli, andrea CheCChi, giannino Zarantonello CROSTACEI DEL GIACIMENTO EOCENICO DI GROLA PRESSO SPAGNAGO DI CORNEDO VICENTINO (VICENZA, ITALIA SETTENTRIONALE) (DECAPODA, STOMATOPODA, ISOPODA) -

Prefettura Di Vicenza Ufficio Territoriale Del Governo
Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo PROTOCOLLO D’INTESA INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO tra La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e La Provincia di Vicenza I Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arzignano, Caldogno, Cassola, Cornedo Vicentino, Creazzo, Chiampo, Dueville, Marostica, Lonigo, Montecchio Maggiore, Romano d’Ezzelino, Rosà, Schio, Thiene,Torri di Quartesolo e Valdagno, Gli Enti territoriali, Associazioni provinciali di categoria e Confederazioni Sindacali Provinciali firmatari del presente documento: ♦ Direzione Provinciale del Lavoro ♦ I.N.P.S. ♦ I.N.A.I.L. ♦ U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa ♦ U.L.S.S. n. 4 di Thiene ♦ U.L.S.S. n. 5 di Arzignano ♦ U.L.S.S. n. 6 di Vicenza ♦ Associazione Industriali ♦ Apindustria ♦ Associazione Artigiani ♦ C.N.A. ♦ Confagricoltura ♦ Coltivatori Diretti ♦ Confcommercio ♦ Confesercenti ♦ Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza ♦ CGIL ♦ CISL ♦ UIL ♦ Ordine degli Ingegneri ♦ Ordine degli Architetti ♦ Collegio dei Geometri ♦ Collegio dei Periti Industriali Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo PREMESSO CHE - dalla Relazione finale elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, istituita in data 23 marzo 2005 dal Senato della Repubblica, è stato posto l'accento sulla necessità di potenziare il coordinamento, a livello locale, di tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza ed al controllo in materia di sicurezza; - la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ha disposto, ai sensi dell’art. -

Via Dalmazia N°45 Tavernelle (Fraz. Di Sovizzo) Vicenza Mappa Per Sede
Mappa per sede Associazione Insieme in Musica e Accademia Musicale Butterfly Via Dalmazia n°45 Tavernelle (fraz. di Sovizzo) Vicenza Lonigo Autostrada A4 Casello Montecchio Maggiore Altavilla V Stazione Tavernelle BEST WESTERN ic. Tavernelle Vicenza Hotel Tre Torri (Frazione di Sovizzo) Verona ss11 Rotatoria con cavallo via Dante viale degli Ippocastani viale dei Rododendri Alighieri viale dei Se avete il navigatore questa via Itinerario n°1 - Casello Autostradale di Montecchio Maggiore è la più vicina memorizzata. All’uscita del casello tenete la destra e seguite per il centro o vicenza. T igli Al semaforo andate dritti fino ad arrivare alla rotatoria con una testa di cavallo nel centro e li girate a destra immettendovi nella Ss11. Proseguite dritto, superate 2 semafori, una rotatoria con l’Ipermercato Tosano sulla destra, un’altro semaforo e al semaforo successivo con un viale dei Platani distributore Agip sulla sinistra girate a sinistra in via Dante Alighieri. viale dei Mandorli viale degli Procedete dritti per 1km più o meno e girate a sinistra in viale dei platani. Incrocio con via Martiri delle Foibe lampeggiante Procedete dritti fino ad un incrocio PERICOLOSO con un lampeggiante sospeso. sospeso Superate l’incrocio andando dritti e svoltate a destra in via Martiri delle Foibe. Poi svoltate alla prima a sinistra, via Istria e alla prima a destra via Dalmazia. Abeti La casa sullo sfondo che vi appare è la mia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Itinerario n°2 - Per chi arriva da Vicenza o limitrofi Seguire la Ss11 fino all’altezza del BEST WESTERN Hotel Tre Torri. via Istria Superare i 2 semafori e girare per il centro in via Dante Alighieri. -

Sistema Informativo Scolastico -2011/2012
S i s t e m a I n f o r m a t i v o S c o l a s t i c o P r o v i n c i a d i V i c e n z a Sistema informativo scolastico -2011/2012- SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI STATALI Pagina 1 di 81 Istituti professionali Istituto Prof. per l'Industria e l'Artigianato (Codice VIRI00601T) IPSIA Lobbia Via Cinque, 2 ASIAGO Dirigente Paiola Alfredo Anno Classe Classe Classe Classe Classe Totale Alunni scolastico 1 2 3 4 5 alunni stranieri 2004/05 92 88 57 39 63 339 18 2005/06 101 92 61 55 42 351 17 2006/07 93 100 70 49 50 362 18 2007/08 90 87 82 60 47 366 22 2008/09 89 79 77 67 52 364 25 2009/10 94 83 76 59 65 377 21 2010/11 80 76 76 61 54 347 22 2011/12 67 66 74 70 54 331 17 Comuni di residenza degli alunni - A.s. 2011/12 ARSIERO 2 Fuori regione 3 ARZIGNANO 1 Totale 331 ASIAGO 93 BASSANO DEL GRAPPA 8 CALTRANO 2 CARRE' 4 CASSOLA 1 CHIUPPANO 1 COGOLLO DEL CENGIO 5 CONCO 18 CREAZZO 1 ENEGO 10 FARA VICENTINO 2 FOZA 12 GALLIO 24 ISOLA VICENTINA 1 LUGO DI VICENZA 5 LUSIANA 10 MALO 1 MARANO VICENTINO 2 MAROSTICA 24 MASON VICENTINO 2 MOLVENA 3 NANTO 1 PIANEZZE 1 PIOVENE-ROCCHETTE 2 ROANA 66 ROMANO D'EZZELINO 1 ROTZO 6 SALCEDO 4 SANTORSO 1 SARCEDO 2 SCHIAVON 1 TEZZE SUL BRENTA 2 THIENE 5 VELO D'ASTICO 1 ZUGLIANO 2 Provincia di Venezia 1 Pagina 2 di 81 Istituto Prof.